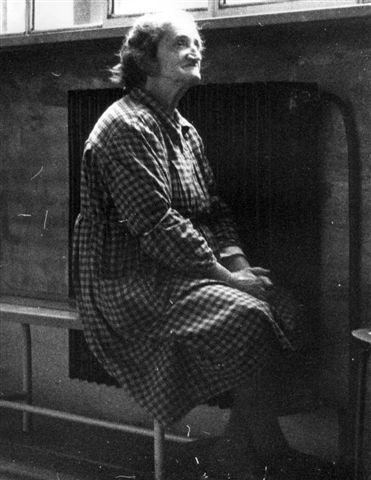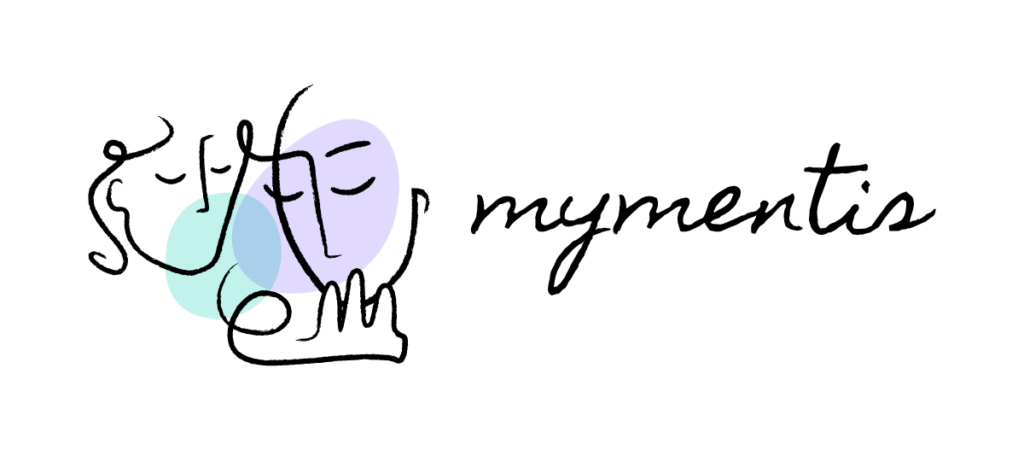Manicomio ultimo atto, dunque?
É assai lodato l’atto del ragazzo spartano – che si nascose il lupo sotto il mantello – lasciandosi divorare, senza lamentarsi. – É più coraggioso, io penso, strapparsi il lupo dal corpo – e lottare con lui all’aperto magari per strada – tra polvere e ululi di dolore. La lingua è magari un membro indisciplinato – ma il silenzio avvelena l’anima. Edgar Lee Masters
Lo stesso enunciato nasconde un’ambiguità che riflette l’incertezza perenne della questione, ed il rischio che su di essa cali la spessa coltre del silenzio. Benedetto Saraceno in merito alla chiusura degli ospedali psichiatrici ha parlato esplicitamente di un fintissimo ultimo atto[7]. Sul piano legislativo e nelle pratiche, infatti, si sono evidenziati numerosi equivoci e comportamenti contraddittorii. Innanzitutto, va ricordato il ruolo centrale assunto dai dispositivi di legge dalla finalità sostanzialmente finanziaria nel dare l’impulso alla definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici, prima dei progetti-obiettivo e delle linee guida di matrice socio-sanitaria sulla tutela della salute mentale, tanto per la popolazione residente nei manicomi in chiusura, quanto per l’utenza dei nuovi dipartimenti di salute mentale. Queste linee guida assegnavano ampio risalto all’indicazione di affrontare il disagio ed i disturbi psichici nella loro complessità, rifuggendo da ogni riduttivismo attraverso un’approfondita considerazione della storia personale, della storia della malattia, della disabilità attuale, delle possibilità concrete di recupero, delle risorse personali e familiari nonché dei servizi territoriali ed istituzionali nell’elaborazione dei programmi riabilitativi. Inoltre, esse raccomandavano di evitare, nella chiusura dei manicomi, sia gli interventi che in passato hanno determinato dimissioni definite selvagge sia trasformazioni che non cambiano nella sostanza la realtà istituzionale. Sembrò, quindi, che la scomparsa dei manicomi rappresentasse la fine, per chiunque possa andare incontro a subire la sofferenza mentale, dell’emarginazione sociale, dell’isolamento istituzionale assunto a paradigma scientifico ed etico dell’intervento psichiatrico. Nei fatti, la chiusura dei singoli ex manicomi ha rappresentato, in molti casi, una rapida soluzione che corrispondeva soprattutto ai bisogni degli amministratori locali delle neonate aziende sanitarie, spinti dalla necessità di chiudere in fretta la partita a fronte della minaccia di subire pesanti sanzioni pecuniarie, e sorretti dalla stessa legislazione che individuava in strutture residenziali ad alto livello di protezione le sedi idonee per il trasferimento dei malati. In molti luoghi, è così accaduto che la dimissione dei ricoverati non sia avvenuta attraverso la faticosa elaborazione di un programma individuale di recupero, bensì mediante un frettoloso trasferimento, spesso forzato, dal vecchio e fatiscente padiglione a locali ristrutturati, oppure in direzione di più lontane Case di Riposo, Case Protette e quante altre denominazioni assumono oggi, nella nostra società post – industriale, le strutture residenziali della nuova segregazione degli individui improduttivi. Altrove, si è semplicemente cambiata denominazione ai vecchi reparti, trasformati in “residenze sanitarie assistite”. Intendiamo sottolineare il fatto che non vi è stata, spesso, una adeguata cura di componenti fondamentali del programma riabilitativo: e non ci riferiamo soltanto alla spinosa questione del consenso dell’ammalato ai provvedimenti emessi a suo carico o vantaggio, ma alle esigenze di provvedere, contestualmente, all’aggiornamento del personale, al collegamento delle strutture di ricovero con le risorse del territorio, all’applicazione di strumenti adatti per migliorare la qualità di vita e l’autonomia degli assistiti. Qualcuno non ha esitato a parlare di contro – trasmigrazioni di massa: persone anziane, da tempo esposte ai rischi del disadattamento alla vita presso l’istituto manicomiale che contro il loro parere le aveva accolte da giovani, sono state costrette ad un viaggio di ritorno presso i luoghi della loro provenienza, talora molto distante nello spazio oltre che nel tempo, per rispondere alle esigenze di suddivisione della competenza finanziaria delle A.S.L. e dei servizi sociali, non già per essere riaccolte da famiglie o collettività ormai indisponibili a riconoscerli come loro membri di diritto, ma per sobbarcarsi nuovamente il compito di un adattamento presso strutture “pesanti”, focalizzate sulla cronicità dell’intervento, senza verificare se e quanto essa fossero preparate ad accogliere i bisogni e a garantire i diritti di una reale ri-animazione di funzioni devitalizzate dalla lungodegenza. A chi conosce in profondità i meccanismi sociali che diedero vita, nell’Ottocento, alla filantropica, capillare diffusione dei manicomi nell’Italia unificata non sfuggono inquietanti analogie.
Diciamo questo anche alla luce dell’esperienza da noi condotta a Racconigi.
Anche il manicomio di Racconigi, come molti altri, ha vissuto l’esperienza della legge di riforma del 1978, che imponeva il graduale superamento degli ospedali psichiatrici, come, di fatto, un abbandono psichiatrico razionalizzato, attraverso la messa in pratica della sola assistenza sociale e medica generica per un rilevante numero di persone dei quali è stata sanzionata l’impossibilità di ricevere trattamenti alternativi. Anche qui, come altrove, la legge 180 non è stata interpretata dai tecnici come rottura critica e riappropriazione di un altro modello di operatività, quanto piuttosto come necessità di abbandonare quel luogo, e con esso tutti gli inguaribili ivi depositati, affidati a pochissimi psichiatri progressivamente ed in gran parte demotivati e molti infermieri rassegnati a subire l’onda di riflusso della precedente contestazione, tutti in attesa di un corso naturale degli eventi – il decesso, per i primi, il pensionamento, per gli altri.Lungo gli anni ottanta, salvo sporadiche parentesi nella quiete immobile dell’istituzione totale, non solo è fallito ogni precedente tentativo di messa in discussione dell’ordine istituzionale, ma complessi fenomeni istituzionali che non è qui il caso di analizzare hanno prodotto lo storno verso altri utilizzi, non destinati alla assistenza psichiatrica, delle risorse liberate dalla dismissione degli ospedali psichiatrici, fino a determinare, raggiunti livelli che definiremmo di sussistenza delle misure di gestione, improcrastinabili necessità di bonifica degli spazi. Per restare alla realtà da noi esperita, al 31 dicembre 1978 erano presenti presso l’ospedale psichiatrico di Racconigi 894 ricoverati. Tre anni dopo la popolazione degente si era ridotta a 469 persone, per effetto della legge 180; al termine del 1988 vi erano 290 ricoverati. Ma, mentre dal 1978 al 1996 vi furono 168 decessi, le dimissioni programmate nello stesso periodo furono progressivamente sempre più rare e quasi tutte verso le precedenti succursali del manicomio, che già avevano accolto le dimissioni del primo triennio laddove le famiglie non erano disponibili a riammettere al loro interno il congiunto; appena 16 pazienti fecero ritorno dopo il 1980 al loro domicilio. Nei primi anni novanta vi fu una brusca accelerazione dei programmi di dimissione, che determinarono il progressivo abbandono di interi padiglioni. Al 1° gennaio 1996, tuttavia, ancora 170 persone, per i due terzi maschi, vivevano nell’ospedale psichiatrico di Racconigi, ospitati nei reparti di uno solo dei quattro padiglioni originari e nelle sedi di tre comunità alloggio interne. La maggior parte rappresentava, nella classificazione voluta dalla Regione, la categoria dei disabili psicofisici, anziani non più autosufficienti per malattie della senilità o soggetti portatori di disturbi mentali cronici invecchiati nell’istituzione; settanta persone erano per lo più residenti nelle comunità alloggio interne e, di questi, solo trenta richiedevano ancora un’intensiva presa in carico psichiatrica, che, a cura del Dipartimento di Salute Mentale dell’area saviglianese, si realizzò attraverso veri progetti individuali elaborati dalle équipe multiprofessionali dei servizi di territorio, che si impegnarono nella loro accurata definizione lungo l’arco di molti mesi. A fianco del programma di trasferimenti, all’inizio del 1998 fu realizzato un corso di aggiornamento regionale per il personale dell’ex ospedale psichiatrico, condotto da colleghi psichiatri in servizio presso dipartimenti e centri universitari di Torino e Genova; durante l’estate, fu inaugurato un nuovo servizio per l’accoglienza dei dimessi che rimanevano a carico del servizio psichiatrico di zona, a cui spettava il coordinamento dell’intera operazione. Questo servizio proseguiva l’opera impostata all’inizio degli anni novanta da un gruppo di educatori professionali, qualificata, tra l’altro, da una profonda integrazione con la città e dall’apertura nei confronti del volontariato. Non era il primo ingresso di persone esterne nella storia dell’istituzione racconigese: e tuttavia avveniva in circostanze così diverse rispetto ad esperienze precedenti, di cui fu testimone il resoconto di Anna Maria Bruzzone:
“Nell’ospedale di Racconigi noi volontari eravamo entrati con un triplice scopo: essere testimoni in difesa dei ricoverati, organizzare attività con loro, provocare o coadiuvare, mediante quei compiti, un inizio di crisi nell’istituzione tradizionale. Ho tenuto un diario di quei giorni. Il manicomio era un enorme, lugubre carcere. Ricordo che la prima volta che entrammo nel reparto Chiarugi di lungodegenti uomini, dopo che le porte si furono aperte e richiuse a chiave dietro di noi, come in un incubo vedemmo sotto i portici aperti e nel cortile spoglio numerosi ricoverati, tutti in divisa grigia, che vagavano, ognuno perso in se stesso: non c’erano crocchi, se si parlava, si parlava da soli. Qua e là infermieri in camice bianco, ritti – il regolamento vietava di sedersi in servizio – isolati e silenziosi. Al solo entrare in quel luogo ci si sentiva stringere il cuore per i prigionieri, e poi ci si specchiava in quegli uomini conculcati e violentati, provando anche per se stessi tremore e spavento. Il diario mi richiama agli occhi ed alla mente altre immagini. In un camerone pieno di letti un fanciullo dodicenne contenuto durante il giorno con una fascia ad un braccio e durante la notte anche con un’altra all’altro braccio, che in seguito rividi imboccato ed assistito da un malato, e accanto un uomo, contenuto da venti giorni, quando lo incontrai, con una fascia ad una gamba: in quel periodo non era mai potuto scendere dal letto, non si era quindi mai lavato e per i bisogni corporali si era servito di un vaso che teneva nel tavolino da notte. Una stanza chiusa, d’inverno: in essa moltissimi ricoverati si muovevano a stento, agitati, come animali resi furiosi da una gabbia: poche sedie o sedili alle pareti, e su un alto sostegno un televisore, allora spento. E l’atteggiamento verso i ricoverati di molti di quelli che svolgevano, con funzioni e ruoli diversi, il loro lavoro nell’ospedale: parlavano dei ricoverati alla loro presenza, ignorandoli, come se essi non potessero capire, oppure ricorrendo a giri di parole e ammiccamenti, di cui gli altri avrebbero dovuto cogliere il significato ed i ricoverati no. Da una parte l’istituzione, potente nella sua vergogna che pareva non potersi scalfire; dall’altra noi volontari, velleitari, sprovveduti, confusi. Alla fine di marzo del 1970 rinunziammo all’attività nell’ospedale.”[8]
Nel corso degli anni abbiamo risposto numerose volte alla domanda: dove sono andati gli ultimi dimessi dell’ex ospedale psichiatrico? Come accennato, il loro percorso di uscita dall’istituzione che li aveva accolti nei precedenti venti, trenta, talora quaranta e più anni avvenne in maniera graduale e personalizzata: dei 170 con cui il progetto fu avviato, al 30 settembre 1997 vi erano ancora 80 degenti, di cui solo 15 appartenenti al gruppo con prevalente patologia psichiatrica, mentre gli altri erano soggetti non autosufficienti, per disabilità neuropsichiche o per prevalente patologia geriatrica. Nei sei mesi successivi, i primi 15 vennero tutti dimessi, e l’aggiornamento al 31 marzo 1998 documentava la presenza degli ultimi 47 pazienti della seconda tipologia, trasferiti presso strutture del territorio entro la fine dell’anno. Uno stralcio del colloquio-intervista che Anna Maria Buzzone tenne con un ricoverato di Arezzo può dare un’idea dei significati che assume la decisione di dimettere il paziente dalle cure psichiatriche, soprattutto quelle “ad alta protezione”:
“Volevo dire, uno dei motivi principali per cui i dottori tengono dentro i malati è la paura, perché se viene un malato in crisi, quando lo fanno uscire lo devono fare uscire con l’assicurazione che è guarito e che la crisi non ci sarà; e se putacaso gli riviene la crisi, oppure se anche combina qualche cosa, insomma, perché può anche tirare un piatto in testa a qualcuno, eh, la colpa è del dottore, va bene? E allora va così, che quando entrano qui è l’interesse del dottore farli stare qui, farli stare qui in modo che finché li cura, lui, il dottore, sta sempre a posto; se invece li fa uscire, corre rischi, e fra lo stare a posto e il correre rischi gli conviene lo stare a posto, capito? É per questo che gli ospedali s’affollano, eccetera, ha capito? Perché una vera sicurezza, il dottore, che una volta uscito l’ammalato non gli prende più niente, una volta che è rimesso in quell’ambiente familiare, è difficile che ce l’abbia, va bene? Anche chi è fuori può avere una crisi, d’accordo, ma i parenti li mandano qui per curare, eh, hanno paura anche loro, e poi, insomma…Il dottore è dottore o non è dottore? O è un fesso? E va a finire che gli conviene tenerli dentro, va bene?”.[9]
Dopo la definitiva chiusura dell’ospedale, un gruppo di trenta ex degenti, attraverso un graduale percorso di progressiva riacquisizione dell’autonomia avviato sei anni prima[10], viveva nei locali di tre comunità alloggio, dove ciascuno usufruiva dell’assistenza necessaria alla gestione alberghiera e del supporto di personale specialistico lungo l’arco delle 12 ore, disponendo dell’indipendenza rispetto all’organizzazione quotidiana, in merito agli spostamenti da e verso l’abitazione, e di una reperibilità notturna del personale attivabile in caso di necessità. Disponevano inoltre di un centro funzionante di giorno per la promozione di occasioni d’incontro e di partecipazioni ad attività sociali, coordinato da personale del servizio psichiatrico di territorio. Attraverso la frequenza di questo spazio cittadino, condivisa con utenti del locale Centro di Salute Mentale, fu loro possibile partecipare ad un ampio ventaglio di attività, dalla semplice accoglienza presso un locale adibito a bar, alla realizzazione di gite sociali, all’allestimento di laboratori espressive, tra i quali nel 1999 si inserì il laboratorio teatrale che produsse lo spettacolo Voci Erranti.
“Perciò per farli uscire ci vuole il coraggio, ci vuole praticamente il coraggio, perché una garanzia proprio che un malato di mente è guarito, e come fanno? ha voglia a studiar la mente, non ce l’hanno mai, va bene? E perciò ci vuole il coraggio di sdrammatizzare la questione…”[11].
Gli autori di Voci Erranti hanno avuto questo coraggio, proprio nel lungo istante in cui hanno drammatizzato la questione. Forse è il coraggio di strapparsi il lupo dal corpo che non era, e non è, possibile chiedere per intero agli addetti ai lavori; ed allora, ben vengano anche oggi in loro aiuto, dall’esterno della psichiatria, come già accadde negli anni settanta, persone coraggiose, senza considerarle velleitarie, sprovvedute, confuse, con i loro progetti credibili, colti, coerenti, capaci di contaminazioni ed incroci. Progetti che nell’ultimo decennio hanno trovato, a differenza di quanto avvenne ai giovani psicologi rifiutati dall’istituzione nei primi anni settanta, interlocutori incuriositi e disponibili negli operatori e nei dirigenti attuali del Dipartimento di Salute Mentale. Esperienze analoghe sono state riprodotte in contesti liberi dall’ombra minacciosa del manicomio. Pur con le sue ineliminabili contraddizioni, originanti dalla difficilissima mediazione tra un mandato sociale più o meno implicito che, necessariamente, comprende anche il controllo e bisogni, spesso di lettura estremamente ardua, degli assistiti, le odierne strutture del Dipartimento di Salute Mentale non hanno più nulla del lugubre carcere descritto da Anna Bruzzone.