Il lavoro con pazienti autori di reato si colloca strutturalmente in una zona di confine, in cui il progetto terapeutico è costantemente intrecciato al mandato giudiziario. In questo spazio intermedio, la possibilità di costruire un percorso dotato di senso dipende non solo dalla qualità dell’intervento clinico, ma anche dalla continuità e dalla coerenza delle risposte istituzionali.
Nella mia esperienza clinica recente, uno degli ostacoli più rilevanti alla realizzazione di interventi orientati all’autonomia risiede non solo nelle difficoltà intrinseche dei pazienti, quanto nella crescente instabilità degli interlocutori giudiziari. Il frequente avvicendamento dei Magistrati di Sorveglianza introduce infatti una discontinuità che rischia di compromettere la credibilità stessa del percorso riabilitativo.
La discontinuità decisionale come fattore clinico
La sostituzione di un magistrato con uno nuovo, spesso privo di una conoscenza diretta del paziente e della sua storia, comporta che richieste di permessi o ampliamenti graduali delle libertà vengano rilette da zero, talvolta prescindendo dal percorso già svolto. Può anche succedere che autorizzazioni precedentemente concesse vengano sospese o negate, non in seguito a un peggioramento clinico o comportamentale, ma per una prudenza istituzionale legata alla mancanza di una storia condivisa.
Dal punto di vista clinico, questa discontinuità produce effetti profondi: indebolisce il legame tra impegno terapeutico e riconoscimento istituzionale, alimenta vissuti di impotenza e arbitrarietà, e rischia di trasformare il progetto terapeutico in un contenitore formale privo di reale prospettiva evolutiva.
Una vignetta clinica: quando il rischio è del sistema
Un episodio preso dalla mia pratica quotidiana può forse aiutare a rendere più chiaro questo passaggio.
Un paziente, inserito da tempo in comunità, con una buona adesione al progetto terapeutico e un andamento clinico stabile, aveva già usufruito in passato di permessi accompagnati dagli operatori, senza criticità. A seguito dell’avvicendamento del Magistrato di Sorveglianza, una nuova richiesta – poco diversa per modalità e obiettivi a quelle precedenti – è stata respinta, con la motivazione che il permesso proposto non fosse ritenuto “sufficientemente protetto”.
Il rifiuto ha avuto inizialmente un impatto significativo sul paziente, che ha vissuto la decisione come una smentita del lavoro svolto e come la conferma dell’idea che, indipendentemente dall’impegno e dai progressi, l’accesso a maggiori autonomie restasse imprevedibile e fragile. Dal punto di vista clinico, ho percepito il rischio di una rottura del patto terapeutico implicito, fondato sull’idea che il cambiamento possa essere riconosciuto e sostenuto.
Ho avuto modo di richiedere un confronto diretto con il Magistrato di Sorveglianza, con l’obiettivo di comprendere le ragioni del rifiuto e chiarire quali elementi fossero considerati necessari per una valutazione favorevole. Nel corso del dialogo è stato possibile ricostruire la storia del paziente, il significato clinico del permesso richiesto e le motivazioni che avevano portato l’équipe a considerarlo un passaggio coerente e sostenibile.
Al termine dell’incontro, il Magistrato ha deciso di concedere il permesso, motivando il precedente diniego con un’affermazione tanto semplice quanto rivelatrice: “Capisce: se succede qualcosa, poi io finisco sui giornali”. Questa frase ha reso esplicita una dimensione fin lì implicita, ovvero come le decisioni giudiziarie possano essere fortemente influenzate da una logica difensiva, più orientata alla tutela dell’istituzione e della responsabilità personale che a una valutazione condivisa del rischio clinico.
La disillusione come esito relazionale
Episodi come questo mostrano come la discontinuità istituzionale non sia un elemento neutro, ma un vero e proprio fattore clinico. Quando il riconoscimento dei progressi diventa incerto o revocabile, il paziente può sviluppare una profonda disillusione, che si esprime attraverso ritiro emotivo, atteggiamenti oppositivi o perdita di fiducia sia nel sistema che negli operatori, i quali possono essere visti come impotenti mediatori.
Il rischio è che l’intervento terapeutico venga percepito come un esercizio privo di ricadute reali, alimentando una posizione di passività o di cinismo che finisce per confermare le paure istituzionali.
Costruire reti: uno spazio possibile?
Di fronte a questo scenario, la possibilità concreta che intravedo è il tentativo, faticoso ma necessario, di costruire reti di dialogo con la magistratura e, più in generale, con le forze dell’ordine territorialmente competenti. Presentarsi, spiegare il lavoro clinico, rendere visibile la complessità dei percorsi e la gradualità delle richieste può contribuire a ridurre la distanza tra decisione giudiziaria e processo terapeutico.
Si tratta comunque di un lavoro fragile, costantemente esposto al rischio di essere vanificato dall’elevato turnover, spesso improvviso, degli interlocutori giudiziari, così come dalle pressioni del contesto esterno, che possono inevitabilmente determinare deviazioni rispetto ai percorsi previsti. Credo che anche questi eventi, sebbene complessi, debbano essere condivisi e discussi all’interno del percorso stesso del paziente, assumendo il valore di fattori di cui tener conto nella costruzione continua del progetto terapeutico.
Conclusioni
Il lavoro con pazienti autori di reato richiede una delicata alleanza tra sistema di cura e sistema giudiziario. Quando questa alleanza si frammenta, il rischio è che il percorso terapeutico perda coerenza e significato, trasformandosi in un’attesa senza prospettiva.
In assenza di una reale continuità istituzionale, il nostro compito diventa anche quello di farsi custodi della memoria del percorso comunitario, tentando di mantenere vivo il senso del lavoro clinico nonostante le discontinuità decisionali. La costruzione di reti con la magistratura non credo rappresenti una soluzione definitiva, ma diventa uno spazio necessario per difendere la funzione trasformativa della cura all’interno di un sistema che, in questo momento storico, appare sempre più orientato al controllo.
Accanto a questo lavoro di mediazione istituzionale, diventa però imprescindibile mantenere viva un’attenzione culturale e sociale sulla psichiatria come pratica complessa e non riducibile alla gestione del rischio. La formazione continua, il confronto interdisciplinare e momenti pubblici di riflessione – come il convegno dedicato alle REMS svoltosi il 3 e 4 ottobre – assumono in questo senso un valore che va oltre l’aggiornamento tecnico: essi rappresentano luoghi di resistenza simbolica alla tentazione di pensare il disagio psichico e la devianza esclusivamente in termini di controllo sociale, e spazi nei quali può continuare a essere coltivata una speranza critica di maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva.

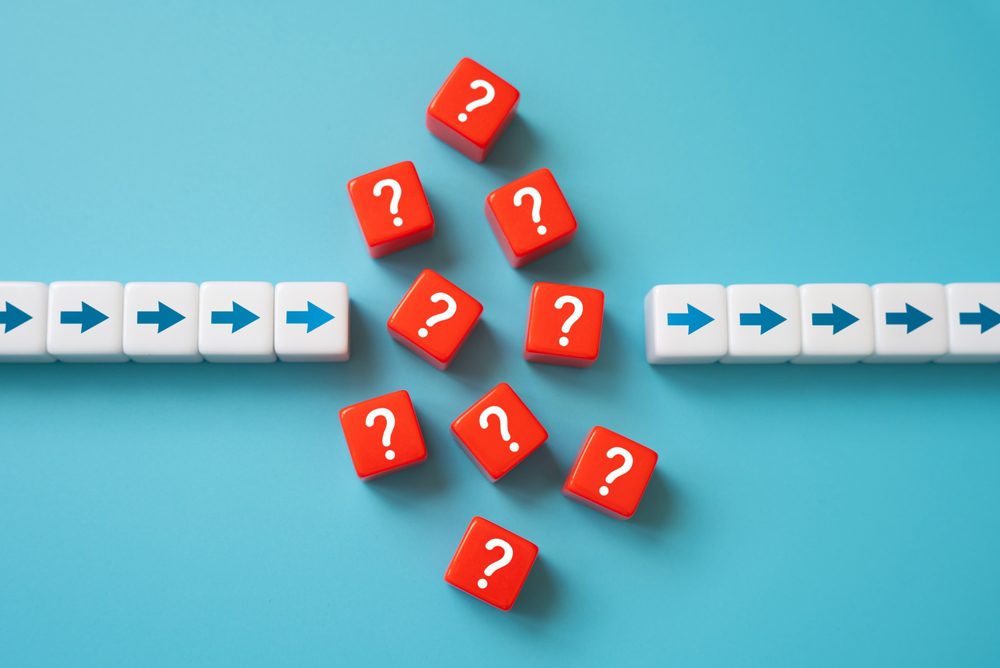
















Intervento molto utile perché evidenzia i problemi aperti.
Nelle Rems il regolamento penitenziario non è applicabile e dopo la chiusura degli Opg si sono mantenute prassi precedenti (licenze ad horas ecc.).
In assenza di provvedimenti di natura legislativa credo siano molto importanti i regolamenti, le Carte dei Servizi delle REMS e delle altre strutture da comunicare e condividere con la Magistratura a livello regionale in specifici protocolli. Questi possono essere un riferimento a tutti pazienti, familiari ecc. avvocati, garanti e giudici. Così si può ridurre la variabilità. Poi sono fondamentali i PTRI che devono essere ampi, da costituire una cornice e non richiedere continue richieste ai magistrati. La Rems non è un istituto, una struttura autonoma e autosufficiente ma per le sue attività deve essere organicamente connessa con il territorio. Non si può parlare di interventi “intramurari”. Infine il rispetto delle prescrizioni durante la libertà vigilata va visto sapendo che i bisogni e le lettere psichiatrica e giudiziaria sono diverse e fondate su presupposti diversi. Le condizioni per la cura sono state illustrate su questa Rivista