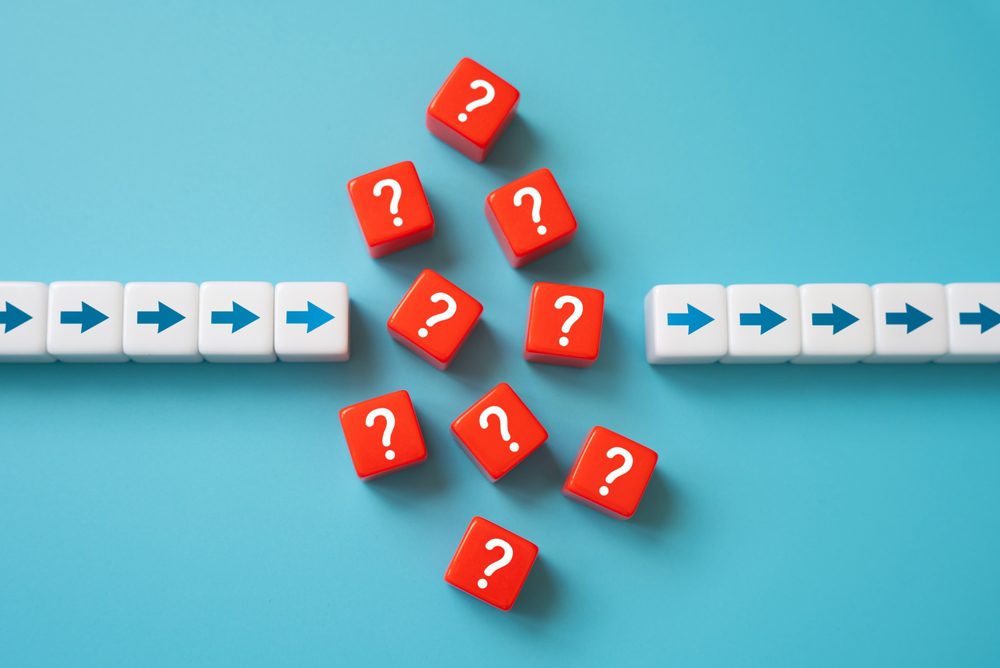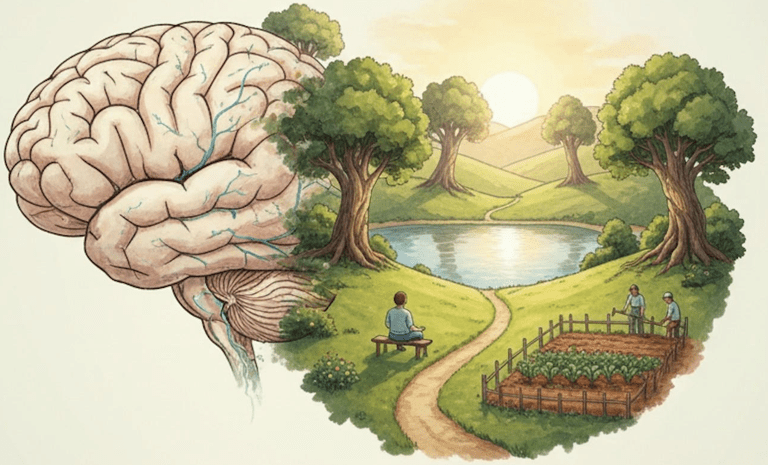Stabilimento balneare. Fine giugno. Dopo un’apparente renitenza dell’estate a insediarsi decisamente, il caldo è torrido, la luce abbacinante e il vociare delle truppe balneanti accompagna come continuo rumore di fondo il ritmo delle piccole onde che rotolano sul bagnasciuga.
Il quadro è dunque quello lenitivo e pop della bella stagione che, come Enrico Ruggeri connota con fulminante calligrafia in una sua canzone, è tornata, come sempre, “piena di bugie”.
Ma una piccola scena, in bilico tra catastrofe e sceneggiata popolare, sta per lacerare, almeno nell’immediato circondario, l’illusione del “piacere” e del “bello”, che fino a poco prima erano stati fatti faticosamente combaciare nei riti plebiscitari dell’estate – ciò che persino Kant nella Critica del Giudizio aveva disperato si realizzasse universalmente se non in rari casi.
In un attimo, gli spettatori involontari – tra i quali ho la ventura di trovarmi anch’io – finiranno catapultati né nei pressi del piacevole, né tantomeno in quelli del bello.
L’aggressività di un bambino
A pochi metri dalla mia postazione, un bambino di circa dieci anni, frustrato in una qualche sua richiesta – che sospetto non rivestire carattere vitale, né avere a che fare con una violenza di cui sia stato oggetto -, picchia letteralmente il padre che subisce in modo del tutto disarmato e rinculante (mi ricorda il mio atteggiamento quando prendevo qualche scapaccione dal mio compianto papà, ex militare e uomo del sud, ai tempi “reazionari” in cui i ruoli erano invertiti). Poi il ragazzino gli afferra gli occhiali da sole lasciati sul lettino e glieli sbatte violentemente sullo stesso urlando: “ecco la fine che faccio fare ai tuoi nuovi occhiali!”.
Il padre impietrito riesce a sibilare solo un implorante “no, con quello che mi sono costati…”, protendendosi inerme verso il gruppo scultoreo composta dal prezioso erede, dal suo gesto di rabbia titanica e dagli occhiali che impattano sulla superficie del lettino. Poi, sottovoce, osa suggerire al piccolo vendicatore che (forse) è stato poco educato.
L’unigenite rimanda con voce stridula ma percepibile in una vasta area: “io maleducato? E tu sei una persona orrenda, che non dovrebbe esistere! Non dovresti essere neanche nato!”.
Il genitore, ancora più disarmato e in difficoltà, decide che non c’è altro da fare che allontanarsi, intraprendere mestamente la via dell’esilio come l’ultimo rappresentante di una casa regnante già da tempo decaduta. E così si dilegua.
Perché non ha idea di come rispondere in una situazione sociale – ma verosimilmente in qualsiasi luogo – a questo show del figlio.
La figura della madre
D’altronde, se, come cantano Guccini/I Nomadi, nei miti dell’estate Dio, che è “Il” Padre, è morto, cosa possiamo attenderci che accada a un povero “padre”?
Lasciato il campo libero alla diade edipica, la mamma, che era stata il più prossimo e silenzioso sguardo fuori campo, probabilmente trepidante più per il sovvertimento emotivo della creatura che per l’inermità del coniuge, prende a cullarsi il virgulto cercando dolcemente di fargli valutare l’ipotesi che abbia potuto (forse) sbagliare. Ma il ragazzino ad alta voce mette in chiaro definitivamente di non aver assolutamente sbagliato nulla, chiudendo a qualsiasi sviluppo dialettico (anche se lui non conosce il difficile termine “dialettica”, sa benissimo come non farla sorgere neppure come possibilità).
La signora a quel punto evidentemente conclude che non è il caso di provocare oltre l’ira del “piccolo dio” e insieme, mamma e puer – probabilmente aeternus -, se ne vanno verso il bagnasciuga, con lei che lo segue deferente, rassegnata a ratificarne, quando non a celebrarne, l’onnipotenza.
Excusatio non petita
Consentitemi, con atteggiamento degno della prudenza del miglior Bruto di fronte al popolo romano dopo l’assassinio di Cesare, una sorta di captatio benevolentiae, rivolta soprattutto agli psicologi, agli psichiatri, agli educatori, agli studiosi delle relazioni genitoriali e agli specialisti del mondo emotivo infantile, i quali potrebbero ricavare, da questo breve racconto, un’atmosfera reazionaria implicita o di inconfessata laudatio temporis acti.
Non intendo fare di questo mio sguardo, che è stato suo malgrado catturato da una scenetta perturbante ma tutt’altro, a mio modo di vedere, che semplicemente aneddotica, un baluardo nostalgico, ma semmai una lente per osservare – certo con comprensibile inquietudine – ciò che accade quando la funzione del padre si smaterializza fino a diventare un’ombra muta e ritirata.
Ciò che prende il suo posto sembra essere un principio pulsionale senza argine, autocelebrativo e ineducabile.
Non s’intende qui proporre una diagnosi morale, ma semmai clinica, antropologica, simbolica: ovvero, non una rievocazione di passati ormai congedati, ma una domanda inquieta sul presente.
Evocare alcune nozioni classiche, come quella di funzione simbolica, di limite, di triangolazione edipica, o richiamare, tra le righe, figure mitiche o teoriche oggi ritenute desuete, non è funzionale alla volontà di rimettere in piedi vecchie statue abbattute, ma a tentare di comprendere quale tipo di vuoto abbia preso il loro posto e quali nuove formazioni sociali, psichiche e patologiche stiano emergendo da tale evaporazione.
Ancora, occorre sottolineare che questa è la classica scena che in genere si considera riguardare l’altro. Certo, noi genitori d’oggi, effettivi o potenziali, siamo pur consapevoli di avere qualche problema d’identità di ruolo, ma, di fronte all’estremizzazione icastica sopra rappresentata, probabilmente ci diciamo che essa ci riguarda solo come curiosità sociale.
Circostanza o sketch paradigmatico?
Il silenzio che d’intorno aveva seguito la “edificante” scena, probabilmente non è solo espressione di un imbarazzo legato a una circostanza episodica, ma rivela un sottaciuto coinvolgimento collettivo sintomatico: il disfacimento del principio simbolico dell’autorità e con esso dell’ordine generazionale e del senso del limite. Non siamo davanti a un “caso” singolare di cattiva educazione, ma a un sintomo culturale che porta in sé una domanda radicale: cosa resta del patto educativo, della funzione paterna, del desiderio che attraversa le generazioni e non si esaurisce nel soddisfacimento immediato?
Quel bambino non è chiaramente un mostro, ma un prodotto logico — e affettivo — di un tempo che ha trasformato l’autorità in colpa, l’autorevolezza in trauma da evitare, il conflitto in panico sociale.
Il padre disarmato, imbelle, è figura di una funzione evaporata (Lacan), svuotata del proprio senso strutturante: non solo egli non punisce, ma nemmeno interpreta, nomina o trasmette. Non c’è un gesto simbolico; solo un balbettio impaurito, una preoccupazione – che è anch’essa un piccolo capolavoro dis-educativo – per il valore monetario del danno materiale. E infine, un ritiro dal campo.
La madre chiude il cerchio nell’apparente resa incondizionata – quando non partecipazione attiva al culto – al narcisismo infantile.
Kundera e la rovina narcisistica
A questo proposito, la scena mi ha fatto ripensare a un romanzo di Milan Kundera, La vita è altrove, dove si racconta la triste vicenda di Jaromil, bambino-poeta di scarso talento allevato da una madre che lo idolatra come fosse un oracolo e un predestinato. Kundera scrive: “Quando la madre gli aveva detto: ‘Tu sei la mia vita’, non aveva fatto che strapparlo al mondo per incatenarlo al suo amore”.
Jaromil cresce avvolto da uno specchio permanente: ogni gesto, ogni parola, ogni capriccio viene riflesso, celebrato, accarezzato. Ma mai educato. E così, invece di diventare uomo, resta prigioniero di un sé narcisistico, ipersensibile e persecutorio. Non impara la realtà, ma solo il culto di sé. E di questa grandiosità che la realtà s’incaricherà di smentire traumaticamente, finirà, nella migliore delle manifestazioni epigonali di Narciso, per morire.
Quel bambino sulla spiaggia sembra figlio dello stesso mito: quello della centralità emotiva assoluta, dove il compito del genitore non è più trasmettere la legge, ma gestire le tempeste affettive senza mai opporsi e proiettare grandiosità senza argine. Non sorprende che, nella narrazione corrente, ogni frustrazione sia percepita come violenza e ogni richiamo come tradimento.
L’infanzia è diventata sacra, ma nel senso idolatrico del termine: intoccabile, separata dal reale.
La fine dell’autorità e la rimozione del “no”
Hannah Arendt, con lucidità implacabile, diagnosticava già nel secondo dopoguerra la crisi dell’autorità come perdita di un fondamento simbolico.
L’autorità, affermava, non è dominio né potere arbitrario, ma capacità di rappresentare un ordine simbolico che precede e fonda la relazione educativa.
Un padre che parla in nome della legge, un maestro che insegna in nome della conoscenza, non parlano a titolo personale, ma trasmettono un mondo comune. Quando questo viene meno — quando tutto diviene orizzontale, contrattuale, opinabile — l’educazione si dissolve in una negoziazione senza struttura, in una psicologia dell’accompagnamento che non educa ma coccola, non struttura ma consola.
Donald Winnicott, nel definire la figura della madre sufficientemente buona, indicava un equilibrio sottile: inizialmente il genitore si adatta quasi completamente al bambino, ma gradualmente deve deludere, introdurre la frustrazione, mostrare che il mondo non è un’estensione del proprio desiderio. Senza questo gesto simbolico, il bambino resta immerso in una illusione di onnipotenza, incapace di tollerare la differenza e l’assenza.
Oggi pare di assistere a una iper-adattività educativa che impedisce ogni separazione.
Christopher Bollas parla di una sorta di privazione di contrasto: l’ambiente è talmente sintonizzato sui vissuti del bambino che non vi è più resistenza, alterità, ombra.
Il bambino cresce in una casa di specchi dove non incontra mai il mondo, ma solo il riflesso deformato del proprio umore.
Oggi il “no” suona come una dissonanza insopportabile. E allora l’ira esplode. Devastante e senza rimorso.
Nel capolavoro Pastorale americana, Philip Roth mette in scena Seymour Levov, padre buono, tollerante, progressista, che tenta in ogni modo di comprendere la figlia ribelle. Ma la sua disponibilità e la sua bontà si rivelano impotenti. Roth sembra suggerire che l’assenza del limite generi mostri e che il bene disarmato sia solo una forma impotente di desiderio, senza efficacia né valore.
Come il padre sulla spiaggia: disarmato non per amore, ma per rimozione della propria funzione.
Nel nostro tempo — chiosa Byung-Chul Han, filosofo sud-coreano — il negativo è stato abolito. Niente più mancanze, interruzioni, interdizioni: solo accumulazione, trasparenza, prestazione.
Anche l’infanzia è colonizzata da questa logica: tutto deve essere visibile, comunicabile, gestibile; il desiderio sempre accolto, sempre soddisfatto fino al collasso del desiderio stesso come impianto e motore che nasce dalla mancanza.
Il risultato è una infanzia narcisistica, esposta alla luce costante dello sguardo genitoriale accondiscendente ma privo di riparo simbolico. Il bambino non si struttura come soggetto, ma come immagine: da proteggere, da difendere, da vendicare.
E l’adulto si ritrae. Si dissolve. Diventa un mediatore affettivo, incapace di dire “no”.
Il ritorno del gesto del “no”
Ovviamente non serve più moralismo, né nostalgia. Serve, per così dire, coraggio simbolico, che si incarna nel gesto del no: limite che fonda, resistenza che struttura, ombra che fa nascere la forma.
Un bambino a cui si nega il “no” non è amato: è sacrificato al narcisismo.
E un adulto che non sa più dire “no” non è buono: è semplicemente assente o perlomeno abdicatario.
In un tempo che idolatra la trasparenza, occorre — forse — difendere l’opacità. In un tempo che celebra l’immediatezza, bisogna reimparare la distanza, la sua lenta ritualità.
In un mondo che ha cancellato la soglia, bisogna ristabilirla. Non per escludere: per rifondare i passaggi. Non per punire o coartare: per lanciare nel futuro.
Forse è questo il compito residuo dell’adulto nel tempo dell’estinzione simbolica: non piacere o evitare sempre di dispiacere, ma essere custode della soglia.
Il giovane dio e l’uomo
“Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo,
senza pena, col morto sorriso dell’uomo
che ha compreso.
Anche il sole trascorre remoto
arrossando le spiagge.
Verrà il giorno che il dio
non saprà più dov’erano le spiagge d’un tempo”.
Così Cesare Pavese nella poesia Mito, da Lavorare stanca.
Questo giorno verrà ancora? Quel piccolo dio onnipotente — celebrato, sorvegliato, assolto — sarà messo ancora in condizione di perdere le sue spiagge? Di smarrirle con doglianza, di lasciarle alle spalle con un lutto da elaborare per farsi uomo?
Oppure sarà la vita, senza più il filtro dell’interdizione simbolica, senza più la mediazione dei ruoli incarnati dell’autorevolezza e dei riti di passaggio, a incaricarsi con brutalità di quel compito formativo che spettava al “padre”, alla legge, alla parola che introduce il limite?
La scena tragicomica della spiaggia, nella sua crudele quotidianità, mostra il rischio concreto di un mondo che ha rifiutato il dolore necessario della crescita. E quel dolore, non accolto, non mediato, non bonificato e infine non integrato nella relazione, tornerà più tardi, nella forma violenta della frattura narcisistica, della rabbia senza linguaggio.
Perché se nessuno insegna al dio a diventare uomo, egli lo diventerà solo per rovinosa caduta. E allora le spiagge d’un tempo saranno davvero perdute. Senza più mito da cogliere pienamente solo nel suo oltrepassamento.