Sono noti due eventi che riguardano il problema dell’agito che sono saliti agli onori della cronaca perché hanno coinvolto due personaggi pubblici: di recente l’ex Presidente del Consiglio Prodi e pochi anni fa Papa Bergoglio. Sono episodi molto interessanti, tanto più che i protagonisti sono persone di notevole spessore culturale, abituati a esprimersi in pubblico e a sostenere confronti anche carichi di conflittualità. E’ quindi comprensibile che tali eventi abbiano scatenato dibattiti, polemiche e persino caricature. Provo qui ad aggiungere qualche riflessione intorno al tema dell’agito che tanto interessa i clinici.
Cosa si intende per agito
L’agito è letteralmente un atto compiuto, in genere impulsivamente, che esprime un vissuto conflittuale tramite il comportamento al posto del linguaggio. Si può anche dire che l’agito è un comportamento che prende il posto del pensiero.
In ambito clinico l’agito è assimilato ad un attacco alla cura perché inverte il flusso di pensieri ed emozioni dalla mente al gesto e così questi elementi psichici possono sfuggire alla possibile elaborazione all’interno della cornice terapeutica. Sono frequenti gli episodi in cui il paziente tenta di sottrarsi a questo impegno e sono tante le forme minime di agiti che hanno proprio questo scopo e che disseminano i percorsi di cura: ritardi, sedute mancate, interruzioni, ripetizioni di comportamenti disfunzionali, mancato rispetto degli onorari, tentativi di intromissione della vita privata del terapeuta ecc. Sono tante le possibili espressione comportamentali delle resistenze che, per lo più, suscitano un atteggiamento di disapprovazione da parte dei terapeuti che vedono attaccato il dispositivo della cura.
Bisogna ammettere che non mancano neppure gli agiti sul fronte dei curanti. Capita talvolta che degli interventi siano dettati da uno stato emotivo alterato che si impone nel terapeuta in reazione a qualcosa che proviene dal paziente e si interfaccia con questioni personali acute o irrisolte come resti non analizzati. Senza dover per forza tornare con la memoria agli agiti clamorosi al tempo dei manicomi con contenzioni meccaniche o elettroshock imposti a scopo punitivo o meramente contenitivo, oggi possono accadere eventi, in genere di portata più ridotta, che comunque dobbiamo registrare come significativi e meritevoli di riflessione: da dimenticanze ed errori fino a comportamenti espulsivi, vi sono agiti che segnalano che il dispositivo mentale del sistema curante è fragile e richiede formazione specifica e manutenzione continua.
Porto tre brevi esempi.
- In supervisione un terapeuta racconta di un agito appena fermato in tempo. Un imprevisto incontro fuori dall’ambito clinico con una paziente seguita solo online, a causa di un recente intervento per una grave neoplasia e la scoperta di metastasi, suscita in lui un impaccio nel salutarla. Egli si rende conto di stare sul punto di dirle: “che piacere vederla … dal vivo” ma si frena in tempo e riesce a modificare l’ultima parte della frase che riconosce come inadeguata. In supervisione riflette sull’angoscia di morte che questa donna comunica ma che appartiene anche alla sua storia personale e che stava provando ad aggirare attraverso un agito. Quelle parole pensate e trattenute hanno però aiutato a recuperare una parte importante che lo riguarda alla quale non aveva pensato prima e questo è stato per lui il vero incontro imprevisto, l’alterità che lo riguarda attraverso la paziente.
- Uno studente in medicina va in analisi e manifesta fantasie erotomaniche nei confronti della sua analista. Queste fantasie diventano comportamenti sempre più pressanti che mettono a disagio l’analista che, sentitasi in pericolo, lo denuncia. Durante il procedimento penale, per una curiosa omonimia, il paziente viene scambiato per un pericoloso terrorista. Superato il fraintendimento, al paziente resta un pensiero persecutorio che si allarga sempre più parallelamente ad una crescente frammentazione del pensiero e del linguaggio: i poliziotti che l’hanno arrestato diventano nazisti, il pensiero si ferma ad un passato remoto fatto di guerre e uccisioni e viene manifestata ripetutamente impulsività aggressiva. Ne consegue una serie di ricoveri in acuzie e poi un lungo periodo in Comunità, in una località lontana da casa, con progressiva riduzione di deliri e impulsività ma con un definitivo “arresto” nella cronicità, oggi eufemisticamente definita stabilizzazione con impoverimento cognitivo.
All’agito del paziente, probabilmente attivato da una relazione transferale vissuta da lui in modo erotizzato e senza capacità di accedere ad una lettura simbolica, è seguito l’agito dell’analista e poi degli investigatori che hanno inchiodato il paziente ad un funzionamento scisso e persecutorio.
- Un terzo esempio di agito diventato molto famoso si rintraccia in letteratura con l’alterco tra un paziente e il suo analista a causa dell’introduzione nel setting da parte del primo di un registratore cui segue una vibrante reazione da parte del terapeuta. Il paziente dopo la seduta col registratore viene prelevato dalla polizia e internato in manicomio, riesce a fuggire ma subisce in seguito altre ospedalizzazioni forzate. Qualche anno dopo scrive una lettera alla rivista filosofica Les Temps Modernes e propone la trascrizione del dialogo con il suo psicoanalista (che aveva appunto registrato) che egli chiama “Il dialogo psicanalitico”.
Il testo viene pubblicato e suscita un aspro dibattito interno alla rivista coinvolgendo, tra gli altri, Sartre e Pontalis. In Italia la vicenda arriva grazie a Elvio Fachinelli che la ripubblica attivando una catena di riflessioni e di altri scritti: l’uomo col magnetofono non c’è più ma la sua registrazione testimonia ancora di qualcosa che riguarda i rapporti di potere all’interno del setting (“Un singolare gatto selvatico. J.J.Abrahams, l’uomo col magnetofono”, a cura di G.Conserva, P.Barbetta e E.Valtellina).
Il potere dell’agito
L’agito sembra avere il potere di sovvertire quello che si reputa il normale corso di una relazione terapeutica basata su qualcuno che chiede un aiuto professionale a qualcun altro che lo fornisce. Una sostanziale asimmetria che si vuole inserire pacificamente entro una cornice cooperativa: il famoso contratto terapeutico dove da entrambe le parti ci si impegna a rispettare le regole del setting, comprese quelle sul consenso, sulla privacy e sull’eventuale pagamento delle sedute.
Questa asimmetria si manifesta d’altra parte anche nei confronti della causa della sofferenza, tanto difficile da comprendere quanto insistente e inabilitante. Di qui la spinta a consultare qualcuno che si suppone sia in grado di comprendere e sollevare dalla sofferenza. E’ un’asimmetria di competenze che tutti possiamo riconoscere come legittima.
Dal lato del paziente
Sul fronte del paziente, notiamo che nel tempo c’è stato un progressivo cambiamento della sintomatologia prevalente: un tempo erano frequenti i disturbi basati sull’inibizione – sia nell’ambito delle nevrosi sia in quello delle psicosi – mentre ora si stanno diffondendo la disregolazione emotiva e l’impulsività. L’inibizione appartiene ad un’epoca storica basata su una prevalente rigidità della struttura familiare e sociale con una totale asimmetria nella distribuzione del potere, è intriso di pudore, di timore del giudizio, di vincoli alla tradizione. Ma oggi l’inibizione, che un tempo era uno dei sentimenti di protezione dall’angoscia, sembra fuori moda. Il riverbero sul piano generale del controllo delle passioni e il rispetto della gerarchia familiare ha un evidente significato nei termini di un processo di civilizzazione volto a domare gli aspetti irrazionali e perturbanti.
È in quest’epoca che nasce la psicoanalisi e da questo clima proviene lo sguardo di disapprovazione verso le devianze che il R.D. n° 36 del 1904 riunisce parlando di “alienati…pericolosi per sé e per gli altri e di pubblico scandalo”. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e molti cambiamenti sono intervenuti nella società e anche nelle pratiche psichiatriche e psicoterapeutiche. A pensarci bene, molti di questi cambiamenti sono avvenuti attraverso pratiche decisamente sovversive: era certamente sovversiva la psicoanalisi che Freud definiva la “peste” per l’influenza che avrebbe determinato sul mondo e sono state sovversivi coloro che hanno portato alla chiusura dei manicomi e continuano a esserlo i tanti tipi di interventi dei servizi di salute mentale territoriali che provano a innovarsi e crescere pur all’interno di meccanismi che li frenano e li impoveriscono di risorse.
Per continuare, non sono forse sovversivi i lapsus, l’attacco di panico o l’incubo che scompaginano l’ordine difensivo della rimozione o il breakdown di un giovane in cui irrompono sintomi acuti che esprimono un cambiamento drammatico? Il cambiamento repentino di un equilibrio delicato è sempre accompagnato da una quota di angoscia ma, come tutte le volte che l’inconscio si apre in modo imprevisto, è forte la tentazione di chiudere bene a chiave quella porta che inaspettatamente si è spalancata mostrandoci tutta la nostra vulnerabilità. In questi casi la richiesta più frequente è un aiuto a tenerla ben chiusa e così il panico diventa ansia anticipatoria ed evitamento di ogni occasione di vita sociale, il timore di nuovi lapsus fomenta l’aumento delle difese e l’esordio psicotico inaugura spesso una carriera psichiatrica volta a smorzare il rischio di nuove crisi.
Il moderno apparato psichiatrico, insegnato all’università e sponsorizzato dalle case farmaceutiche, mira a questo lavoro di contenimento delle crisi che sta producendo una larga schiera di cronici passivi, dipendenti e privi di una loro soggettività, isolati dal contesto sociale, chiusi in casa o in strutture residenziali in una sorta di manicomializzazione diffusa. Eppure si muove nella società un notevole malessere che si esprime con i sentimenti prevalenti di rabbia e di perdita di speranza, quei sentimenti che U.Galimberti descrive in termini di “nichilismo” (“il più inquietante fra tutti gli ospiti”, scriveva Nietzsche). Sentimenti non sempre arginabili o addomesticabili con l’abuso di sostanze o di social che, anzi, possono attivare scompensi ulteriori.
Di fatto stiamo assistendo ad una grande regressione da quel pensiero positivista che aveva fatto immaginare che la progressiva civilizzazione dell’umanità avrebbe portato ad una maggiore capacità di gestire le pulsioni inconsce (“là dov’era l’Es deve subentrare l’Io”, scriveva Freud). Siamo invece in un’epoca in cui regna il discontrollo emotivo e i labili confini tra le persone e tra il mondo interno e quello esterno vengono superati con disinvoltura, a volte con compiacimento. Dalla pandemia in poi sono nate piattaforme per approcci psicologici da remoto, spesso abusati per sfuggire a relazioni dirette, con diverse varianti discutibili di psicoterapie virtuali.
Il limite dello spazio personale
Quindi, non dobbiamo sorprenderci se – tornando agli incidenti accaduti a Prodi e a Bergoglio – il limite dello spazio personale viene violato e l’incontro diventa scontro? In un’epoca di mancanza di mediatori sociali credibili può accadere che un leader scenda a contatto diretto con interlocutori improvvisati che non desiderano un confronto dialettico ma qualcos’altro: un contatto fisico-feticcio, una provocazione aggressiva da consumare nel turpiloquio dei social ecc. Siamo lontani dall’azione umoristica di Benigni che prende in braccio Berlinguer che a sua volta si lascia prendere in braccio. Qui l’azione è festosa e si svolge all’interno di una più ampia cornice condivisa che è preparata ad accogliere col sorriso la scena bonaria e giocosa di un incontro dalla forma insolita tra il politico e il personale. In fondo quello è stato un abbraccio rassicurante tra il rigore della politica e la comicità dissacrante, non un vero atto sovversivo.
La crisi di sistemi di valori ideali
Accade però che, successivamente alla crisi dei sistemi di valori ideali – ideali sovversivi compresi – e alla decadenza progressiva dell’idea di comunità e di confronto dialettico, si fanno strada posizioni dedite alla cultura del disincanto e del disimpegno sociale, sorrette dal facile reperimento di tanti dispositivi deputati alla sudditanza dal registro immaginario. È nel trionfo della labilità dei confini che l’angoscia del vuoto sembra trovare un po’ di riparo. Smarrendo la grammatica dei legami sociali e delle radici culturali tutto appare più sopportabile perché schernito e attaccato con quelle difese maniacali che tentano un disperato controllo onnipotente dell’oggetto misterioso: l’altro.
Con questo termine intendo indicare la doppia accezione dell’alterità, quella della realtà sociale (le altre persone) e quella struttura simbolica che definisce l’uomo come animale sociale (Lacan lo chiama Altro) con i suoi aspetti opposti come il linguaggio comune e la legge ma, nota Zizek, “quando collassa – come è accaduto nella seconda metà del nostro secolo – mostra la sua faccia oscena, corrotta, irrazionale” (S. Zizek, “Il grande Altro”).
Gli agiti che stanno dilagando nei vari angoli della città, sui bus o nel pronto soccorso fino alle scuole, appaiono per lo più come reazioni sproporzionate, come gesti di insofferenza ma dietro queste modalità violente si intravvede l’incapacità di tollerare la presenza dell’altro (e dell’Altro) che risulta ingombrante, scomodo, da eliminare. Si tratta di modalità distruttive e afinalistiche dove il gesto si consuma in sé istantaneamente nel godimento per l’annichilimento dell’alterità. Sono gesti predatori senza progettualità, solo mere scariche motorie da parte di soggetti fermi ad un funzionamento neuropsicologico primitivo e istintuale.
Che spazio resta oggi al potere veramente sovversivo dell’agito?
Esistono agiti con una carica potenzialmente ridefinibile da mettere al servizio di processi di cambiamento? E in ambito clinico siamo attrezzati per un lavoro di analisi degli agiti per convogliare questi atti in un processo di cura? Capita più spesso che il setting venga totalmente travolto dagli agiti senza possibilità di recupero lasciando ingombro di macerie lo spazio della cura, macerie da eliminare per riprendere il lavoro interrotto malamente.
Un esempio tra i tanti che possono venire in mente: un uomo con un livello cognitivo borderline usa il denaro come antidepressivo e come organizzatore della sua fragile struttura di personalità. Grazie a piccoli pensieri galanti e una buona cura del suo aspetto è apprezzato dagli altri ospiti della Comunità in cui è inserito ma nel resto del mondo deve muoversi furtivamente elemosinando o giocando al gratta e vinci come se stesse nelle tetre foreste delle fiabe dei Grimm rischiando la vita alla ricerca disperata di fortuna.
Tuttavia, prevalendo le buone maniere e una discreta stabilità emotiva, i curanti ipotizzano l’inserimento in appartamento con assistenza domiciliare a fascia oraria forzando le resistenze di parenti e Amministratore di sostegno. Proprio in questa fase il paziente viene accusato di vari furti in Comunità che fanno arrestare il programma di dimissione: il paziente reagisce fuggendo e viene ricoverato, fugge ancora e ancora una volta viene ricoverato. Tutto il contesto appare sconsolato per un progetto che sembra definitivamente naufragato. La stessa Comunità lo dimette senza darsi uno spazio di riflessione su quanto accaduto, come se il progetto fallito ormai non la riguardi più.
Quest’ultimo esempio mostra il difficile crinale degli agiti quando stringono d’assedio la mente dei curanti impedendogli di pensare e attiva altri agiti. Né viene sempre in aiuto l’equipe che si teorizza come uno spazio di pensiero multidisciplinare ma spesso si declina attraverso assetti gruppali difensivi. Nel tempo stringente del “fare” la concretezza prende il sopravvento ed è difficile imporre un tempo di riflessione. La negoziazione delle regole del setting e degli obiettivi da raggiungere stride con la rigidità di un’organizzazione sanitaria che vuole evitare di valutare il proprio operato e mettere in discussione le abituali modalità di lavoro.
Se regna la necessità del controllo del sintomo, ci si posiziona in modo difensivo e tutto l’assetto relazionale che ne consegue mira a ridurre gli spazi di manovra. Così commenta Sartre la vicenda del c.d. uomo col magnetofono (v. esempio n° 3): “Alcuni parleranno di transfert mal liquidato, ma che cosa rispondergli se ci dice che la guarigione del malato deve incominciare dal guardarsi in faccia e divenire un’impresa comune dove ciascuno accetta i propri rischi e si assume le proprie responsabilità? (…) Questo soggetto desidera comprendersi in quanto soggetto ferito, deviato, in assenza di una collaborazione intersoggettiva “passa all’atto”: questo significa capovolgere la prassi e nello stesso tempo la situazione. Nel dialogo i ruoli si capovolgono e l’analista diventa oggetto. Per la seconda volta l’appuntamento dell’uomo con l’uomo è mancato. Questa storia che alcuni giudicheranno buffa è la tragedia dell’impossibile reciprocità”.
L’intersoggettività
È un vero enigma l’intersoggettività che è una questione completamente estranea alla moderna sanità che invece è legata alle gerarchie, ai processi decisionali senza verifiche, all’assenza di analisi epidemiologiche, alle prestazioni con relative pesature economiche e, per finire, legata al feticcio delle “evidenze” che è tale, soprattutto nel campo della salute mentale, quando nega l’importanza della relazione e del contesto. Se potessimo permetterci un’immersione nella dimensione profondamente interpersonale dell’esperienza clinica potremmo apprezzare la fragile sensazione di reciprocità con l’alterità che molti agiti ci comunicano in modo potente ma enigmatico, come un linguaggio sconosciuto e fastidioso, come una di quelle versioni dal latino o dal greco da tradurre con molta pazienza e che ci esercitavano nel riprendere le regole apprese e a riconoscere le eccezioni irregolari.
Poche sono le fortunate personalità in grado di rendere il proprio nodo conflittuale un atto creativo, per es. attraverso la pratica artistica, e sono molte di più quelle che si ritrovano purtroppo nella condizione definita da Fachinelli di “un singolare gatto selvatico” che piomba nel setting lacerando la sua messinscena abituale basata sul ruolo centrale della parola. Questo “gatto selvatico” non si lascia addomesticare facilmente e pone delle domande serie sulla relazione di cura e sullo stesso dispositivo. All’epoca, il caso riportato nell’esempio n° 3 sollevava soprattutto il tema del “potere” all’interno dell’analisi e in generale nella società ed era un tema tipico degli anni attorno al ’68.
Oggi lo stesso tema è tutt’altro che inattuale ma possiamo aggiungere una riflessione anche in merito alla stessa “talking cure” che trova negli agiti il suo limite. Il gesto oltrepassa il potere della parola e forse è la sola modalità comunicativa per coloro che non conoscono altre possibilità espressive che un linguaggio denso di contaminazioni emozionali. Come per certi tatuaggi estesi fino al punto da diventare mera decorazione riempitiva contro l’horror vacui e non messaggi da scambiare in uno spazio condiviso pur tra fronti opposti riconosciuti reciprocamente come tali, l’agito innalza delle barriere ma indica anche il problema di come inserire la barriera in un dialogo, apprezzarne la forte valenza libidica, la forzatura del setting ripetitivo e della stessa formazione ricevuta. Il problema è quindi come farne strumento di reciprocità, occasione inaspettata di apertura di nuove strade.
Un ultimo esempio e conclusioni sull’agito
Concludo con un quarto esempio, il più drammatico perché – con la morte – lascia letteralmente senza possibilità di parola. Un giovane è seguito al CSM fin dall’età di vent’anni, inseguito dal dramma di un mancato riconoscimento come soggetto per dei lutti mai elaborati nella madre e nella nonna materna. Dopo vari agiti etero e autoaggressivi che l’hanno portato a tanti ricoveri e persino in una REMS, trova una sua discreta stabilità in Comunità dove però deve alternare un’apparente bonomia un po’ fatua ad un mondo interno denso di inquietudine ontologica di cui lascia trasparire solo segni indiretti: scrive pagine di formule astruse sulla consistenza delle sue ossa che raramente cadono sotto gli occhi degli operatori perché per lo più le getta nel water ostruendolo ed è dal numero di ostruzioni che si intuisce l’intensità del suo lavorio nascosto.
Al termine di una passeggiata silenziosa, è solo attraverso il cancello della struttura che finalmente parla e rivela al suo psichiatra un suo progetto: scrivere un testo sull’australopiteco. La separazione fornita dal cancello sembra giovare alla relazione come accaduto tempo prima quando è serenamente ingessato dopo una defenestrazione e si dedica tranquillamente alla fisioterapia. Cancello, gesso, water sono oggetti e luoghi attraversati dai suoi gesti e sono anche gli unici spazi psichici concessi all’interlocutore.
La svolta decisiva avviene dopo un colloquio in cui lo psichiatra gli dice che la madre parlerà del suo caso in un lavoro di raccolta di storie per il Museo della Mente. ”E se fossi contrario?”, ribatte. Lo psichiatra cerca di rassicurarlo: “Allora, ne dovremmo riparlare”. Il giorno dopo si impicca proprio nel bagno in cui ha eliminato i suoi scritti. Una sua poesia lasciata leggere pochi giorni prima parla di “speme” e della vocale “o”. Lo psichiatra è colpito dall’apparente opposizione di questi due elementi. La tragica evoluzione del caso costringe lo sconsolato curante ad un approfondimento intriso di autorimprovero per quello che pensa essere stato un suo agito determinante.
Nel suo tormentato lavoro ritrova quanto scrive Freud sull’inconscio che non conosce il “non”, come accade per i sogni in cui “o…o” in realtà si traduce “e…e” e in generale sulla compresenza dei contrari nelle lingue antiche, come nei sogni di tutti noi (“Significato opposto delle parole primordiali”, 1910).
La conclusione di Freud è un invito ad affinare l’ascolto dei tanti “gatti selvatici” o “australopitechi” che incontriamo nella clinica e che ci pongono il problema di come gestire una difficile reciprocità di interlocuzione, linguistica ed emozionale, che gli agiti ci propongono come linguaggi astrusi e incomprensibili: “Nella concordanza tra la singolarità del lavoro onirico … e la prassi adottata dalle lingue più antiche … ci è consentito di vedere una conferma alla nostra concezione del carattere regressivo, arcaico dell’espressione del pensiero nel sogno. E a noi psichiatri s’impone, come congettura irrecusabile, il fatto che la nostra comprensione e traduzione del linguaggio sarebbe migliore se fossimo più informati sull’evoluzione della lingua”.










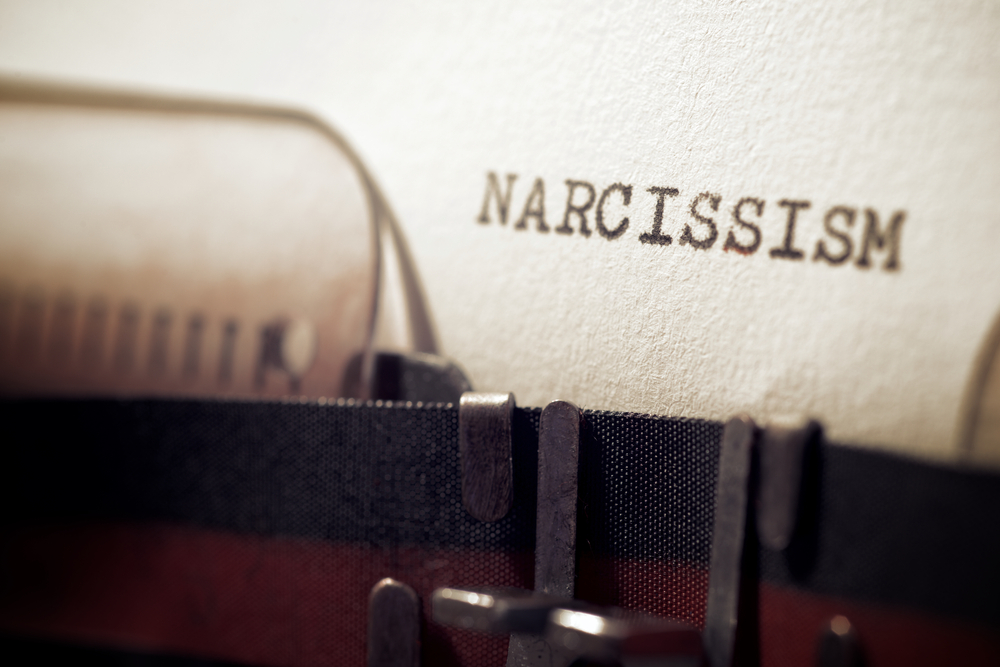








L’Autore va veramente ringraziato per questa ricca e accurata esposizione del problema.
Mi chiedo se l’agito, oltre a costituire una pietra d’inciampo – e magari rischiosa – nel trattamento, possa comportare anche qualche risvolto positivo: potrebbe costituire un segno, nel senso ammirevolmente definito tanti secoli fa dai pensatori stoici: segno è ciò che indica una cosa oscura. Ed è possibile che venga volutamente messo in atto, in ambito terapeutico o meno. Alcuni atti di Bergoglio (certo non tutti ) lo sono: quando indossa un poncho argentino vuol mandare un messaggio.
Quanto all’altro risvolto, il possibile agito del terapeuta, è stato in passato volutamente messo in atto. Qualcuno, mi pare Rogers, aveva un paziente con fantasie grandiose: dichiarava di essere persona importante, che poteva ottenere oggetti e servizi senza pagare: il terapeuta lo prendeva alla lettera, mettendo alla prova del reale questa sua fantasia, con le immaginabili conseguenze. Discutibile, certo.
E Sechehaye, terapeuta di uno psicotico, è entrata nella sua cameretta molto sporca sedendosi a terra al suo fianco: lui ha reagito dicendo “io sarò quel che sono, ma so come ci si comporta con una signora”, e le ha porto la mano per farla alzare.
Credo che fondamentale sia che il terapeuta sappia perchè fa un certo agito.
E’ meglio precisare che gli interventi che ho ricordato non sono propriamente acting, in quanto animati da precise intenzioni terapeutiche, magari con componenti pedagogiche. Si avvicinano piuttosto alle azioni parlanti di Racamier
Molto belle queste pagine sull’agito. Dense di umanità e portatrici di incertezze.