A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il suo sguardo resta una bussola per leggere la politica contemporanea.
Pasolini diffidava della sinistra quanto della destra. Non per spirito di contraddizione, ma perché riconosceva nella cristallizzazione delle idee un segno di decadenza.
La sua eresia nasceva dal rifiuto della stasi intellettuale: pensare significava non appartenere.
La stasi nel discorso pubblico
Oggi quella stasi domina il discorso pubblico. Il conflitto tra schieramenti è diventato permanente, ma svuotato di contenuto.
La contrapposizione non serve più a produrre pensiero, bensì a garantire equilibrio di potere.
Il governo e l’opposizione si legittimano a vicenda: esistono solo in quanto nemici.
È una forma di sopravvivenza politica, non di analisi.
Nel frattempo le questioni essenziali – povertà, accesso alla casa, disuguaglianza economica, guerra – restano sospese, perché affrontarle imporrebbe un lavoro di comprensione che la politica non sembra più in grado di compiere.
Scissione, proiezione e negazione
Chi lavora con la mente umana conosce bene queste difese.
Scissione, proiezione e negazione sono meccanismi che l’individuo usa per non affrontare ciò che lo minaccia.
Oggi la società li riproduce su scala collettiva.
La paura della complessità viene spostata sul piano del confronto ideologico: l’altro diventa contenitore del male, il nemico da neutralizzare.
È un processo di semplificazione che protegge dal dubbio, ma impedisce la conoscenza.
Il correntismo politico
Il correntismo politico funziona come una difesa narcisistica.
Offre identità e sicurezza, ma riduce la capacità critica.
Il dibattito si appiattisce sul linguaggio di gruppo, dove ogni parola serve a confermare l’appartenenza.
L’adesione prende il posto del pensiero.
Così la politica, invece di elaborare la propria crisi, la ripete.
La guerra in Medio Oriente mostra chiaramente questa dinamica.
Viene spesso presentata come un conflitto “religioso”, un’etichetta che rassicura ma non spiega.
È una riduzione difensiva: traduce in categorie morali una realtà storica e geopolitica complessa.
Nel discorso pubblico, su Israele si proietta l’immagine della potenza economica e militare, la figura di chi domina e opprime; la Palestina diventa simbolo dei poveri, degli ultimi.
Chi sostiene Israele, al contrario, proietta su Gaza l’integralismo islamico, la violenza terroristica, la minaccia incontrollabile.
In entrambi i casi la realtà viene trasformata in metafora emotiva.
Non ha senso fornire giudizi: più utile è osservare come questi meccanismi agiscano, come servano a contenere l’angoscia invece che a comprendere i fatti.
Le difese dell’Io
Psicologi e psichiatri, per formazione, sanno leggere le difese dell’Io.
Potrebbero farlo anche nella sfera pubblica, riconoscendo le difese della collettività.
Non per moralizzare, ma per riportare la politica alla sua funzione analitica: distinguere, capire, elaborare.
Una società che sostituisce la riflessione con la contrapposizione si comporta come un paziente che teme la propria verità.
Il conflitto, in sé, non è patologico.
Lo diventa quando serve solo a evitare il pensiero.





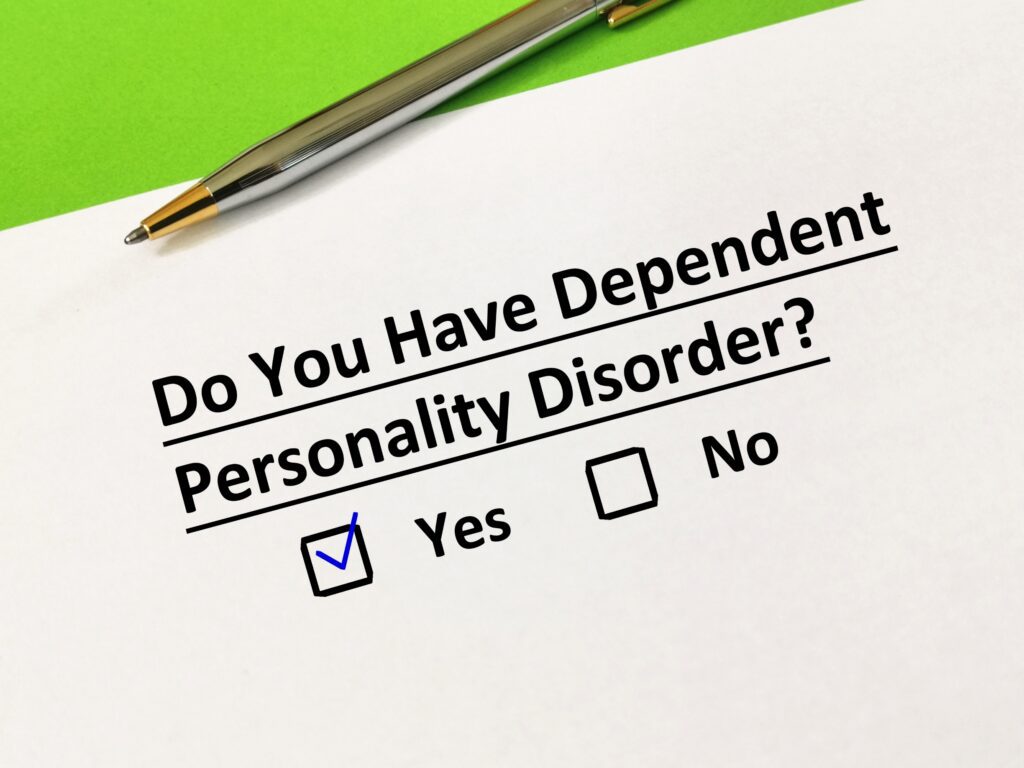












Mi piace nella sua chiarezza
Mi dispiace nella sua impossibilità di espandere questa chiarezza che mi sembra così comprensibile
Ma forse noi siamo di una complessità incurabile così dice la storia