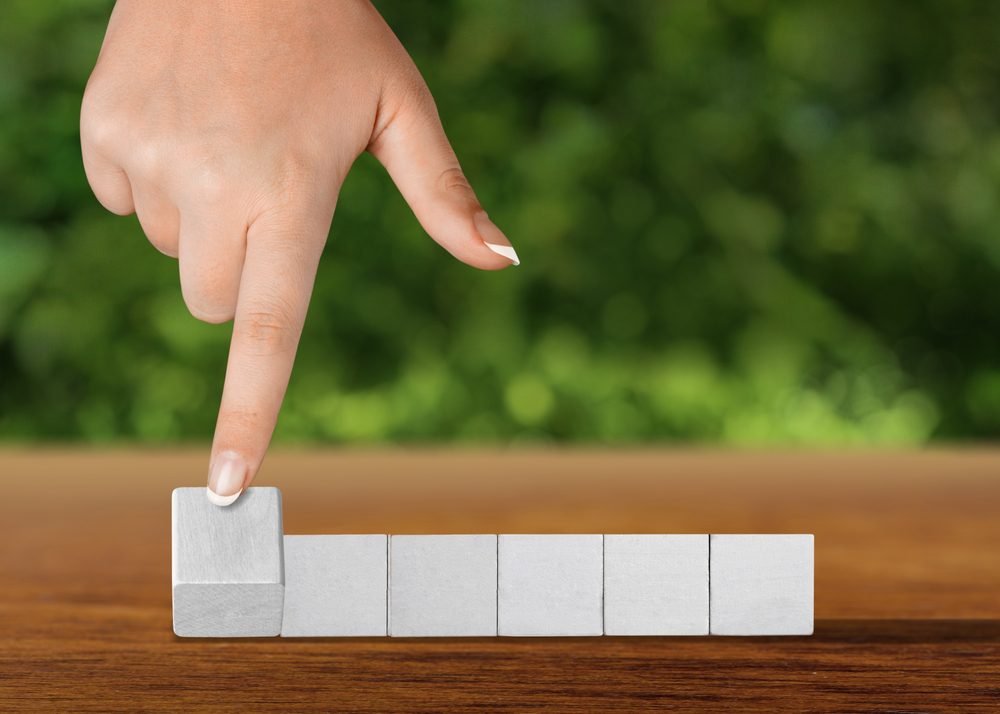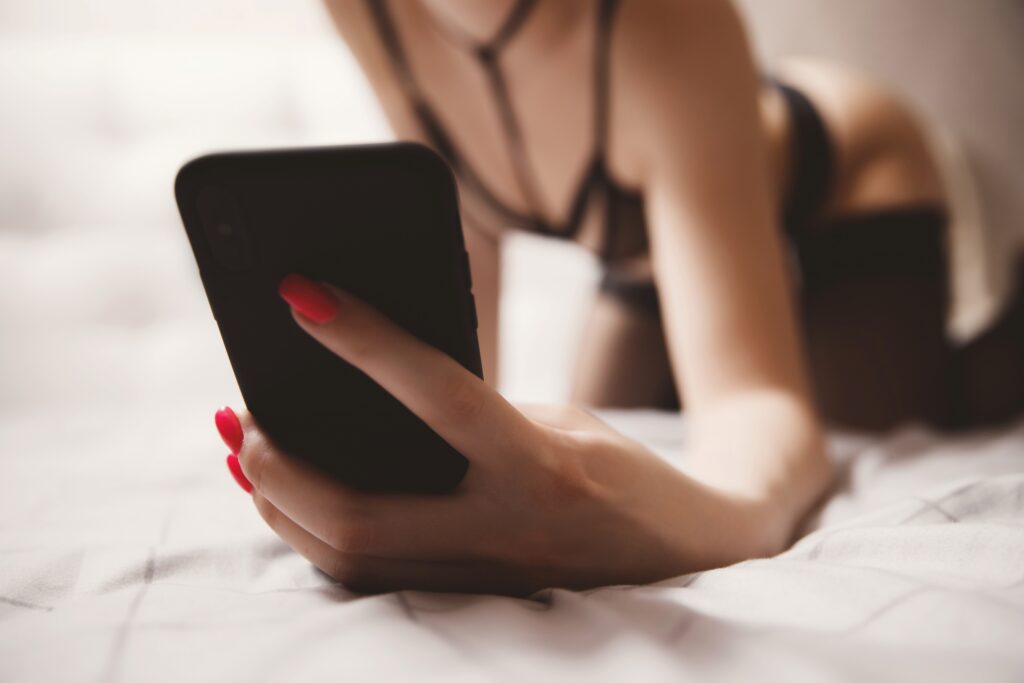La storia è ormai nota: due donne si presentano davanti al re Salomone chiedendo entrambe l’affidamento del neonato che una delle due teneva in braccio. Secondo il racconto biblico, ciascuna sosteneva di essere la madre del bambino, e sembrava impossibile giungere a un accordo o stabilire con assoluta certezza chi fosse la vera genitrice. Salomone, con un lampo di genio, risolse brillantemente la questione proponendo — in modo paradossale — di dividere il bambino a metà, così che ognuna ne avesse una parte. Naturalmente, la vera madre, tra le lacrime, scongiurò il re di salvare l’infante e di donarlo all’altra donna. Nulla da dire: brillante risoluzione di un caso difficile, non senza una certa dose di rischio. Certo, dividere il bambino in parti uguali sarebbe stato, in un certo senso, “statisticamente” corretto… ma umanamente? Non serve nemmeno rispondere.
L’utilizzo degli asterischi per promuovere l’uguaglianza
Questo racconto mi è tornato in mente stamattina, mentre leggevo un interessante articolo sulle politiche legate alla nostra professione. A un certo punto mi sono accorto di essere stanchissimo: non per i contenuti, che erano profondi e stimolanti, ma per la presenza di numerosi asterischi che sostituivano l’ultima lettera delle parole, nel tentativo di rendere “neutri” tutti i sostantivi. Statisticamente è l’unico modo corretto per evitare l’uso del genere maschile o femminile nella lingua italiana per riferirsi a una persona. Ma siamo sicuri che sia “giusto”?
Moralmente è lodevole, probabilmente è utile solo in superficie — come un bellissimo pacco regalo dal contenuto poco entusiasmante — e stilisticamente, diciamocelo, è un po’ bruttino. Le intenzioni dell’autore erano probabilmente quelle di promuovere il concetto di uguaglianza. Ma che cosa vuol dire essere uguali? Salomone voleva dividere equamente il bambino in parti, ma non sembrava una grande idea. Sforzarsi di livellare artificialmente tutto nel tentativo di distribuire giustizia in parti uguali è un grande rischio, oltre che qualcosa che stride con la realtà delle cose: un mondo migliore per qualcuno – per citare il protagonista della serie Handmaid’s Tale – è necessariamente un mondo peggiore per qualcun altro.
Jung metteva in guardia dall’identificazione con quella che chiamava la Persona, ovvero la maschera prosociale che tutti indossiamo per coesistere con gli altri. Ammoniva che aderire troppo al pensiero collettivo poteva comportare una perdita di identità personale: magari si conduce una vita tranquilla, ma non una vita individuata, cioè realizzata secondo la propria predisposizione innata. Un’uguaglianza forzata, priva di basi solide, rischia di diventare un appiattimento incolore.
Uguaglianze e diversità
Ma allora, la soluzione è forse nella disuguaglianza? Homo homini lupus? Affatto. È un termine che evoca ingiustizie sociali che non sono mai tollerabili. Citando Guggenbühl-Craig, direi piuttosto che la soluzione sta nella diversità:
«Ognuno di noi è favorevole all’idea dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani — dice ne Il Vecchio Stolto, ragionando sui diversi e molteplici modi di essere delle varie culture — ma come si presenta la realtà culturale, politica, sociale così com’è, e non come la desideriamo? Noi siamo tutti diversi, non soltanto come singoli individui, ma ancor più come gruppi. Nessun essere umano è uguale a un altro, né vi sono famiglie, popoli o razze fra loro uguali. Dovunque ci voltiamo non vediamo altro che diversità. Come è stato allora possibile arrivare alla grottesca idea dell’uguaglianza?»
È una domanda centrale, che può essere risolta solo abbandonando il punto di vista basato su chi è “migliore” o “peggiore”. Essere diversi non implica superiorità o inferiorità: la diversità per come la intendo implica movimento, confronto, e a volte anche incomprensione — e questo è foriero di sforzi per capire cosa si muove nell’altro, questo misterioso Altro che secondo Lacan incarna il nostro Desiderio. Il terapeuta ad esempio deve sapere che ogni paziente che incontra è diverso da quello precedente; altrimenti, finirà per applicare sempre le stesse procedure e dire sempre le stesse frasi fatte ad ogni sessione.
Coltivare le diversità
L’uguaglianza vale solo per i diritti. Guai, però, a cercare di indirizzare tutti i pazienti verso la stessa “strada giusta”. Come dice von Franz, non dobbiamo assolutamente avere una teoria su come l’essere umano dovrebbe essere “normale”. Coltivare la diversità e sottolineare le differenze — in un’ottica di curiosità verso l’altro — è fondamentale. Come lo è, a volte, riconoscere che esistono persone (e parti interne) completamente diverse da noi, con cui non ci piaceremo mai, ma che dobbiamo imparare a tollerare. E dunque, dobbiamo trovare necessariamente un modo per convivere.
Per questo, dal mio punto di vista, preferisco sottolineare le differenze piuttosto che forzare l’uguaglianza. Meglio quindi — citando di nuovo l’articolo — non essere tutti psicolog* ma piuttosto psicologhe e psicologi. Anche perché, diciamocelo, scriverlo in modo esteso non costa poi tanta fatica… e, in fondo, è tutta un’altra lettura.