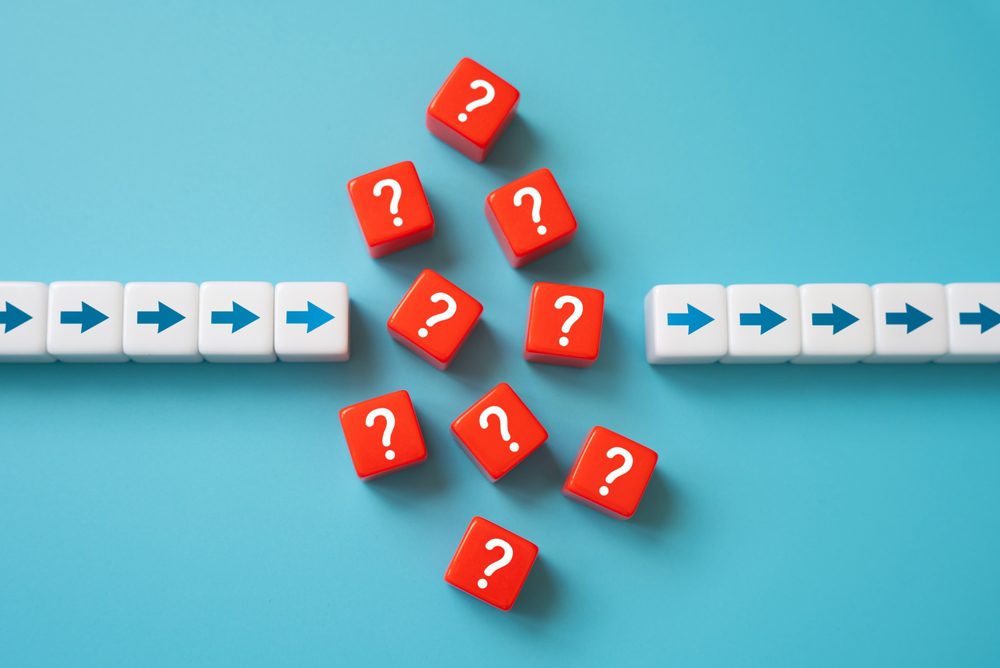“Sono stanco”. Ho ormai smesso di contare le volte che, in studio, ho sentito questa frase pronunciata da qualche mio paziente: la stanchezza a cui si riferivano non era quella fisica, né la tipica stanchezza da stress acuto, generata ad esempio da una conflittualità familiare o da un lavoro eccessivamente esigente. Quella si riconosce subito, già dalla mimica e dall’intonazione. La stanchezza di cui parlo è invece di natura esistenziale: la sensazione di “non arrivare mai”, o di essere “sotto scopa” – per riportare le parole di diversi pazienti – che dà l’impressione di essere incastrati in una routine fatta di infinite scadenze, persino nei giorni cosiddetti liberi, che liberi non sono mai. Sono infatti sempre colmi di eventi sociali o di incombenze rimandate durante la settimana.
Bedtime Revenge Procrastination
Questa forma di stanchezza viene descritta come un’impossibilità a recuperare energie, uno stato di sonnolenza perenne che non trae beneficio né dal riposo notturno né da qualche pisolino pomeridiano. Eppure, paradossalmente, molte persone – pur percependosi esauste – tirano avanti fino a tardi per ritagliarsi qualche ora di svago, spesso davanti alla TV o coltivando un hobby. È proprio da questo fenomeno che nasce la mia riflessione: esso ha un nome preciso, Bedtime Revenge Procrastination. In sostanza, le persone ritardano l’andare a letto come forma di piccola ribellione per rivendicare il diritto ai propri spazi di libertà, nonostante pressioni sociali e lavorative. Nato in Cina e diffusosi rapidamente in tutto il mondo, questo comportamento è emblematico di come alla base di molta stanchezza percepita vi sia un rapporto passivo con il tempo, più subíto che realmente vissuto.
La nostra routine quotidiana è segnata dalla mancanza di tempo, alla quale cerchiamo di porre rimedio incastrando impegni, spesso scivolando in un multitasking altamente improduttivo. La sensazione di non riuscire mai a raggiungere gli obiettivi o a rispondere alle numerose richieste deriva solo in parte da un nostro atteggiamento di autoschiavismo. Non possiamo ignorare l’elevata richiestività performativa dell’ambiente: lo sviluppo tecnologico e comunicativo, invece di alleggerire il carico lavorativo, ha favorito l’accumulo di ulteriori compiti che si insinuano negli spazi liberati dagli stessi strumenti tecnologici.
L’urgenza cronica
Se durante la rivoluzione industriale i macchinari non hanno liberato gli operai dalla fatica ma li hanno costretti a turni massacranti, oggi l’estrema reperibilità garantita dai dispositivi digitali ha creato una condizione di urgenza cronica. Numerosi studi di psicologia del lavoro mostrano come il flusso costante di email e riunioni online incida negativamente sulla produttività, sulla performance e sul benessere lavorativo.
Ma non si tratta solo dell’ambito professionale: nella vita quotidiana abbiamo interiorizzato questa fretta, questa pulsione a saturare ogni spazio libero con ulteriori impegni. Persino ai bambini non è più concesso il tempo di giocare o annoiarsi, presi come sono da mille attività tra scuola, sport e corsi vari. Ciascuna di queste attività è utile e preziosa per lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo; tuttavia, sommate tutte insieme, rischiano di trasformarsi in un vero e proprio cappio psicologico. Ricordo ancora un aneddoto di anni fa: un genitore, fiero, mi raccontava di prelevare i suoi due figli da scuola per portarli in un’altra città a seguire un corso di diverse ore, aggiungendo con soddisfazione che i bambini svolgevano i compiti durante il tragitto in auto, sia all’andata sia al ritorno. Un caso forse estremo, ma altamente indicativo.
L’autoschiavitù
La stanchezza che viviamo oggi non è quella che il filosofo Byung-Chul Han definisce “stanchezza fondamentale”, ossia la fisiologica spossatezza derivata dall’interazione con gli altri nel corso della giornata. È piuttosto una stanchezza diversa, direi patologica, generata da un’autoschiavitù che ci imponiamo e che ci viene caldeggiata dalla società in cui siamo immersi. Perché questo? Difficile dare una risposta univoca, ma si può anche pensare che il “fare” sia un antidoto al vuoto: come sottolinea Yalom, una delle più grandi paure dell’essere umano – accanto alla morte – è la libertà, che lo mette di fronte alla solitudine: l’assenza di una struttura esterna espone al vuoto, e con esso all’angoscia esistenziale della mancanza di senso nella vita. Fare qualcosa vuol dire in qualche modo identificarsi con un ruolo, un lavoro, un hobby, una idea e così via, quindi sentirsi necessari.
Non sorprende dunque che cerchiamo di riempire quel vuoto in ogni modo possibile, trasformando persino le festività natalizie in un affannoso susseguirsi di acquisti, cenoni e organizzazione di immancabili serate di Capodanno che tutti dichiarano di detestare, ma che puntualmente si ripresentano. Continuiamo a fare tutto ciò pur lamentandoci, perché questa forma di angoscia – a mio avviso – risulta più tollerabile dell’angoscia del vuoto e dell’assenza di senso che potrebbero derivare dalla noia o dall’inazione.
Ma noia ed inazione sono davvero concetti così terribili? Ne discuteremo nel prossimo scritto.