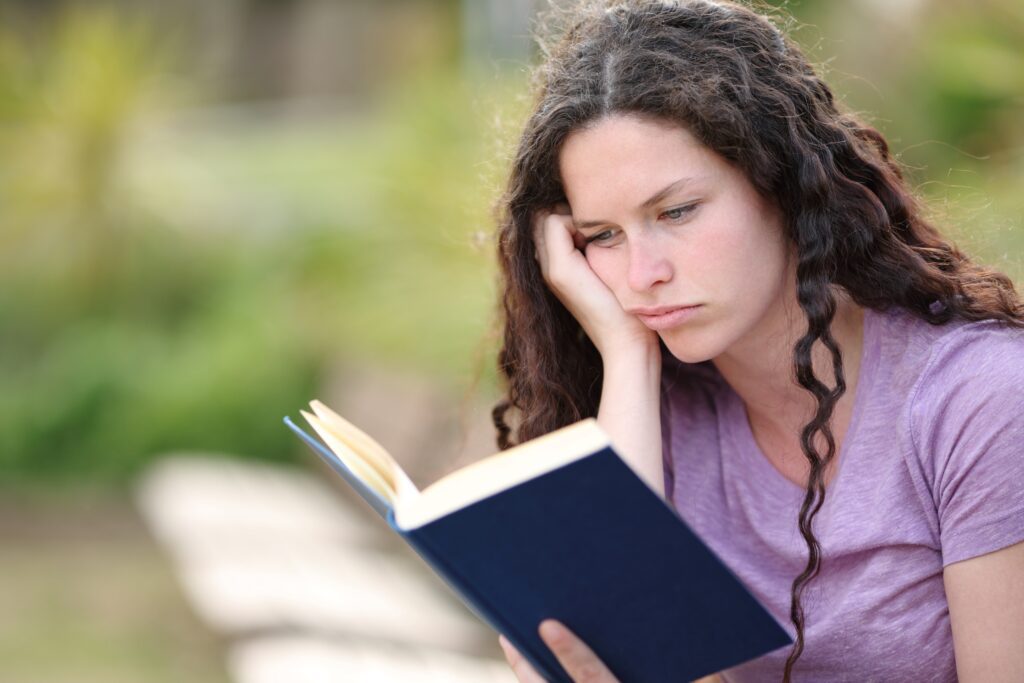Nella seconda metà degli anni 90, il nostro gruppo ha avuto il privilegio di fare formazione con il prof. Zapparoli, il quale, attraverso incontri a Milano quindicinali, ci ha insegnato a modulare e ad interpretare clinicamente le nostre volenterose osservazioni.
Allora le Comunità del gruppo Redancia erano ancora poche ed ospitavano pazienti perlopiù psicotici. Per noi giovani forse più complessi dei “border”, meno immediati, più distanti, più delicati.
Chi ha partecipato a questi gruppi ricorda la fatica, l’impegno e la tensione che corollavano un viaggio che dopo l’incontro con il professore si trasformava in una liberatoria goliardia intorno ad una tavola.
Zapparoli mi ha insegnato le basi del lavoro comunitario, o meglio, mi ha aiutato a diventare un operatore di comunità a dare un senso alle frasi che mi dicevano i pazienti ed a comprenderne il significato.
Ho ritrovato tra i miei file questo scritto, portato forse ad un convegno e forse pubblicato sulla nostra rivista cartacea.
Mi pare attuale ciò che vi è scritto, mi pare applicabile il pensiero di Zapparoli non solo ai pazienti psicotici, bensì a tutti i pazienti che parlano il complesso linguaggio della sofferenza.
Dal suo insegnamento trapela il rispetto per l’altrui persona. Rispetto che oggi spesso è dimenticato.
Si ritiene utile suddividere in due parti questa esposizione del modello di lavoro proposto dal Prof. Zapparoli, in quanto il materiale esposto rischia di apparire pesante al lettore ed altresì la nostra intenzione è fornire la possibilità di riflettere sui temi, valutare paragoni con l’attualità e naturalmente lasciando occasione per commentare e fornire altro materiale di riflessione.
Modello di intervento integrato
La prospettiva di Zapparoli ( 1979) è quella di dividere gli psicotici in 3 gruppi, utilizzando elementi diagnostici basati sulle condizioni attuali e sulla storia maturativi ed evolutiva, per arrivare ad una valutazione delle caratteristiche strutturali e dinamiche del pz , individuandone potenzialità e risorse.
Al primo gruppo appartengono pz che conservano tali potenzialità in modo sufficientemente ampio per raggiungere un discreto livello di emancipazione e di autonomia.
Al secondo pz che, pur presentando certe capacità evolutive potranno mantenere un funzionamento adeguato solo avendo sempre a disposizione una equipe terapeutica da utilizzare ogni volta che se ne presenti il bisogno.
Nel terzo gruppo infine vi sono pz con necessità di dipendere costantemente da una istituzione o gruppo che svolga funzioni vicarie e protettive , permettendo la saturazione di bisogni di base legati alla sopravvivenza, vale a dire quei pz nei quali sono minime le potenzialità evolutive ( concetto del 3per4).
Queste considerazioni delineano un paradigma volto al superamento della lotta di potere fra psichiatria e psicologia, fra l’una e l’altra tecnica o scuola per assicurarsi il ruolo di unica risposta terapeutica alla patologia psicotica.
Sul piano clinico la diagnosi funzionale è il primo passo verso l’impostazione di un intervento integrato.
Il trattamento deve essere finalizzato a seconda del livello dell’inadeguatezza strutturale di base dello psicotico e la fase della malattia ( acuta, subacuta e cronica), tenendo conto delle maggiori o minori potenzialità evolutive e della presenza o meno di angoscia.
In caso di deficit marcato si rende maggiormente necessaria una PROTESI, quindi saranno più marcati gli interventi assistenziali e framacologici, volti a mantenere una condizione di relativo funzionamento, a prevenire crisi acute o un ulteriore deteriorarsi delle già ridotte capacità.
In caso di maggiori potenzialità emotivo-evolutive, le tecniche psicologiche avranno più spazio nel trattamento, affiancate da assistenza e farmacoterapia nella misura i cui il pz non possiede ancora sufficienti risorse e la forza dell’Io necessarie per un funzionamento autonomo.
Durante la fase acuta i farmaci avranno un ruolo essenziale anche se non esclusivo, per contenere il carico eccessivo di angoscia e favorire una riorganizzazione della personalità, mentre successivamente, pur essendo utilizzati per diminuire la vulnerabilità al panico, potranno essere ridotti.
Così come l’assistenza e la riabilitazione, nei vari momenti della malattia, avranno caratteristiche e finalità diverse.
Una reale integrazione del progetto terapeutico nelle sue varie articolazioni può fondarsi soltanto su una solida interazione dell’equipe.
Tale condizione sottolinea Zapparoli ( 1994) viene raggiunta costituendo un linguaggio comune che nasca dal riconoscimento dei bisogni specifici dello psicotico, dall’ascolto attento degli insegnamenti che al riguardo il pz ci dà.
I bisogni specifici dello psicotico
La definizione di bisogno più corrente è quella che rinvia ad uno stato di tensione generato dalla mancanza di un qualcosa necessario per soddisfare esigenze fisiologiche, psicologiche o sociali.
I bisogni peculiari degli psicotici sono difficilmente riconoscibili dalla maggioranza delle persone perché caratterizzati da una diversità che suscita rifiuto.
Per meglio comprendere la configurazione che i bisogni assumono nello psicotico è necessario ricordare che è caratteristica comune uno sviluppo difettoso. Traumi precoci ostacolano il costituirsi di un sè organizzato e compromettono il funzionamento dell’ io.
Alla base di tali traumi vi è una relazione inadeguata con la figura materna, specie per quel che riguarda l’accudimento.
Il risultato, espresso in termini diversificati da vari teorici, è sempre l’impossibilità di attingere da un’esperienza interna di gratificazione su cui fondare una introiezione di oggetti positiva.
La dipendenza si configura così come forza distruttiva da cui difendersi. Ma queste persone sono al tempo stesso dipendenti, per mancanza di una solida struttura interna di regolazione e di controllo e sono bisognose degli altri.
Questa estrema dipendenza nei confronti di un oggetto esterno è alla base di una profonda paura dell’oggetto stesso. Paura di essere abbandonato o paura dell’influenza che può esercitare.
I bisogni dello schizofrenico si articolano dunque lungo questa lacerazione interna, con espressioni contraddittorie.
Zapparoli (1954) le ha descritte così:
- Bisogno di un oggetto inanimato
- Bisogno di continuità
- Bisogni relativi alla condizione simbiotica
- Bisogno di non avere bisogni
Bisogno di un oggetto inanimato
Lo psicotico, per le esperienze traumatiche subite, per la sensazione di profonda vulnerabilità, deve esercitare un controllo sugli altri, specie sulle persone più significative e deve difendersi dai cambiamenti, che compromettono la sicurezza.
Questa sicurezza è quindi favorita, soprattutto all’inizio del rapporto, dal fatto che lo psicotico possa mantenere i membri dell’equipe nel ruolo di oggetto inanimato. Viverli cioè come inattivi, non orientati verso iniziative vissute come pericolose, considerarli come un oggetto da prendere e riporre o una radio da accendere e spegnere a proprio piacimento.
Su questa base il pz talvolta sceglie quale interlocutore privilegiato l’infermiere o un altro operatore addetto all’assistenza (l’operatore non qualificato). Per il ruolo che svolgono tali figure vengono avvertite come meno qualificate professionalmente rispetto ad es allo psichiatra, prive di autorità, quindi meno pericolose, tali da poter essere relegate, in maniera rassicurante in una condizione passiva.
La capacità di queste figure professionali meno connotate dal punto di vista del potere di mettersi a disposizione del pz, è talvolta l’unica chiave che permette di aprire ad ulteriori iniziative terapeutiche, una porta altrimenti inaccessibile.
Bisogno di continuità
Per le ragioni evolutive che abbiamo espresso precedentemente, lo psicotico sul piano pratico necessita di un appoggio esterno che gli consenta di assumere le funzioni indispensabili all’autoconservazione, o che si faccia carico delle esigenze legate alla sopravvivenza.
Chi fornisce, genitore o parente o comunita terapeutica, tale appoggio deve vivere per tutta la vita che vive lo psicotico.
Solo l’equipe terapeutica, pur nell’avvicendamento degli operatori, può fornire tale continuità (Continuità di funzione).
Persone diverse possono svolgere la stessa funzione.
Bisogni relativi alla condizione simbiotica
La fusionalità non è idonea all’autoconservazione. In tal caso qualsiasi stimolo che si configuri come attacco al legame simbiotico, rappresenta una minaccia alla sopravvivenza, suscitando opposizione ed aggressività in entrambi i membri della coppia.
L’unica attività consentita è il delirio, in quanto non modifica la condizione di dipendenza.
L’accettazione dell’ estraneo può iniziare a realizzarsi soltanto ricevendo precise garanzie che verrà rispettato il bisogno fusionale.
Secondo Zapparoli (1988) è spesso utile programmare una serie di incontri con la coppia simbiotica. Dati successivi ci permetteranno di capire se questa incapacità del pz di vivere come individuo separato (perché separazione è uguale a morte) potrà aprirsi o meno a prospettive future di emancipazione.
Bisogno di non avere bisogni
È la negazione onnipotente della realtà dei propri bisogni.
Può essere espressa a livello sintomatico con la convinzione delirante che il cibo sia avvelenato, che permette di non sottostare al bisogno primario della fame.
Può essere espressa nei confronti della parte deficitaria che crea limiti e determina la necessità di aiuto: rifiuto di ogni tipo di intervento, oppure accettazione dello stesso solo se imposto da un “persecutore” nei confronti del quale si sentono paura e odio e non dipendenza, tradimento dei curanti che vengono abbandonati per cercarne altri, opposizione a proseguire programmi terapeutici dimostratisi efficaci.