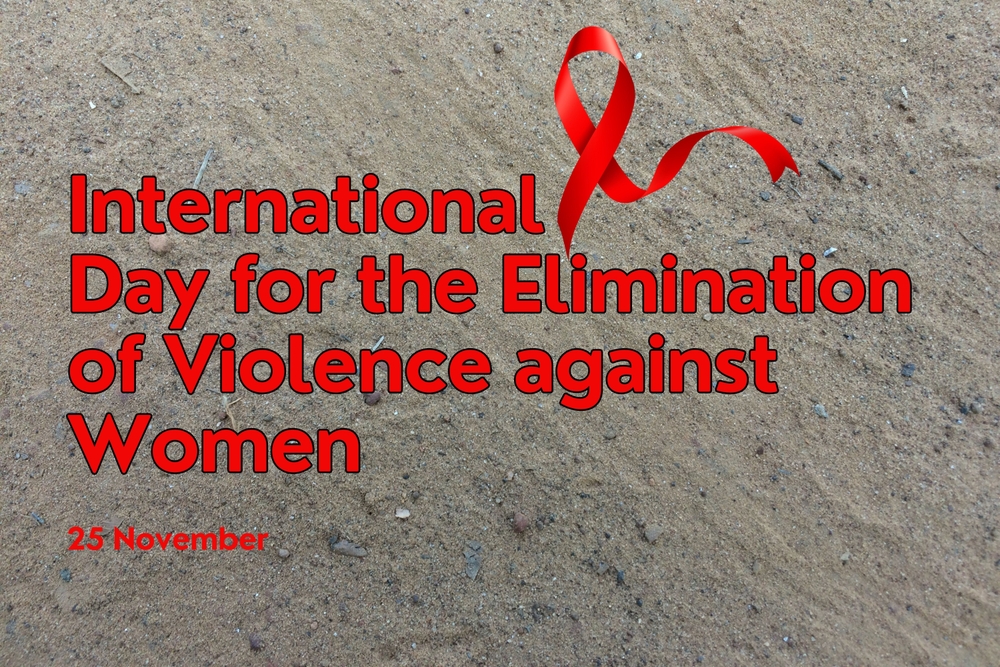Il nuovo intervento di Enrico Di Croce sul problema degli immigrati mi stimola a parlare di una situazione da me vissuta come perito, e a un tempo estrema ed esemplare.
Si tratta di un ragazzo – sui vent’anni quando incrocio il suo percorso – originario del Mali: sede, ai tempi dei tempi, di consolidata struttura statale – l’Impero del Mali – ma adesso, specie nei decenni 2010 – 2020, tormentato da scontri etnici, guerre intestine, tentativi di secessione, intervento “pacificatorio” francese.
Il ragazzo perde padre e un fratello, uccisi in questi scontri. Ragionevolmente, decide di fuggire dal paese per raggiungere un altro fratello che è riuscito a insediarsi stabilmente in Francia. Entra in Italia da clandestino, viene collocato in un Centro di accoglienza a Catania, ne evade, riprende il suo percorso verso la terra promessa francese. Fermato al confine dagli agenti, non lo tollera, reagisce con violenza. Viene fermato. Il comportamento rimane aggressivo, soprattutto nei confronti di forze dell’ordine e agenti di custodia, per 8 – 10 giorni, poi si fa adeguato.
Lo vede un Perito, che ritiene – credo giustamente – la sua condotta esplosiva e aggressiva secondaria alla condizione esistenziale di sradicamento e confinamento nella precarietà di migrante, con risposta violenta vissuta come “autodifesa”. Successivamente lo vedo io in carcere, dove il contegno è del tutto riordinato . Dice di trovarsi male neppure qui, di essere ben trattato; ma poi aggiunge che “non c’è salute e bene in prigione; non c’è niente da fare” . Vorrebbe tornare a Catania, ma solo perché spera di poter ottenere lì i documenti che gli consentano di entrare finalmente in Francia. Non ha notizie della madre, ma non ne sembra preoccupato: ne parla solo se sollecitato. Fra l’altro la comunicazione verbale è ostacolata dalla differenza di linguaggio.
Mi oriento verso una crisi di Amok, sindrome propria di ambiti culturali diversi dal nostro e di persone situate a bassi livelli socioculturali, consistente in una esplosione di violenza aggressiva, precipitata da altrui sgarbi o insulti, o da atti percepiti come tali. Con riferimento alla nostra corrente categorizzazione, essa può essere espressione di un disturbo psicotico breve o della riacutizzazione di condizione psicotica a decorso protratto.
Il punto delicato è la richiesta valutazione sulla pericolosità: ritengo probabile che, tornato in libertà e senza punti di appoggio, il periziando commetta nuovamente atti analoghi a quelli addebitatigli. Infatti, se alla base di essi sta una condizione psicotica cronica, questa è destinata a riattivarsi dopo la pressochè certa sospensione della cura che il paziente lasciato a sé stesso metterebbe in atto. Se invece l’Amok nasce dal particolare background culturale e da personale vulnerabilità, esso insorgerà nuovamente di fronte alle inevitabili contrarietà e molteplici frustrazioni.
Se dichiarassi che non c’è “pericolosità”, mi esporrei a essere quasi certamente smentito dai fatti: e fin lì, pazienza. Ma farei il danno del ragazzo: lasciato libero, ripetendo i sui gesti riprenderebbe daccapo il penoso iter che lo ha condotto a me. Dopo molte esitazioni, opto per la “pericolosità” . Segue ovviamente la collocazione in una struttura psichiatrica dove peraltro l’accoglienza è più che adeguata sia sul piano tecnico che su quello affettivo-relazionale.
Ma il suo futuro non può essere lì: sollecito, al di là dei miei compiti di perito, il SSM e l’Avvocato d’ufficio affinché si attivino per favorire, se possibile, il passaggio in Francia dove il fratello è ben disposto all’accoglienza; o, in alternativa, per una presa in carico qui, a partire dal compito più improbo: reperimento di una soluzione abitativa.
Riassumo il defatigante iter che segue: richiesta di riconoscimento di protezione internazionale, procedura come richiedente asilo, richiesta di permesso con motivazione umanitaria. Infine la situazione si sblocca, ma dopo anni. Nel frattempo, alle ripetute giuste richieste del Giudice sulla persistenza della c.d. “pericolosità”, non ho potuto che rispondere ogni volta affermativamente, poiché nulla era cambiato nella situazione. Il SSM ha difficoltà ad assumersi il peso economico di una temporanea collocazione residenziale non imposta dal Giudice. Unico elemento favorevole, la validità del rapporto che la struttura è riuscita a stabilire con il ragazzo, di alleanza anche nel fronteggiare le difficoltà.
Caso esemplare, dicevo. Un contesto disastroso, a partire dalla tragica situazione della patria di origine fino alle tensioni fra paesi europei che mirano a scaricare l’uno sull’altro il peso del migrante, all’inadeguatezza delle normative, alle lentezze burocratiche, alle difficoltà dei Servizi, si coagula in un concetto di pericolosità che scarica tutti i problemi in una mente individuale più o meno “malata”.
Questa impostazione riduttiva ed erede di una arcaica concezione del disturbo mentale è molto evidente nel caso dei migranti, ma riguarda ogni possibile autore di reato più o meno infermo mentale. Il Codice in vigore, datato sotto molti aspetti, lo è particolarmente in questo: parla di persona “socialmente pericolosa”, qualifica di cui quella psichiatrica è una sottocategoria. Naturalmente ogni perito, nel valutare la probabilità che si ripetano atti contrari alla legge, può e deve tener conto del contesto; ma il termine “pericolosità” di per sé tende a mettere in crisi questa ottica, offuscando i fattori ambientali e favorendo un etichettamento stigmatizzante. Pericolosità è solo una parola, si dirà: ma le parole sono pietre.