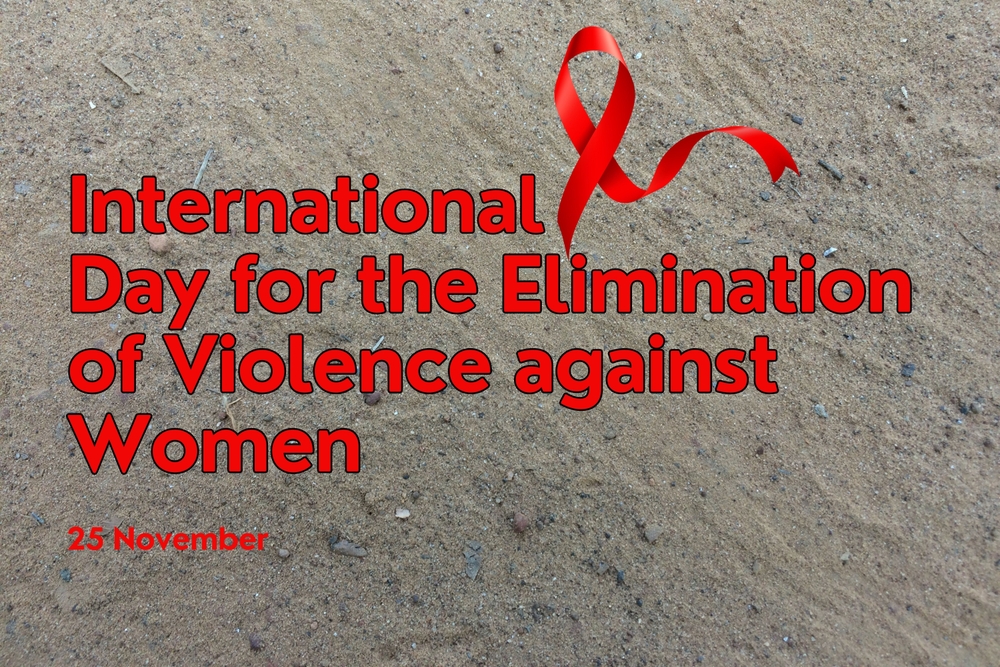Chi è messo peggio: il malato di mente o l’immigrato clandestino? Chi guida la classifica dello stigma e dello svantaggio sociale? Non saprei dire se qualcuno abbia studiato scientificamente la questione. Ma per noi che lavoriamo in prima linea, e ci nutriamo di impressioni grossolane, la risposta è scontata: messo peggio di tutti è chi cumula le due condizioni. Clandestino e “psichiatrico”. Specie se associate a una terza qualifica, di gran moda: autore di reato.
Non sono situazioni rare. Le rems si stanno riempiendo di stranieri, considerati non imputabili per un’ampia gamma di reati. Quale che sia il misfatto che hanno commesso la legge li assolve e, paternalisticamente, li obbliga a rimanere in Italia per curarsi, evitando loro il carcere e anche l’espulsione.
Ma allora per quale motivo diciamo che incarnano il massimo dello svantaggio sociale e dell’emarginazione? Per un piccolo particolare: lo stesso Stato che impone questo percorso di terapia, da svolgersi per obbligo entro i confini italiani, non concede loro i documenti per rimanere. Non hanno il diritto di vivere in Italia, anche se sono obbligati a farlo da una sentenza della Magistratura italiana. Essere soggetti a una misura di sicurezza con prescrizioni di cura non dà diritto ad una regolarizzazione documentale, nemmeno temporanea. Anzi, secondo alcune interpretazioni, è addirittura un fattore ostativo insuperabile.
Assistiamo così a un sontuoso paradosso, evidente soprattutto per i pazienti che dalla rems sono passati in una comunità: essere in libertà vigilata ostacola l’accesso ai documenti ma l’assenza di documenti impone il protrarsi della libertà vigilata. Come potrebbe infatti il magistrato di sorveglianza considerare il paziente non più pericoloso se, al di fuori della comunità, non ha modo di sopravvivere legalmente? Senza documenti non può esercitare alcun diritto di cittadinanza; né casa e residenza, né lavoro regolare, né sostegno al reddito, formazione, assistenza sanitaria. Niente di niente. Si ritroverebbe più sradicato e sbandato di prima. Facile prevedere che rischi di commettere nuovi reati (non ci vuole un luminare della psichiatria per capirlo). Quindi? L’unica cosa che può fare è rimanere dentro.
E’probabile che sia proprio questo il punto. Il sospetto è che al di sotto della apparente follia burocratico-amministrativa si celi una razionalità a suo modo lucida. L’idea, nemmeno troppo subliminale, che l’istituzione psichiatrica goda di una sorta di extra-territorialità e lo “starci dentro” sia la vera terapia, il vero presidio contro la pericolosità: non certo l’”uscire fuori” verso un percorso di reinserimento sociale. In questa ottica è perfettamente coerente non concedere i documenti che dello stare fuori, nel mondo, sono la premessa materiale e simbolica.
Mettiamola così: il paradosso kafkiano dei clandestini autori di reato potrebbe essere una specie di avanguardia distopica. La prefigurazione di un nuovo, ma in realtà vecchissimo, modello di assistenza psichiatrica, che il reinserimento sociale nemmeno più si cura di prevederlo in teoria: anzi, lo vieta per legge.