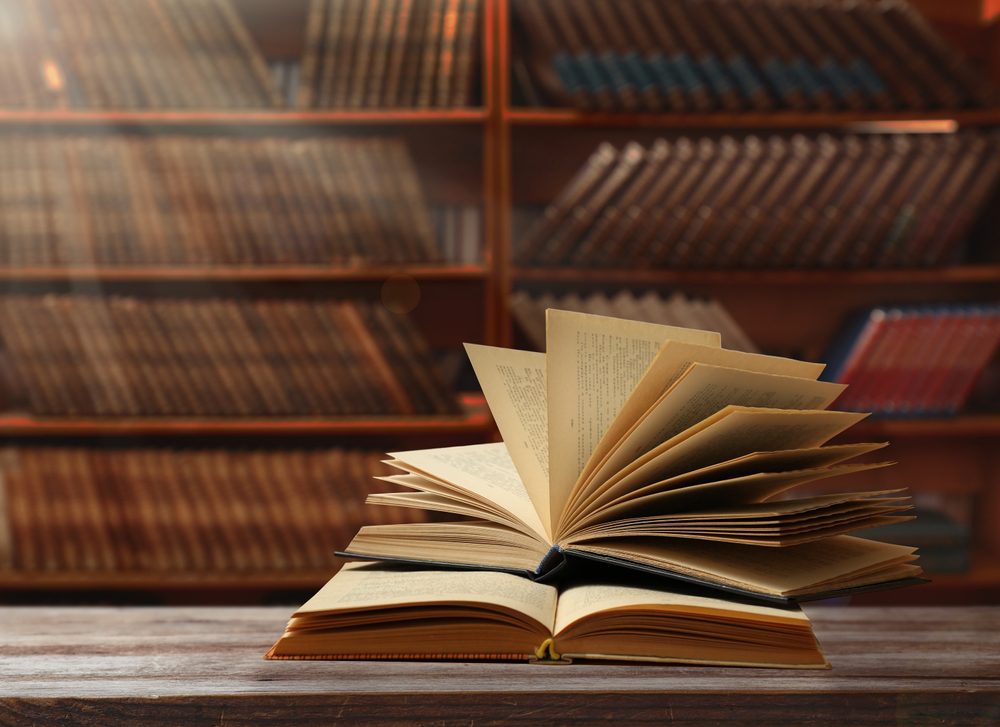Il viaggio è momento centrale dell’esperienza umana. Siamo nati viaggiatori, altrimenti non ci saremmo “sparsi per tutti i lidi” partendo dall’iniziale nido africano. L’esigenza di base è quella del cambiamento, e non solo nella dimensione spaziale, poiché da sempre si è manifestata nel tempo con l’avvicendarsi delle culture; il movimento verso un “avanti” da scoprire o costruire è essenziale per tale avvicendamento. Va ricordato che la parola “senso” include più accezioni: le due che qui interessano sono “direzione verso” e “pienezza di significato”, solo apparentemente distanti.
A tutto ciò, credo, pensava Lacan parlando di “mancanza ad essere”. E Bion: “la mancanza ci fa quel che siamo”. È possibile che questa condizione di base si manifesti in varie sfaccettature: desiderio di un altrove, curiosità, confronto con un limite, possibile ricerca del sublime (evidente quest’ultimo in quel particolarissimo viaggio breve ma succoso che è l’escursione alpinistica, introdotta nel costume dai Romantici).
Il viaggio, insito nella natura umana da sempre
Una minima riflessione storica ci conferma il viaggio come insito nella condizione umana. I cacciatori-raccoglitori per sopravvivere dovevano spostarsi o addirittura viaggiare, alla ricerca di prede sfuggenti o prima o poi ridotte di numero: i primi abitatori dell’America del nord dovevano seguire i percorsi del bisonte.
Il passaggio alla agricoltura e poi all’industria ci ha progressivamente e necessariamente stabilizzato in una sede fissa. Ma ciò non ha affatto esaurito la spinta a viaggiare. Ci sono state le grandi esplorazioni: da quella forse mitica di navigatori Fenici al servizio del faraone egizio Necao e via via fino a quelle di Magellano e di Cook, oltre a quelle via terra di Livingstone e Stanley ( e voglio ricordare l’italiano Savorgnan di Brazzà).
Esse riguardavano all’inizio pochi esploratori, seguiti prima o poi da minoranze che tuttavia cercavano una nuova stabilizzazione, uscendo per scelta o per necessità da una maggioranza che si era stabilizzata in Spagna, in Inghilterra, in Francia, poi nella nostra Italia. Poteva essere angosciante questo tuffo nel nuovo: esemplare il quadro che ne dà Franz Kafka in “America” (titolo originario “il disperso”). I viaggiatori erano non di rado disperati che vagavano alla ricerca di un luogo un po’ accogliente. In un esempio di psichiatrizzazione estrema del disagio sociale, qualche autore ottocentesco ha parlato di “follia migratoria”. È perfino superfluo ricordare che questo tipo di viaggio si riproduce oggi per le popolazioni africane.
Ma l’angoscia può imporsi anche al viaggiatore – osservatore non spinto da necessità personali impellenti: vedi “Cuore di tenebra” di Conrad.
Il rapporto tra viaggio e follia
Un altro aspetto del rapporto fra viaggio e follia vera o presunta è stato il viaggio imposto: prima della nascita delle istituzioni pre-psichiatriche, la risposta al comportamento disturbante poteva essere l’allontanamento coattivo, verso spazi a quel tempo ancora disabitati; o forse nella mitica “nave dei folli”. Ciò ricorda l’antica usanza del capro espiatorio: l’animale (ma forse talora l’uomo) veniva avviato a un viaggio forzato e mortale verso il deserto.
Come sempre, anche l’esperienza del viaggio conosceva (e conosce ) un stratificazione classista: per le classi privilegiate era una esperienza di solito agevole, e nelle intenzioni istruttiva: nel settecento era raccomandata ai giovani aristocratici. Un personaggio goldoniano (mi pare de “La locandiera”) rimprovera un ragazzo che ha fatto il suo viaggio senza una preliminare formazione libresca, e che di conseguenza non ha profittato dell’esperienza quanto avrebbe potuto ricavarne culturalmente. Sterne invece ironizza garbatamente su questa usanza, nel suo “Viaggio sentimentale”. E Xavier De Maistre nel “Viaggio intorno alla mia camera” sostiene la supremazia del percorso interiore, in un’ottica sorprendentemente moderna. Per contro Goethe nel Viaggio in Italia ci parla con gioia del fascino di un mondo così diverso dal suo; fascino condiviso ancora oggi da tanti suoi compatriotti.
Da obbligo a piacere
Tuttavia, nella sua epoca il viaggio cessa di essere un quasi obbligo per i rampolli della classe dirigente: diviene un impegno facoltativo ma qualificante per pochi gentiluomini spesso definiti “eccentrici”, alla ricerca (decisamente romantica) di un centro “altro” sia nella quotidianità che nell’esplorazione di realtà geografiche, paesistiche, sociali diverse: in Liguria abbiamo il Golfo dei Poeti, in ricordo dei soggiorni di Byron, Shelley e tanti altri.
Poi, nel ‘900, James Joyce col programmatico titolo Ulysses riprende e approfondisce di molto – un secolo dopo – il discorso di De Maistre, poiché il viaggio esteriore non è più quello dell’antico mito: è ridotto ai minimi termini, divenendo un vagabondare per una angusta Dublino e il pretesto per un vertiginoso viaggio interiore.
Come viene vissuto il viaggio oggi
Oggi di solito non ci perdiamo, non andiamo alla ventura, non vaghiamo smarriti, non affrontiamo incognite: ci accontentiamo di pezzi di viaggio protetti, che hanno come scopo specifiche necessità lavorative o più spesso la soddisfazione di desideri ludici, miranti all’appagamento di quello che chiamerei desiderio nostalgico: nostalgia di un passato di viaggiatori che forse ancora, e da sempre, portiamo dentro. Non sono più, di regola, angoscianti, e ci mancherebbe: c’è una larga offerta di viaggi “pret a porter” impacchettati in modo rassicurante, o magari dotati di un margine di imprevedibilità e apparente rischio accuratamente dosato, così da gratificare il bisogno di avventura senza traumatizzare e senza rischiare davvero. Ciò non toglie che possano offrire occasione di esperienze gratificanti e arricchenti, quando non troppo incapsulati in organizzazioni “perfette” come quelle di certe crociere e vacanze.