Recensione al libro di Roberta Rubini, Iacobellieditore, 2018.
Questo libro ci offre una utile e non comune documentazione diretta del vissuto melancolico: di quel problematico crocevia fra malattia con più che possibile base biologica e condizione umana di sofferenza partecipabile e condivisibile (con termini un po’ antiquati, fra corpo e mente?).
E’ un crocevia comune a ogni turba mentale; ma nella condizione melancolica è più evidente perché lo stato d’animo di base, rispetto alla tristezza “normale” cui ognuno di noi è esposto, si differenzia più che altro quantitativamente e per la difficoltà di riconoscerne motivazioni. Tuttavia, non ci è mai estraneo, radicalmente altro da noi, questo vissuto fatto di angoscia ma anche, con apparente contrasto, di noia, legata a un vissuto di arresto del tempo: entrambi aspetti di una fondamentale disperazione.
Anche per questo scrittori, artisti, pensatori se ne sono ampiamente occupati, da Baudelaire a Leopardi (“l’ostinata orrenda barbara malinconia che mi lima e divora”); ma non sempre con connotazioni negative, poiché l’intero movimento romantico accoglieva la malinconia – beninteso moderata – come momento creativo: sempre Leopardi parlava della “dolce malinconia che partorisce le belle cose”; posizione esposta poi anche a possibili venature snobistiche come nello spleen di britannica memoria.
Ma torniamo al discorso serio. Simone Weil: “La sventura rende Dio assente per un certo tempo.. Durante questa assenza non c’è nulla da amare. E se in queste tenebre dove non c’è nulla da amare l’anima smette di amare, l’assenza di Dio diventa definitiva”. C’è qui un presagio di morte, tuttavia corretto da un tempo che qui non si è fermato: Dio è assente, ma per un certo tempo. Di fatto, Simone Weil non si è uccisa, a differenza di Virginia Woolf che lascia questa lettera d’addio, piena di consapevole disperazione: “Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E stavolta non guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo la cosa che mi sembra la cosa migliore da fare”. La consapevolezza può essere micidiale.
Non mancano dunque illustri precedenti, con cui questo libro non intende entrare in competizione: ma il suo specifico è l’offerta, così dettagliata e senza reticenze, di una dolorosa vicenda nei suoi aspetti sia interiori che relativi alla realtà esteriore. Centrale, al confine fra i due aspetti, il problema della solitudine.
Il dolore dell’anima melancolica è anche solitudine, che lo moltiplica: difficile, e forse improprio chiederselo, dire se è solitudine voluta o imposta da una radicale incapacità di condivisione. Il pensare, il condividere un’idea, è un importante momento di incontro. Scrive Eugenio Borgna: “il senso della sofferenza e delle sofferenze non è facile da rintracciare:c’è una sofferenza inevitabile e una sofferenza evitabile;c’è una sofferenza che testimonia della fragilità della condizione umana e una sofferenza che sfugge, o sembra sfuggire, a ogni significato”. E cita il teologo Xavier Thevenot: “ chi mi può incontrare nella mia sofferenza? Tutte le parole che mi si rivolgono suonano più o meno false. E’ qualcosa che va al di là delle parole, dei linguaggi. Mi sento solo”.
Suggerisce strategie di intervento, fondate sulla consapevolezza del rapporto fra la nostra soggettività e la soggettività del paziente, avendo in mente un approccio non troppo incisivo né troppo debole ed esitante: sempre nel rispetto dello specifico equilibrio di quel paziente, incerto fra bisogno e timore del rapporto intersoggettivo. fatto di parole ma anche di silenzi, e comunque di disponibilità.
Bion ci ha insegnato che il pensiero nasce e si sviluppa in un contesto depressivo; ma quando il dolore si fa lacerante, diventa paralizzante anche della capacità di pensare.
A livello più superficiale, lo stigma è ulteriore ostacolo alla possibilità di comunicare. Scrive Rubini: “Se avesi avuto prima il coraggio di parlare del mio dolore, senza il timore di esser giudicata pazza, forse avrei soltanto sfiorato con lo sguardo il fondo agghiacciante di quell’abisso con il quale poi sarei diventata tutt’uno”. Ma verosimilmente ciò non le era possibile, al di là della possibile impropria risposta dell’entourage: l’incapacità di parlare e di pensare connota una radicale perdita del senso della vita. Eppure anche l’esprimere in qualche modo tale perdita di senso può essere comunicazione. Questa è comunque frenata dal problema della colpa, che strutturalmente fa parte di questa condizione, e che è alimentata dalla consapevolezza del dolore inflitto alle persone care, che con difficoltà potrebbero capire fino in fondo quanto accade.
Ma qui subentra un altro problema: la possibile incapacità di recepire il messaggio, anche da parte di chi dovrebbe essere professionalmente qualificato a farlo. Racconta Rubini: “Un giorno (lo psi) mi fece stilare una lista, dove elencai senza alcuna ritrosia tutte le mie preoccupazioni: ad aprire quell’elenco sintomatico, che avrebbe dovuto suggerire molto più di quanto fece, c’erano la paura di impazzire e quella di soffocare”. La risposta del curante sarebbe stata inadeguata. L’altrui incomprensione – vera o presunta, ma comunque vissuta come tale – alimenta la persecutorietà e la solitudine: “mi sedetti con la convinzione di dovergli confidare meno pensieri possibili: davanti a quell’uomo non dovevo espormi più di tanto. Se avessi parlato, mi avrebbe fatto rinchiudere chissà dove. Rappresentava un nemico, un pericolo, una minaccia”. Qui si entra nel cuore del nostro rapporto con la follia: l’angoscia psicotica congiura con quella di noi interlocutori inducendoci talora a risposte non raramente inappropriate, mirate più all’autodifesa dall’angoscia personale che all’aiuto dell’Altro.
Il lungo dettagliato racconto di Rubini ci mostra la costellazione di tanti momenti dell’esperienza vissuta così a lungo: smarrimento, voglia-timore di perdersi, irritazione e collera, solitudine interiore ed esteriore, angoscia che giunge a crisi parossistiche, insonnia, degrado dell’immagine di sé con perdita perfino della cura del corpo, tristezza profonda, crisi di pianto, pensieri ossessivi, rimpianti nostalgici con sentimenti misti e contrastanti fra recupero di gioia e rinnovata angoscia di perdita, stanchezza profonda e persistente, pensieri di morte, alternarsi di sollievo e disperazione, ambivalenza di fronte alle offerte di aiuto, collera per l’incomprensione di tanti, isolamento quasi ricercato come sollievo, invidia per le gioie di altri, persecutorietà e vissuti di totale rovina, perdita di progettualità, frustrazione per le ricadute, vissuti di interminabilità del dolore e di arresto del tempo con rituali ossessivi intesi a controllarlo, perdita di coraggio e di speranza, sentimenti di colpa ai limiti del delirio, gesti autolesivi, fantasie di annientamento in qualche modo vissute quasi come affascinanti… E poi ingenui e benintenzionati interventi dei familiari che vorrebbero richiamare la paziente alla “ragione”; lo stravolgimento del rapporto con loro fino alla riportata esperienza psicotica del non-riconoscimento di essi come tali; psicotica, certo, ma esprimente una profonda verità di solitudine; il sentire di non essere capita – aiutata e di non poterlo essere. E poi…l’odissea di miglioramenti e ricadute, lunghe terapie, ripetuti ricoveri col difficile confronto con il dolore altrui, iter di studio e lavoro interrotto, interazione non sempre positiva e facile con i curanti, faticoso e doloroso ingresso con lo status di malata: status ambiguo, possibile fonte di riduzione dell’angoscia e della altrui colpevolizzazione, ma anche ostacolo a cogliere la dimensione universalmente umana della condizione depressiva.
L’Autrice ci presenta tutto ciò con ammirevole lucidità, capacità introspettiva, recuperato coraggio: il suo è un riuscito tentativo di trasmettere ciò che potrebbe sembrare non trasmissibile.


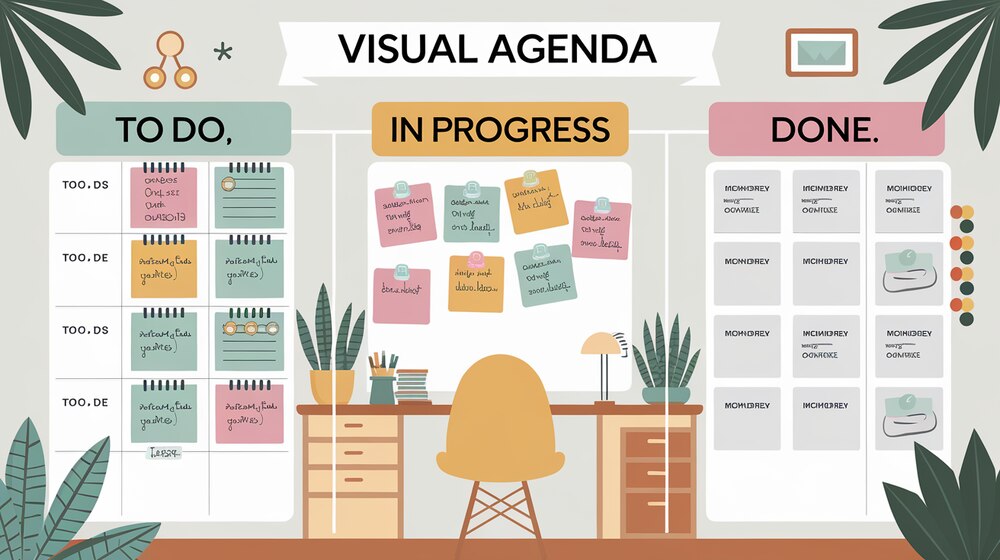














Tutto tanto realistico ed esplicativo nel vissuto indiretto di genitore di un figlio così. Tutto così difficile da “aiutare” per i familiari per lenire, pur volendo , quella solitudine!
Grazie