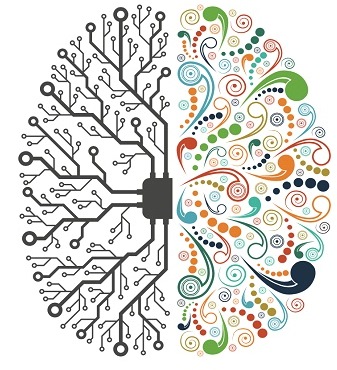Come tutti sappiamo ricorre quest’anno il quarantennale della legge 180. I festeggiamenti e le celebrazioni che hanno avuto luogo hanno ragioni ben fondate.
Di certo si tratta di una legge di civiltà della quale da italiani dobbiamo andare orgogliosi, come di poche altre cose.
Non vorrei però che, la pur legittima soddisfazione, impedisse di accorgersi che non è bastato aver chiuso i manicomi per avere una risposta efficace e soddisfacente alle necessità di cura delle patologie mentali gravi.
La 180 ha determinato scelte molto concrete, aldilà delle spinte ideologiche che vi hanno concorso. Sono scomparse le cittadelle della follia. Si è preso atto della centralità e del primato della persona e dei bisogni, che rendono ognuno unico e irripetibile.
Si è compreso che nessuno nasce come un fungo in mezzo ad un prato con le sue qualità e i suoi limiti, sano o malato, ma che il frutto cresce sulla pianta e che le piante popolano il giardino del mondo e prosperano o decadono a seconda che il terreno sia fertile o povero di risorse.
Ognuno ha una storia che lo precede che si narra nel contesto storico, geografico e sociale della storia di molti.
Insomma, tutto è connesso ed ogni cosa ci richiama ad una responsabilità globale che richiede un impegno collettivo.
Così pensare gli strumenti e le agenzie della cura come luoghi specializzati ognuno a sé stante è anacronistico. Governare la molteplicità, la coesistenza delle differenze, il confronto collaborativo dei saperi è la sfida che prelude all’evoluzione di efficaci processi di crescita, in ogni ambito.
Non a caso in psichiatria la parola Integrazione ricorre frequentemente e con vari connotazioni: integrazione fra diverse parti del sé, nella clinica; lavoro integrato, nella pratica dei gruppi di lavoro; integrazione bio psico sociale come paradigma culturale che definisce l’uomo nell’interazione fra ciò che lo costituisce; integrazione culturale fra tutti i contributi scientifici che stanno arricchendo la conoscenza umana; integrazione o reintegrazione sociale per tutti coloro che vi si affacciano o ne siano stati esclusi dalla malattia o vi arrivino da altri mondi ed altre storie.
Il lavoro terapeutico ha quindi come obiettivo, a partire dalla persona, un lavoro ricostruttivo, reintegrativo che riguarda l’individuo ma anche e di conseguenza il suo rapporto col mondo. Ma perché si possa parlare di rapporti c’è bisogno di curiosità, conoscenza reciproca, tolleranza, affetti.
Non possiamo pretendere che le persone in condizione di minorità o percepite, a qualsiasi titolo, “differenti” si adattino ad un mondo che non sia disponibile ad ascoltare, a conoscere ed accogliere.
Il richiamo alla “città che cura” non deve, perciò, essere solo una suggestione ma porci concretamente innanzi al dovere di conoscersi e riconoscersi come uniti da intenti etici comuni, che potremmo raggiungere solo collaborando con passione, a prescindere dalle appartenenze e dalle competenze.
Le diverse agenzie implicate debbono perciò aiutarsi a sostenere interventi che richiedono, non solo adeguate capacità, ma anche una concertazione molto complessa e protratta nel tempo.Territorio, comunità, reparti, famiglie, associazioni, enti di formazione, debbono lavorare assieme nel dialogo e nel confronto superando la distinzione tra interessi pubblici e privati, tra esperienza tecnica ed esperienza esistenziale, tra impegno professionale o volontario.
Non esistono due persone uguali, sane o malate che siano.La necessità della personalizzazione dell’intervento non è quindi una posizione ideologica e tanto meno idealistica ma rappresenta l’unica via da percorrere.
Tutto ciò è facile da enunciare e difficile da realizzare. Sono ancora ben solide le mura che separano i luoghi della vita da quelli della cura. Il bellissimo “programma per la costruzione di un patto per al salute mentale” propone obiettivi che ci fanno intravedere la possibilità di avviare un concorso di intenti ed azioni che potrebbero ridare vita alle tante persone coinvolte dalla sofferenza mentale, sia che ne siano vittime, sia che se ne prendano cura.
Ma alcune contraddizioni, attendono soluzioni prioritarie.
Abbiamo con la 180 sancito il primato della persona, dei suoi diritti e della sua dignità ma come possiamo garantirlo a persone che nella stragrande maggioranza, proprio a causa della malattia, vivono in condizioni di assistenza e di sostanziale povertà economica ed affettiva?Quale dignità potrà riconoscersi chi non ha nulla e, talvolta, nessuno?
Quale indipendenza otterrà chi deve dipendere per ogni cosa?
E’ sensato che le risorse per sostenere lavori agevolati a basso reddito siano ridotte a tal punto che i pazienti in residenzialità non possano accedervi?
Come possiamo rendere compatibili i processi di Recovery ed Empowerment con l’inattività e l’indigenza?
Come possiamo contenere i trattamenti residenziali intensivi se non sono adeguatamente bilanciati con forme abitative sostenute che, in alcune esperienze, comportano costi modestissimi?
E infine, dato che bisogna ascoltare per imparare come possiamo dare realmente voce ai nostri pazienti e invece di parlare di loro, dare a loro la parola?