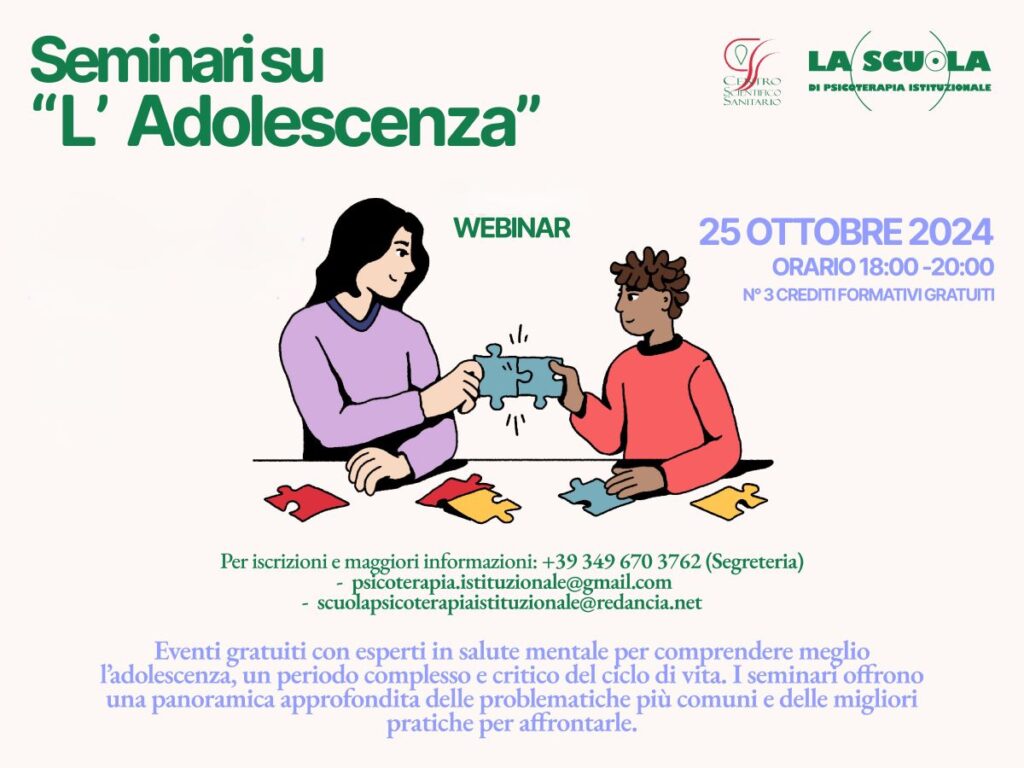Commento alla notizia ANSA del 10 dicembre 2016
Siamo nel campo della neuroestetica, disciplina sviluppata da Semir Zeki e che in Italia riconosce esponenti come Lamberto Maffei, Luca Ticini, Adriana Fiorentini. Essa fa parte di quel più ampio movimento che è l’affascinante tentativo, eterno ma da molti decenni rinnovato con nuovi mezzi, di trovare affidabili collegamenti e corrispondenze fra mente e corpo, evitando i contrapposti pericoli del dualismo cartesiano e del riduzionismo.
Il pensiero divergente è un concetto psicologico cognitivista coniato dallo psicologo americano Joy Paul Guilford nell’ambito di un suo complesso modello delle attività cognitive, in cui egli distingue tre componenti o categorie: operazioni, contenuti, prodotti.
Il pensiero divergente è la capacità di trovare soluzioni diverse e alternative a un problema; correlata quindi alla creatività. Si contrappone al pensiero convergente, che trova una soluzione unica ritenuta la sola affidabile; questo è quindi meglio misurato dai test di livello, che danno risultati ripetibili e “certi” ma rischiano di dare una visione limitata e conformista di quel misterioso insieme di capacità prestazionali che chiamiamo intelligenza.
Lo studio citato nell’articolo ci mostra come negli artisti si rilevi, a livello neurobiologico, un forte e insolito coordinamento della capacità di pensiero divergente con quella di attenzione. Potremmo leggere questo dato considerando che, nella creazione dell’opera d’arte, al momento divergente e propriamente creativo – una intuizione di essenza – dovrebbe far seguito un momento di attenta concentrazione per l’esecuzione concreta dell’opera.
Un qualche punto di contatto con questa distinzione e associazione fra creatività “divergente” e attenzione – necessaria questa per la organica costruzione dell’opera – possiamo trovarlo in Jean Pierre Changeux, neurobiologo molto interessato alla creazione artistica, che parla di “ragione e piacere”.
Dalla ben diversa prospettiva di Direttore d’orchestra, Daniel Barenboim ritiene a sua volta la sensibilità musicale (intesa come inclinazione istintiva o intuitiva al suono come mezzo di espressione) non sufficiente se non è accompagnata da un pensiero riflessivo; nel definire questi due momenti egli si rifà non tanto alle note classificazioni di una psicologia scientifico – descrittiva quanto, esplicitamente, a Spinoza con la sua classificazione delle attività conoscitive: in ordine crescente di valore, quella empirica, quella razionale, quella intuitiva.
Sarebbe interessante sapere quali sono le opere d’arte che costituiscono il campione della citata ricerca: a me sembra che il ruolo dell’attenzione, necessaria componente di un impegno costruttivo anche protratto e faticoso – pensiamo a Michelangelo che dipinge la Sistina – sia stato e sia tuttora, nelle opere più tradizionali, decisamente importante: massimo nella antichità classica con la sua ricerca di equilibrio, armonia, “perfezione”, spinta al rispetto della sezione aurea nella costruzione degli edifici; poi ripresa in termini diversi nel Rinascimento e in particolare nel lavoro di un Piero della Francesca con le sue geometriche prospettive.
Tale ruolo mi sembra invece minore in certa arte contemporanea: alcune opere – certo non tutte – sembrano buttate giù di getto, perché volte alla espressione diretta di una intuizione e/o di uno stato d’animo, che può perfino prescindere dal possesso di una abilità tecnica e dalla necessaria attenzione.
In questo rilievo, nessuna intenzione svalutativa di tante opere molto significative: pur se è evidente che si sono aperti spazi anche al dilettantismo, alla cialtroneria, alla mera ricerca di spazio nel mercato, le opere valide presenti in movimenti come il surrealismo, l’astrattismo, l’arte concettuale meritano la riflessione di Gadamer: nell’arte come nel pensiero filosofico si tratta di uno scarto, di una distanza fra ciò che vediamo in questo momento e ciò che c’è sempre, e che l’arte come la filosofia ci mostra, indicando un senso mai del tutto raggiungibile.
Può essere interessante ricercare un collegamento fra questo concetto e quello psicanalitico di interpretazione insatura, che lascia aperte diverse possibilità. E qui, mi pare, può chiudersi il cerchio con il concetto, pur sviluppato in ambito teorico diverso, di pensiero divergente, che a sua volta lascia aperte diverse vie, mentre il convergente ricerca una definizione, una affidabile certezza.