MODELLI DI LAVORO E PAROLE SENTINELLA
Ci sono parole che sarebbe meglio evitare, in comunità. O comunque dovremmo pensarci bene quando le usiamo, perché sono una specie di campanello d’allarme: un po’ come i dispositivi di assistenza alla guida che segnalano il rischio di uscire di traiettoria, verso una strada che non è più quella del nostro modello di lavoro originario. In questo senso possono essere molto utili. Propongo di chiamarle “parole sentinella”. Eccone un primo, breve elenco.
Ricovero
Nel gergo clinico, il ricovero si fa in ospedale. Le comunità sono una cosa diversa. Non migliore o peggiore, ma diversa, con organizzazione e indicazioni differenti. I principi classici del modello comunitario, nati in contrasto al manicomio, non trovano naturale applicazione nemmeno in ospedale generale. Per questo motivo sarebbe preferibile usare un altro termine per indicare l’ingresso dei pazienti nelle nostre strutture. Devo confessare che non ho in mente alternative molto convincenti. “Inserimento” è terribile, fa pensare a qualcosa di meccanico e passivo. Forse l’ideale è proprio “ingresso”, inteso come l’atto di entrare, perché implica una qualche forma di collaborazione attiva: di solito si entra con le proprie gambe. Quando si arriva in barella, semi-incoscienti, magari accompagnati dalla forza pubblica, non è un ingresso ma un ricovero e infatti dovrebbe capitare solo in ospedale. Se invece è una struttura residenziale ad accogliere in simili condizioni (succede, ho in mente diversi esempi…) possiamo desumere che non pensi più a sé stessa come a una comunità terapeutica.
Un’altra classica differenza è che dovendo essere ricoverati (in ospedale) in genere, non ci si reca in visita al reparto; non vi si trascorrono in anticipo alcune ore per annusare il clima, non si viene invitati per un caffè e magari, dopo qualche giorno, per un pranzo di conoscenza reciproca. È vero che ci sono anche strutture residenziali psichiatriche che considerano ormai superflua questa fase preliminare di conoscenza e ambientamento. Il paziente arriva quando c’è posto, senza tante cerimonie. Viene ricoverato. Ebbene, è lecito ritenere che, anche in questo caso, acceda a qualcosa di diverso da una comunità terapeutica.
A proposito: le comunità che si ritengono tali, e quindi non fanno ricoveri nel senso appena descritto, di solito aborriscono i termini “degente” o “co-degente”
Ragazzi
Alla mia età, se qualcuno mi chiama “ragazzo” e mi dà del tu (di solito in un bar o in altri esercizi pubblici di cui sono avventore pagante…) reagisco con un brivido di soddisfazione. Ma non penso che faccia lo stesso effetto essere assegnati d’ufficio alla categoria quando si entra in comunità. Nelle nostre strutture chiamiamo “ragazzi” adulti di qualunque fascia anagrafica, a volte con un profondo senso relazionale, altre volte per un automatismo che potrebbe rivelare una fastidiosa tendenza infantilizzante, più che uno spirito paritario e anti-gerarchico. Certo, anche in questo caso non esiste un termine alternativo davvero convincente. Il tradizionale “ospiti” nasce negli anni 70 al manicomio di Trieste per distinguere i pazienti che rimanevano all’interno delle mura dell’ospedale pur essendo dimessi dal punto di vista amministrativo: una distinzione lessicale allora necessaria per sottolineare un cambiamento epocale del loro status interno all’istituzione. Oggi il termine è molto più difficile da giustificare, a mio avviso. Chi entra in comunità vive un passaggio di condizione sociale assai meno liberatorio rispetto agli ex internati triestini; dissonanza particolarmente evidente per i cosiddetti ospiti in misura di sicurezza, agli arresti o in “obbligo di cura”. Credo che sarebbe meglio chiamare ospite chi invitiamo a casa nostra a cena o per il week end. Trovo “utente” impersonale e burocratico. Con tutti i limiti, la mia preferenza va ancora al termine “paziente” che è un po’ triste ma sottolinea in modo trasparente e onesto il mandato terapeutico.
Diaria o paghetta
Sì, anche “paghetta”. Qualcuno chiama così (giuro) la somma di denaro a disposizione dei pazienti per le esigenze giornaliere. Quasi sempre si tratta di denaro dei pazienti stessi, amministrati o meno, tenuto in custodia dagli operatori. Quasi sempre i pazienti hanno dato il loro assenso a questa modalità di gestione (vedi paragrafo successivo) non autonoma; la quale, non di rado, risponde a esigenze cliniche oggettive. Ma la scelta dei termini può essere indicativa di un vissuto sottostante più conflittuale di quanto appaia. Soprattutto se sono i pazienti a usare espressioni che sembrano consegnarli, in automatico, a un ruolo infantile e regressivo. E assegnare agli operatori una modalità relazionale fondata sul potere e sul controllo. Il combinato disposto di questi vissuti non lascia presagire sviluppi virtuosi in senso terapeutico-riabilitativo. Certo, parliamo di implicazioni inconsce o pre-consce, ma comunque importanti. Un indizio? Ecco come il vocabolario Treccani online definisce “diaria”: [dal lat. diaria -orum (di dies «giorno») «razione quotidiana degli schiavi, dei soldati, ecc.»]. – 1. Indennità che il datore di lavoro corrisponde al prestatore d’opera. 2. Imposta introdotta nel 1707 dal governo austriaco nel Milanese in sostituzione del mensuale. Non suona molto comunitario, a mio parere…. Sarebbe consigliabile trovare un altro termine.
Fuga
Per definizione si fugge da un luogo in cui si è obbligati a stare. Altrimenti si va via, ci si allontana, ci si dimette. Per definizione non si può essere obbligati a stare in comunità terapeutica. Quindi, nelle nostre strutture per adulti, non ha senso parlare di fuga. Perfino l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, non esattamente un avamposto di Psichiatria Democratica, parla di “allontanamento non concordato”. Le parole sono importanti per i messaggi che portano con sé. Essere obbligati vuol dire non avere alternative. Ma in comunità terapeutica l’alternativa esiste sempre, perché senza una componente di scelta personale non è possibile fare psicoterapia residenziale. Anche chi è agli arresti domiciliari, chi è in libertà vigilata, chi è interdetto deve sapere di poter scegliere qualcosa di diverso (il carcere, la rems, l’spdc, un’altra comunità). Quindi, è importante non sbagliare le parole, almeno quanto è importante che le parole siano coerenti con l’organizzazione e con i messaggi che essa, di per sé, veicola (se nessuno può parlare di fuga quando mi allontano, allora non dovrò scavalcare cancelli chiusi, forzare serrature, rubare chiavi…).
Gestione
Si gestiscono le cose, gli eventi, non le persone. Quindi, in comunità, non esistono pazienti “gestibili” o “ingestibili”. Quando pensiamo che il nostro lavoro sia gestire, abbiamo probabilmente già abbandonato l’ambizione di curare. Per questo, fra tutte le parole sentinella, è quella che mi allarma di più.
Quali altre parole aggiungereste all’elenco?




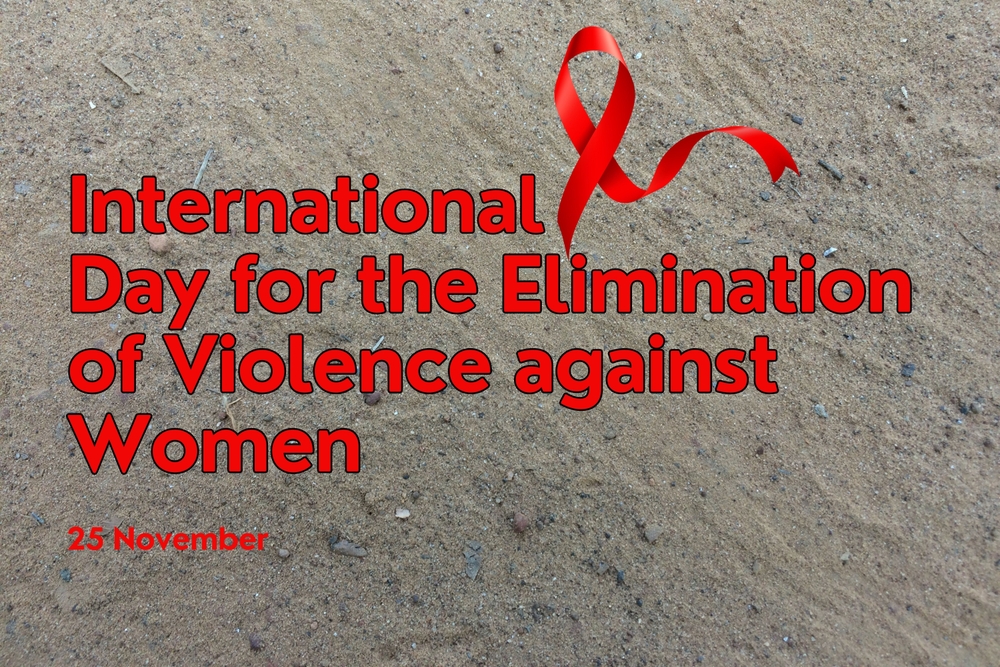













Grazie per gli spunti di riflessione offerti dal Dr Di Croce.
Mi associo nel ritenere utile una attenzione alla terminologia usata ,che rischia di diventare un gergo per addetti ai lavori
Spesso mi ritrovo a sentire tra gli operatori termini comuni che efficacemente seppur superficialmente definiscono uno stato,un modo ,un’azione quotidianamente ripetuta o spesso osservata
Penso di comprendere il senso di questa apparente superficialità
Il modello Redancia è dal mio punto di vista prevalentemente di tipo materno accogliente,accuditivo,educativo si ma mai rigido e normativo tout court .
Ed allora la familiarità,verso la quale dobbiamo prestare attenzione affinché non si trasformi in un generico accudimento ( il tenere gestendo come dice Di Croce,termine che mi irrita perché nasconde una pretesa di dominanza e controllo)può nascondersi dietro al materno’i ragazzi’ quando questi sono dei Marcantoni di due metri ed hanno 40 anni
Aggiungerei un altro termine sentinella:
Il percorso terapeutico /progetto terapeutico
Quando scrivo relazioni ufficiali mi ritrovo a pensare a come dribblare questo termine per spiegare al magistrato ,soprattutto ,che il paziente ( io credo che chi curiamo sia un paziente e mi piace usare questo termine se non posso evitarlo appellando semplicemente la persona con ‘il sig x..’) è pronto per andare altrove.
Altro termine che merita attenzione sono i bisogni .
I bisogni di chi curiamo
Faremmo meglio a dire le necessità,i desideri,le aspettative e le possibilità
I bisogni mi richiamano qualcosa di altro,di molto fisiologico
Le fughe
Dalla rems si fugge purtroppo non ci si allontana
Si fugge perché la legge li chiama detenuti fuggitivi
Ci si allontana invece deliberatamente da un luogo che in quel momento non ci piace
Ci si allontana quando il progetto terapeutico del ragazzo non corrisponde ai suoi bisogni…
Direi in poche parole ‘me ne vado perché mi state troppo addosso,o troppo poco’
Personalizzare i termini usati a seconda di chi abbiamo come interlocutore lo ritengo un segno di rispetto
Si può dire la stessa cosa in modo diverso.l
– [ ]
E’ politicamente corretto che un operatore/trice si rivolga direttamente o indirettamente ad un ospite con la frase: “NON MI ROMPERE I COGLIONI?”
So per certo che questo è successo all’interno di una Vs struttura.
Prima di fare tanta filosofia bisognerebbe forse partire dalle basi, garantendo alle persone più fragili il DIRITTO DI ESSERE RISPETTATE.
La buona educazione è alla base del vivere civile e fondamento del rispetto reciproco.
La invito a specificare chi è e dove è avvenuto quanto affermato e a qualificarsi scrivendo privatamente a css@redancia.net