Formulazione narrativa di un “caso clinico”
Vi propongo una vicenda “clinica” che secondo me ha molto a che fare con l’Eros, e la curiosità (e l’Ethos, aggiungerei).
Permettetemi di fare una premessa “teorica” generale che possa spiegare, spero, il fondamento che mi ha guidato nell’approccio con la paziente.
L’interpretazione che ne ho dato scaturisce non tanto dall’esperienza quanto primariamente dalla relazione instaurata sul momento con questa paziente che vi descriverò.
Quindi, non mi appello all’esperienza non perché io ritenga che l’esperienza non sia importante in questo mestiere. Tutt’altro! È solo che la mia esperienza ritengo non possa essere considerata “statisticamente significativa”, per così dire, e poi, in linea di principio, penso che “l’esperienza non serve a molto se non sei disposto ad imparare ogni giorno. L’esperienza vale per il giorno in corso. Il giorno successivo si fa di nuovo esperienza”. La tal cosa mi sembra una grande lezione di umiltà e insieme un’esortazione a non abbassare mai la guardia. Ciò non significa che gli operatori debbano rinunciare ai metodi e alle tecniche che sono a fondamento del proprio lavoro. Ovviamente, in seconda battuta, come suggerito anche dal Prof. Giusto durante l’ultimo seminario, una volta instauratasi la “relazione umana”, interviene il “modello di riferimento” personale che ti permette d’inquadrare la “relazione” stabilitasi tra operatore e paziente all’interno di una matrice teorica. Ed è in questa fase che la “relazione” diventa “professionale”, vale a dire che abbiamo il “caso clinico”. L’operatore è pur sempre guidato nella sua azione da un modello di riferimento che fa sì che la sua azione non sia qualcosa di semplicemente improvvisato, ma sia propriamente “un’azione clinica”, quindi un’azione con un’efficacia “terapeutica”. Insomma, se non avessimo un modello di riferimento che ci guida nell’osservazione non sapremmo cosa osservare.
È probabile che la lettura che ho dato di questa “relazione” (una lettura più psicodinamica apparentemente, nonostante io sia un sistemico per formazione) come tutte le interpretazioni cliniche, d’altra parte, sia servita per “imbrigliare l’emozione”. In fondo, la “clinica” è, forse, il tentativo “specialistico” (probabilmente illusorio) d’incanalare l’emotività umana a fini terapeutici. Nella “relazione terapeutica” non ci può essere comprensione dell’altro se non all’interno di una teoria. Le emozioni, i sentimenti, l’empatia, scaturiti da una “relazione clinica” non possono bastare di per sé ad aiutare (a “curare”) una persona, secondo me, ovviamente.
Tuttavia, è altrettanto vero che nelle relazioni d’aiuto come in tutte le relazioni umane entra in gioco in modo preponderante la “responsabilità” (“la responsabilità inizia quando l’altro alza gli occhi su di te”, è stato detto, quindi la responsabilità inizia prima di qualsiasi azione): nelle relazioni umane non c’è molto di “scientifico” nel senso di replicabile perfettamente all’infinito come vuole la metodologia sperimentale; tutto è molto aleatorio, esposto com’è all’imprevedibilità “dell’approssimazione”. Dunque, nessun modello e nessuna tecnica per quanto efficaci e sperimentati possono confortarci in assoluto sulla bontà di ciò che stiamo “agendo”. E non ci aiuta nemmeno l’idea che le “relazioni (psicologiche)” non siano “stocastiche”, cioè non siano casuali (ma nemmeno totalmente prevedibili) perché hanno (o dovrebbero avere) “fini etici”. Quando parlo di “stocastica” in questo contesto mi riferisco metaforicamente, in particolare, ai “processi stocastici ciclostazionari” (espressioni mutuate dalla matematica, e in particolare dalla teoria della probabilità che già appaiono in contraddizione perché o è “stocastico” cioè casuale o è “stazionario” cioè fisso, stabile) termini che nell’ambito delle relazioni psicologiche utilizzo per delineare processi o fenomeni psichici che possono manifestarsi periodicamente e in larghi strati di popolazione, ma mai uguali a se stessi. Tali processi o fenomeni possono essere descritti attraverso parametri statistici nonostante sia molto probabile che possano manifestarsi mai in modo identico nella stessa persona e/o in persone diverse. In sostanza, per fare un esempio, il DSM (Manuale statistico dei disturbi mentali) cataloga la sofferenza psichica all’interno di precise categorie diagnostiche presentandoci dunque le sofferenze psichiche come dei “processi stocastici ciclostazionari” appunto, cioè dei fenomeni che hanno una certa frequenza statistica nel tempo e tra la popolazione, ma che non tengono conto dell’individualità, cioè del fatto che i disagi delle persone non possono essere compresi compiutamente attraverso la descrizione puntuale di una serie di sintomi sebbene questi ultimi si presentino con una cadenza statisticamente rilevante nella popolazione. La stabilità o regolarità dei sintomi descritti dal DSM è “ciclica”, nell’accezione di “tendenziale”, ma è proprio questa ciclicità-tendenzialità che per sua natura non può darci una sicurezza assoluta sulla bontà e correttezza di ciò che stiamo osservando. I sintomi descritti in una diagnosi non si manifestano tutti e tutti allo stesso modo in ciascun individuo. Bisogna sempre ricordarci che non è una diagnosi quella che prendiamo in carico, ma una persona unica e indivisibile. Quindi, le relazioni psicologiche sono “processi stocastici ciclo stazionari”, cioè sono abbastanza stabili da poter essere descritte con un buon grado di approssimazione, ma non si presentano mai allo stesso modo. Le descrizioni categoriali ci danno un’idea di massima, ma mai una “comprensione” profonda dell’individuo proprio a causa della sua imprevedibilità.
Tutto questo “sermone” soltanto per dire che, ritengo, farei un torto alla persona in questione se la trattassi soltanto alla stregua di un “caso clinico”, terminologia che mantiene in sé un vago sapore di “stigma” che mi pare la paziente rifiuti categoricamente, a suo modo, come vedremo di seguito.
Dunque, vi parlerò di una paziente che attualmente abbiamo in carico presso una struttura del Gruppo Redancia. La paziente è una donna di 44 anni dalla corporatura massiccia, in sovrappeso si potrebbe dire. Una delle sue caratteristiche più vistose è data dalla sua abitudine quotidiana di introdurre sotto gli indumenti oggetti dei più svariati: bottiglie e bicchieri di plastica, giornali, libricini e agende (anche rubandoli), posate di plastica.
Si oppone, protestando e urlando e aggredendo chiunque voglia anche soltanto tentare di rimuoverli dal suo corpo. Qualcosa di simile accade tutte le volte che si prova a tagliarle le unghie. Sembra che ci sia il bisogno “ossessivo” d’incamerare, “incorporare” gli oggetti (intesi come rappresentanti fantasmatici di persone significative, probabilmente). L’oggetto-plastica (pur nella sua materialità) non sembra avere il vero significato di oggetto esterno indipendente, ma finisce per diventare nient’altro che una parte di lei (è importante per il suo senso d’identità, verosimilmente) per questo fa fatica a liberarsene e lo difende strenuamente. Così come delle unghie fa fatica a liberarsi perché con queste ha imparato a proteggersi. Privarsi delle unghie, un pezzo del proprio corpo, significa rinunciare a un a parte di sé, vuol dire aggiungere altra quota di “disintegrazione” per una persona che fa già molta fatica a “tenersi insieme”. Probabilmente la separazione “prepotente” dall’oggetto (o dalle unghie) rafforza le sue angosce persecutorie alimentando il senso di “confusione” di questo legame tra sé e l’oggetto. Parrebbe il suo una sorta d’irrigidimento narcisistico finalizzato a preservarla dal rischio, percepito come intollerabile, della perdita dell’oggetto e per difenderla dall’angoscia che tale perdita rischia di generare.
In fondo, questa “incorporazione orale”, rappresenterebbe il persistere in età adulta di una modalità molto arcaica di far entrare nel (suo) mondo psichico una quantità sempre maggiore di mondo esterno. Considerato il suo livello di sviluppo si limita ad “incorporare”, (ingoiare) oggetti inanimati piuttosto che “introiettare” atteggiamenti affetti o comportamenti di persone significative o assumere selettivamente le qualità di un’altra persona ammirata (identificazione).
Spesso prima di mettere l’oggetto sotto l’indumento lo schiaccia, lo strizza, lo contorce, la tal cosa assomiglia all’azione del “masticare” prima di ingoiarlo (di “incorporarlo”, in tal modo annientandolo pur sempre facendolo sparire “magicamente” sotto il maglione).
Mi sono chiesto se non si tratti di un caso classico d’indifferenziazione Io/non-Io, con molta probabilità: assenza di differenziazione tra il proprio corpo e l’oggetto esterno. Gli oggetti esterni sono “introiettati” cioè custoditi come oggetti di cui impadronirsi, “inglobati” come un pregiato e adorato possesso. A questa “incorporazione” si accompagnano, non casualmente, forse, alcune paure e angosce orali specifiche come la paura di essere mangiati: quando la invito a consegnarmi qualche oggetto di quelli che trattiene sotto gli indumenti mi dice con voce flebile e biascicando come suo solito: –… non posso… è mio…Tu mi mangi… lasciami perdere… sono incinta! – Quando pronuncia – lasciami perdere! -, l’espressione del volto non è minacciosa o infastidita, ma “compassionevole”: forse mi sta invitando ad insistere (in fondo le attenzioni non devono dispiacerle poi tanto); oppure, vuole avvertirmi di starle lontano perché “troppo pericolosa” (come se volesse proteggermi dalla sua distruttività intrinseca?). Mentre parla sorride, poi si ferma, china la testa da un lato e mi guarda come se aspettasse una mia reazione, poi scoppia in una sonora risata “luciferina” come d’abitudine e poi si allontana pensierosa, lentamente, parlando fra sé e sé e ondeggiando col suo corpo pesante mentre si trascina un pannolone ormai pronto per essere sostituito da uno più asciutto.
È possibile che si sia realizzato un “transfert idealizzante”: so bene che parlare di transfert riferito a una persona psicotica può apparire una forzatura (sarà così vero poi che le persone psicotiche non sono capaci di transfert?) ma sto solo tentando si spiegarmi il significato del suo “delirio”: la paziente mi percepisce come un genitore trasfigurato probabilmente e, difatti, da qualche giorno mi chiama “papà”: adesso raramente devo insistere per farmi consegnare gli oggetti che trattiene, me ne fa dono semplicemente, più spesso accompagnando il dono con piccoli baci che mi da sulle braccia. Una volta ha persino provato a baciarmi sulla guancia, ma io (chissà perché… forse perché troppo imbottito di tutta la mia teoria) mi sono tirato indietro per un senso di pudore eccessivo, o forse per timore di “sessualizzare” il rapporto con lei o forse semplicemente perché non la conoscevo abbastanza e temevo il rischio d’invadere il suo spazio pericolosamente. Insomma verosimilmente ho lasciato che le razionalizzazioni prevalessero sulle emozioni in attesa di capire cosa fosse meglio fare per il futuro. Non so se ho fatto bene a respingerla. Di sicuro la paziente si è risentita molto allontanandosi indispettita e blaterando parole incomprensibili.
Di certo, il mio “rifiuto” dell’approccio della paziente è dovuto, in parte, anche al timore che il suo proposito si rivelasse troppo “seduttivo” (ho tentato di mantenere una “distanza terapeutica”, per così dire, non sapendo esattamente “quale vicinanza poter raggiungere”, come ha scritto Dott. Nicora recentemente sul Vaso di Pandora web). Diverse volte ha voluto mostrarmi il suo abbondante seno (tanto che le prime volte lo confondevamo con la pancia altrettanto abbondante), oltretutto dinnanzi ad altri ospiti; per fortuna l’acquisto del reggiseno rinforzato ha diminuito la frequenza delle sue esibizioni in pubblico. Adesso ogni volta che mi vede non di rado mi “affida”, per così dire, bottiglie e bicchieri e tutto quello che trattiene sotto il vestiario. Dico mi “affida” in quanto l’atto del consegnare si accompagna al gesto di prendermi la mano e di chiuderla intorno all’oggetto spingendo il tutto contemporaneamente contro il mio corpo. Questo suo atteggiamento da un lato mi fa pensare che mi stia concedendo l’autorizzazione ad entrare, seppur in punta di piedi, nel suo “mondo psicotico”, ma dall’altro questo suo riempirsi di oggetti che custodisce gelosamente insieme allo “straripare” del suo seno la fanno assomigliare davvero ad una donna incinta: con la sua “rotondità” fatta di carne e plastica realizza una buona e durevole capacità contentiva di tipo materno. Lei diventa in tal modo possente e morbida allo stesso tempo (gli oggetti con cui si “riempie” costituiscono pur sempre una sorta di scudo, di corazza per affrontare il mondo o per difendersi da questo e contemporaneamente fanno da colla che tiene insieme il suo Sé); lei è anche aggressiva, però: lei sì che è capace di difendere con la sua possanza, con la sua combattività i propri piccoli (cioè, gli oggetti che gli altri le vogliono “togliere” dal “maglione-grembo”) e di allattarli degnamente con l’abbondanza dei suoi seni.
Spesso è talmente traboccante di roba varia da ricordare a tratti la forma tracagnotta dell’omino della Michelin (quello della pubblicità dei pneumatici di qualche anno fa); poi tutta bitorzoluta e “gravida” di tutti i suoi “oggetti” si siede a gambe larghe stendendo le braccia, poggiando le mani sulle ginocchia e aggrottando le sopracciglia in atteggiamento di sfida fissando il vuoto, per la serie “chiunque si avvicini a me e ai miei cuccioli lo faccio fuori”. Altre volte tiene stretti i suoi oggetti in petto come se volesse abbracciarli amorevolmente o difenderli o come se volesse “allattarli” (se li sistema in continuazione proprio in corrispondenza dei capezzoli).
Forse in questa sua “incorporazione” di oggetti si nasconde il desiderio frustrato di avere un figlio o il ricordo evanescente di un bambino mai nato, forse (esperienze pregresse di aborti per necessità o per violenza subìta. Non sappiamo molto della sua storia). Non è un caso, ribadisco, che da qualche giorno ed esattamente da quando le ho fatto acquistare i reggiseni mi chiami “papà”: facendomi dono dell’oggetto plastificato (una parte di sé) affinché io lo custodisca per lei (segno che ha deciso di fidarsi di me, probabilmente) fa dono al padre (a me) simbolicamente di un figlio, è il suo modo di far piacere al padre (di farmi piacere) tanto da “lasciarsi fecondare da lui”: da questa “unione” scaturisce rigorosamente un “figlio di plastica”, ovviamente(cioè la bottiglia o il bicchiere di cui mi fa “dono”). È possibile che con il padre abbia avuto un rapporto molto controverso. Si può pensare che questa “incorporazione” si traduca verosimilmente in una difesa contro l’insoddisfazione causata dall’assenza dell’oggetto paterno o dal desiderio di distruggere una figura paterna (o genitoriale, più in generale) vissuta come molto invasiva o abusante, forse. Quest’ultima ipotesi potrebbe voler dire che mi affida l’oggetto genitoriale appena incorporato (una bottiglia di plastica, ad esempio) perché io lo preservi dalla sua aggressività e distruttività mortale. Se è vero che l’oggetto incorporato rappresenta simbolicamente il genitore amato-odiato di cui non può fare a meno (oggetto-sé) per mantenere la propria autostima (per non sentirsi cattiva), allora potrebbe sentire l’esigenza di affidare a me l’oggetto perché sia io a controllarlo per lei preservandolo dalla sua aggressività “onnipotente” e sottraendola, in tal modo, anche alla “vendetta” dell’oggetto medesimo, eventualmente. Quegli altri cui si oppone con veemenza (gli Oss, ad esempio, che per farle la doccia sono obbligati a volte necessariamente a utilizzare modi più sbrigativi, ma senza mai essere violenti, s’intende) che la “svuotano” (dei suoi “amati beni”) per lavarla non sono abbastanza sicuri tanto da affidargli i suoi “cari-oggetti” (non fosse altro perché sono percepiti come troppo “irruenti” e quindi rischiano di essere “distruttivi” a loro volta verso gli “oggetti che serba in seno”).
Nei rari casi in cui mi riesce di tagliarle le unghie senza l’aiuto dei colleghi Oss capita che pianga, a volte urla (con sfilze d’insulti e improperi vari), tanto da diventare paonazza in volto, a volte si oppone strenuamente per un po’, il volto sconvolto dallo sforzo immane. Sembra davvero di assistere a un parto. L’espulsione delle unghie così come degli oggetti di plastica assomigliano ad una sorta di distacco dal feto. E alla fine quando le unghie sono state tagliate o i vari oggetti allontanati da lei, il volto si rasserena, le rughe si distendono, sorride spossata come una puerpera dopo il travaglio del parto. Allora, ricomincia a sorridere e con gli occhi ancora piangenti, ti bacia su una guancia (adesso ho imparato ad accettare i suoi “bacini”, come li chiama lei) e magari capita che ti da anche una pacca sul sedere e poi pronuncia: -… Non ti arrabbiare piccino… Papà sei il mio topo… Sono i miei topi… Non puoi capire… -. Certo a ripensarci bene questo alternarsi di concitazione a distensione fisica ed emotiva ti fanno pensare vagamente anche all’eccitazione e al rilassamento che precedono e seguono l’orgasmo del coito. In effetti, l’altra ipotesi potrebbe essere che la paziente stia mimando un atto sessuale con quel suo turbamento parossistico seguito da una placida impassibilità.
Forse può essere utile per la disamina citare alcuni momenti di inconsapevole ironia quando ad esempio, durante la veglia funebre di un ospite della RSA, si presenta alla cerimonia con i pantaloni calati e il solito pannolone d’ordinanza penzoloni e intrattiene il morto e i suoi parenti cantando, con voce impostata, una famosa canzone di Caterina Caselli che faceva più o meno così: “insieme a te non ci sto più….si muore un po’ per poter vivere…”. Il cui testo non sembrava poi così fuori luogo, a pensarci bene (doveva pur esserci in lei una consapevolezza sufficiente della situazione, con buona probabilità). In fondo, voleva essere il suo tentativo, seppure maldestro, di alleviare il dolore dei parenti per il caro estinto. Era il suo modo per sottolineare che si può anche morire, ma per continuare a vivere nella testa, nei pensieri, nei ricordi di qualcuno, forse. Certo il suo abbigliamento, anzi, l’assenza del suo abbigliamento, non era il più adatto alla situazione e difatti non tutti hanno apprezzato l’omaggio canoro. Alcuni degli astanti mi lanciavano occhiate di sincero disprezzo attraverso occhi iniettati di sangue, altri erano sbiancati, più bianchi del defunto medesimo, altri sorridevano imbarazzati, ma benevoli per quel momento di involontaria ilarità suscitato dall’intrusa eccentrica che strideva non poco con la solennità del momento. E mentre la rivestivo, dopo averla “strappata” frettolosamente dalla cappella, mi fissa con sguardo indulgente, mi da un buffetto sulla guancia e mi dice, esplodendo in una delle sue risate “infernali”: “non ti arrabbiare topo…è così… non ci puoi fare niente…”, e si allontana accompagnandosi con i suoi soliti monologhi recitati al nulla. Per la cronaca, l’equivoco non si è più ripetuto considerato che in caso di riti funerari un operatore si affianca preventivamente e amorevolmente alla paziente per assicurarsi che le sua vocazione canterina non si trasformi involontariamente in un momento di imbarazzo dal sapore “fantozziano”. A onor del vero alla fine tutti i presenti alla veglia l’hanno presa molto “sportivamente”: recatomi a porgere le mie condoglianze e le scuse ai parenti più prossimi del defunto, per “l’insano gesto”, tutti, più che da propositi di vendetta, sembravano armati di umana comprensione mentre mi stringevano la mano.
Aggiungo che la paziente conserva una parvenza di risorse cognitive tanto che la comunicazione con lei non è totalmente negata, né rifiutata. Ho provato a mostrarle delle foto e dei disegni raffiguranti animali, frutti e oggetti vari, li riconosce ed è capace di nominarli correttamente, segno che alcune delle sue funzioni esecutive frontali non sono irrimediabilmente perdute. In altre parole, se si concentra la sua attenzione su un compito anche di natura discretamente astratta, il suo delirio s’interrompe, svaniscono il deragliamento e la frammentazione, scompare l’insalata di parole, i nessi logici non appaiono più allentati. Ovviamente, le manca la perseveranza, cioè la sua capacità di mantenere la concentrazione è davvero ridottissima, la sua attenzione è eccessivamente fluttuante, cicla perentoriamente nell’arco di pochi secondi.
Finisco ricordando ancora quel suo “lasciami perdere…non puoi capire”. Potrei interpretarlo come il suo solito istinto materno di protezione nei miei riguardi. Tuttavia, penso che francamente, non è che abbia poi tutta questa urgenza di farsi “capire”, forse. Può darsi che mi stia sollecitando semplicemente a non spingermi troppo oltre. Sono io che mi cruccio l’anima e il cervello nel tentativo di “capire” qualcosa di lei o che mi sforzo di dare un senso alle sue espressioni verbali e comportamentali come se da questo splendido insight potesse derivare chissà quale beneficio per lei medesima. Forse tutto quello che vuole è che io faccia almeno lo “sforzo di….”. A volte ho come l’impressione che sia lei che stia cercando di “capire” me cioè che mi stia usando per com-prendere (cum-prendere) per com-prendermi nell’accezione più pura del termine di contenere-me (includermi), di capire-me (afferrarmi). Cioè che mi stia com-prendendo facendo propri aspetti di me utilizzati come “cemento” per costruirsi, per ricostruirsi. E questa ricostruzione personale può avvenire con la ragione, certo, ma anche con un abbraccio, con un “bacino”, con una melodia stonata cantata insieme, con un buffetto sulla guancia. In tal caso una parvenza di capacità di “introiezione” sembra farsi largo sulla sua più massiccia e più arcaica tendenza “all’incorporazione”. Mi sono accorto che quando provo a “fare lo psicologo” bombardandola di domande più o meno sensate (novello Sigmund Freud) lei si ritrae infastidita, altre volte si arrabbia di brutto e ti manda al diavolo senza tanti complimenti oppure aumenta lasua dose di parole e frasi apparentemente sconnesse, senza logica. È il suo modo di “sfuggire al target” o di ribellarsi all’etichetta di “caso clinico”, forse. Forse è il sentirsi “sondata” che non tollera, questo scandaglio psicologico lo giudica alla stregua di una indebita intrusione. In fondo il “caso clinico” (l’inquadramento nosologico) rischia di diventare davvero un modo grossolano, dettato da necessità narcisistiche o di maniera, di accostarsi ad un soggetto per racchiuderlo in uno schema anticipato, per ridurlo ad un abbozzo preconfezionato da una teoria. Spiegare una persona attraverso i suoi sintomi può risultare davvero intollerabile per qualcuno, per la serie “…E tu pretendi di suonarmi con questo rozzo strumento?…”.
E allora, preferisce di gran lunga quando mi metto a cantare insieme a lei e mi prende sotto braccio passeggiando per i corridoi della struttura mentre gli altri ospiti ci guardano con l’aria di chi pensa “questi devono essere proprio matti”.
E qui mi riallaccio al tema della “curiosità” introdotto ancora dal Prof. Giusto all’inizio dell’incontro. Vale a dire che finché penserò che c’è ancora qualcosa da scoprire in lei, allora il mio interesse non finirà e così la nostra “relazione” si manterrà viva tutti i giorni. Il giorno in cui dovessi pensare di aver capito qualcosa allora quel giorno forse avrò perso la curiosità e la mia sollecitudine verso di lei si spegnerà. E non è questo quello che vuole: quindi, non può permettersi che trapelino troppe informazioni, troppe “verità” su di lei. Lei non vuole essere capita; alla fin fine quello che si aspetta è che qualcuno sia coinvolto insieme a lei nel (suo?) mondo. Ecco! Usare l’espressione “il suo mondo” equivale forse a “prendere le distanze”, diventa quasi il meccanismo di difesa di chi è abituato a vivere la “quotidianità” di due mondi separati (quello dei pazienti-ospiti e quello degli operatori), legati soltanto da regole e valutazioni statistiche tipica della tradizionale comunità psichiatrica, forse. Non voglio scadere in un eccesso di retorica che può suonare ipocrita perché è ovvio che un certo grado di separazione tra il mondo degli operatori e quello dei pazienti è indispensabile se vogliamo essere “terapeutici”. Tuttavia, è altrettanto indispensabile trovare un “momento di sintesi”, cioè uno spazio-tempo in cui la “separazione” si sfuma senza mai scomparire completamente; un “luogo” dove più facilmente è possibile confrontarsi tra diverse persone (e personalità diverse) e che può favorire l’incontro tra le persone-pazienti residenti e gli “esperti” dell’istituzione. Questi ultimi entrano nella “comunità” (la casa dei pazienti) in punta di piedi,“rimangono sulla soglia”, con discrezione. Mi piace l’idea che l’op., soprattutto quello che per il ruolo che riveste rimane a contatto più stretto con i residenti di una comunità, entra nell’ottica di chi è “ospite”, a sua volta: l’operatore e il residente “si fanno visita” per alcuni mesi o per alcuni anni ciascuno con le proprie aspettative e interrogativi, i dubbi e le certezze e con una visione del mondo ben (o mal) strutturata. Di sicuro assistiamo all’interscambio tra persone con identità e ruoli e “posizioni” (nel senso di punti di vista) in costante mutamento. Persone che sperimentano un modo differente (ogni volta) di fare gli operatori o di stare semplicemente al mondo in modo costruttivo.
E allora, per tornare al “legame” con la paziente, finché ci sarà curiosità (reciproca) ci sarà relazione; finché riuscirà ad incuriosirmi si assicurerà qualcuno con cui condividere, comunicare i propri stati d’animo e così non sarà mai sola. Certo dovrò anch’io sforzarmi di incuriosirla a mia volta. Questo legame di “reciprocità” ovvero questa “relazione simmetrica affettiva”, contraddistingue un tipo di rapporto in cui ciascun membro della relazione scopre nell’altro caratteristiche proprie attraverso unione e vicinanza, influenza, scambio e corrispondenza “reciproci”, appunto. Questo tipo di relazione può sembrare impossibile in contesti istituzionali perché rischia di essere troppo travolgente e coinvolgente. Ma è di “reciprocità” nella “complementarietà” che sto discutendo nel senso di “uguaglianza nella differenza” attraverso la quale ciascuno accetta l’altro per quello che è e non per quello che vorrebbe che fosse…. Ma questo genere di “reciprocità” vale per tutte le relazioni umane che si rispettino, immagino.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Vi ringrazio anticipatamente nel caso aveste suggerimenti o differenti punti di vista che possano aggiungere un tassello in più alla “comprensione” di questa persona .












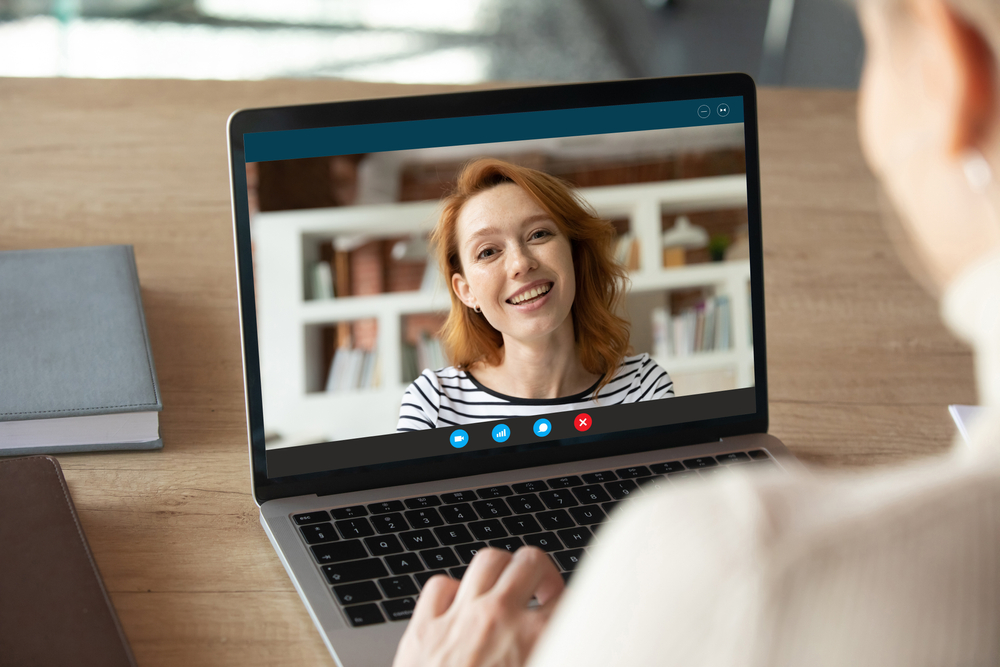





ho letto il tuo articolo con grande attenzione ma c’è una certa autoseduzione per evitare la divisone e l’angoscia ad essa conseguente . Il legno ha fra le tante due proprietà : può bruciare e galleggiare … ma se si brucia per prima operazione poi non può più galleggiare se invece lo si fa galleggiare poi lo si può anche bruciare cos’ì è nel rapporto tecnica e relazione è la tecnica che stabilisce le basi per la relazione non l’inverso. . Nel rapporto clinico ha stabilire la relazione sono le posizioni che si assumono : se non sai che posizioni occupi, se non sai quale istanza rappresenti nei confronti del paziente si cade immancabilmente dall’immaginario nell’empatia, sicuramente eccitanti ma completamente fuori dalla direzione clinica cioè dalla terapia che ti viene chiesta dal Paziente potrai essere un amico vero, un conoscente , un qualsiasi cosa
ma mai l’enigma che cerca. Ciao un caro saluto [m.b.]