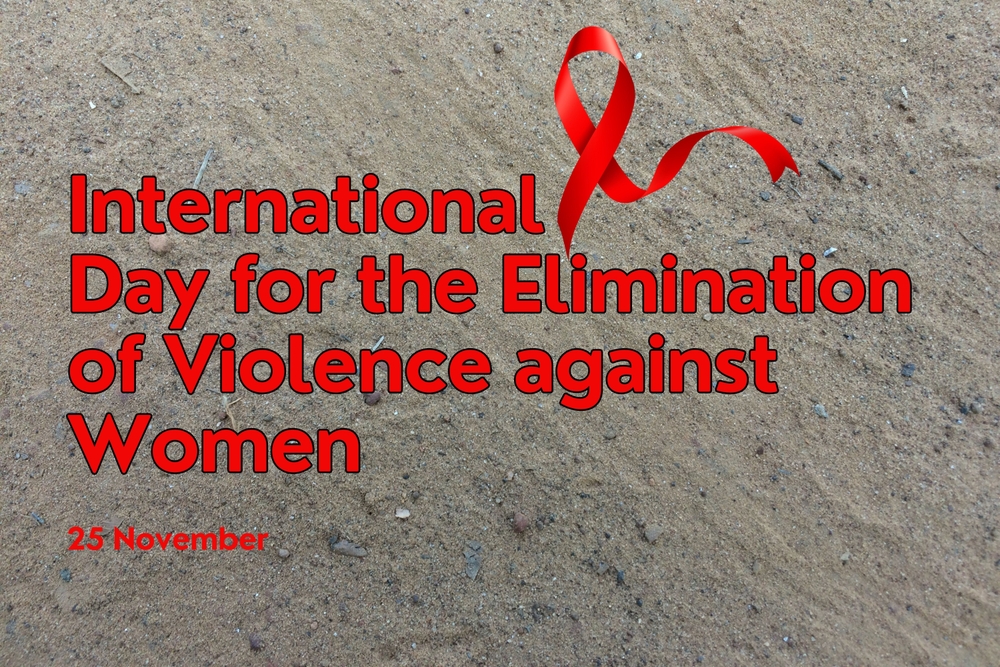Febbre di casa
Gabriele bussa che non sono nemmeno le 8.30. Mi chiede conferma che lo accompagnerò in udienza, rimane sulla porta.
Non entra in ufficio.Gli dico che andremo insieme, che prenderemo un taxi. Mi guarda poco convinto, avrebbe preferito andare in automobile perché così avremmo risparmiato del denaro.
Torna, di nuovo bussa e si affaccia alla porta. Il viso pulito, i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia appena fatta. Con abiti puliti: una felpa dei New York Yankees e dei pantaloni con scritte fluorescenti. Gli chiedo se non abbia dei Jeans, forse più adeguati per presentarsi dal giudice. Si guarda, mi guarda, mi dice che così si sente bene. Ai piedi delle scarpe sportive che a prima vista sembrano pantofole: anch’esse fluorescenti, ma ricoperte da una rete di tessuto nere che le rende strane. Di nuovo, mi domanda se lo accompagnerò in udienza e a che ora usciremo.
Alle 11 Gabriele si riaffaccia alla porta dell’ufficio, mi chiede se non fosse l’ora di andare. Gli ricordo che ho prenotato un taxi che ci verrà a prendere alle 12. Questa volta entra e si siede al tavolo. Aspetta seduto, in silenzio, mentre io termino i miei lavori.
Alle 12 è lui a darmi il tempo: a rispondere al citofono, ad avvisarmi dell’arrivo del taxi. Mi metto la giacca. Lui invece è con la felpa degli Yankees. Di cotone. Gli dico che forse avrà freddo, che sarebbe meglio che indossasse una giacca. Si guarda, mi guarda, mi dice che così si sente bene. Usciamo, fa le scale con rapidi saltelli ed è lui a salire sul taxi per primo.
Non dirà niente per tutto il viaggio. Solo, una volta arrivati, che il Tribunale dei minori si trova vicino alla Comunità. Scende. Chiede della madre, dal cortile interno al tribunale ci risponde l’assistente sociale dell’Uepe (Ufficio Esecuzione Pene Esterne), ci invita ad entrare. La polizia Penitenziaria ci apre la porta, passiamo attraverso il metal detector, le nostre borse sul nastro. Nel cortile l’assistente sociale si presenta, chiede a Gabriele se si ricorda di lei. Gli chiede se non ha freddo senza giacca. Lui si guarda, la guarda e le dice che così si sente bene. Arriva l’avvocato. Saluta Gabriele. Gli chiede se non ha freddo senza giacca. Sto bene così. Gabriele chiede della madre. Arriva anche l’assistente sociale del CPS (Centro Psico Sociale) e dopo averlo salutato nota che è senza giacca. Glielo fa notare. Gli chiede se non abbia freddo. Gli ricorda che l’ultima volta tremava dal freddo. Sto bene così. Gabriele sente la voce della madre e le va incontro, vicino al cancello. Dall’altra parte, la madre lo saluta. Esita e gli chiede se fosse venuto con le pantofole. Salvo poi rendersi conto che erano scarpe da tennis. E poi, anche lei, a chiedergli della giacca. La donna mi guarda quasi a doversi giustificare: “sa glielo dico da mamma…”
Attendiamo pochi minuti, fuori dall’aula. Tutte quante mi chiedono come stia andando Gabriele nella nuova Comunità. Che cosa faccia durante il giorno. Rimangono tutte quante stupite nel sapere che Gabriele cucini per tutti. Gli fanno mille complimenti. A Gabriele sembra non interessare. Chiede all’assistente sociale se può chiedere al giudice il permesso di andare a casa. Non c’è risposta. Gabriele ripete la domanda. Non è questo il momento.
Gabriele si siede accanto al suo avvocato, di fronte al giudice. Accanto a loro, il pubblico ministero e il cancelliere. Dietro, accanto a me, le assistenti sociali e la madre. Il giudice presenta il caso, si tratta di rivalutare la pericolosità sociale per un reato commesso da Gabriele a pochi giorni dal compimento dei 18 anni. Ai danni della sorellastra. Poi, chiede all’assistente sociale di raccontare dell’ultimo periodo, dopo la scorsa udienza, dopo la dimissione chiesta da Gabriele dall’ennesima comunità. A quel punto, lascia la parola a Gabriele che, senza esitare, chiede quando terminerà la pena, che il suo reato aveva ricevuto una condanna a tre anni, già trascorsi. Chiede di poter andare a casa. Il giudice gli chiede della nuova comunità, Gabriele chiede di poter andare a casa, il tono si alza e diventa rabbioso. Chiede quando potrà farlo. Il giudice sorride imbarazzata, non lo guarda. Non gli risponde. Gli dice solo che non è il momento di chiederlo. E poi si rivolge all’assistente sociale, come se Gabriele non fosse presente, gli chiede della nuova comunità. Chiedono a me. Dopo una breve presentazione di noi, del nostro stile di lavoro, della progettualità pensata con Gabriele condivido con il giudice che è importante dare una risposta a Gabriele, a proposito dell’andare a casa: che questo è quello che chiede, che una progettualità terapeutica non può non tenere conto di quello che Gabriele sta chiedendo. Che forse ha bisogno di comprendere la propria responsabilità nel progetto, nella realizzazione di ciò che chiede. E che questo è il momento per farlo, perché lui lo sta chiedendo. Che non possiamo aspettarci, come invece sostenuto dall’assistente sociale, che la progettualità di Gabriele parta dall’elaborazione del reato. Quello potrà esserne la conclusione. Mi viene in mente un articolo letto durante il training dal titolo “Le psychophobe”, nel quale Jean Luc Donnet descrive l’evitamento del pensiero in un adolescente.
Il giudice a quel punto comprende. Dice a Gabriele che per poter andare a casa serve che la sua équipe terapeutica faccia a lei una richiesta, motivandola e supportandola dai risultati del progetto in Comunità. Che dipende da quanto si darà da fare. L’assistente sociale ribadisce l’assoluta necessità che Gabriele elabori il fatto per il quale si trova in tribunale. Gabriele a quel punto e rabbiosamente chiede quando potrà andare a casa. Il giudice interviene duramente con l’assistente sociale riprendendo le mie parole: l’elaborazione del reato sarà possibile quando e se sarà possibile per il giovane entrare in contatto con i propri fantasmi psichici, con la propria mente, con i propri oggetti interni. Intanto Gabriele chiede di andare a casa perché tutti in comunità lo possono fare. La madre dice che è d’accordo, che si può provare, inizialmente accompagnato da un operatore. In quegli attimi, penso che Gabriele ha 21 anni, che da 4 anni non torna a casa. In una casa dove vivono i tre figli della madre avuti da un altro uomo. In una casa da cui, dopo aver tentato un approccio sessuale alla sorellastra minorenne poco prima del compimento dei 18 anni, è stato allontanato. Una casa verso la quale scappa. Per cercare la madre. Una casa in cui non entra da 4 anni. Che non abita da ancora prima, avendo girato di comunità in comunità. Suggerisco al giudice che ci sarà anche da chiarire cosa s’intende per casa: dentro quelle mura, nella relazione esclusiva con la madre. O anche con quel nuovo compagno e quei figli nati dalla relazione tra loro, tra cui anche la sorella vittima di quel reato. Con quali e quanti fantasmi sarà in grado di confrontarsi Gabriele?
L’udienza finisce. La mamma ci tiene ad offrirci la colazione. Andiamo in un bar di fronte al Tribunale. È quasi ora di pranzo, Gabriele si prende una brioche e dal frigo una di quelle bevande utilizzate dagli sportivi dopo uno sforzo fisico per ristabilire l’equilibrio dei liquidi. Uno sforzo fisico quello da cui deve ristabilirsi.
Torniamo in comunità. Vuole essere rassicurato che fisserò l’incontro per chiedere al giudice di andare a casa. Insieme, mandiamo la mail.
Dino Buzzati scrisse nel 1939 un racconto intitolato “I Sette Piani” che venne poi inserito nella raccolta “Sessanta Racconti” . Il protagonista, Giuseppe Corte, per una forma leggera di febbre viene inviato in un celebre sanatorio. Al suo arrivo, da un’infermiera, viene informato della strana caratteristica di quell’ospedale: i malati erano distribuiti piano per piano a seconda della gravità. Il settimo, cioè l’ultimo, era per le forme leggerissime. Il sesto era destinato ai malati non gravi ma neppure da trascurare. Al quinto si curavano già affezioni serie e così di seguito, di piano in piano. Al secondo erano i malati gravissimi. Al primo quelli per cui era inutile sperare. Nei primi momenti, Giuseppe Corte si guarda attorno, guarda fuori dalla finestra per scorgere, attraverso le finestre, altri ammalati dei piani inferiori. Dopo la prima visita con il medico, a Giuseppe Corte viene detto che puo’ rimanere nella sua stanza, quella assegnatagli originariamente. Segue scrupolosamente la cura , mette tutto l’impegno a guarire rapidamente, ma ciononostante le sue condizioni rimangono stazionarie. E a quel punto inizia la discesa: un infermiere chiede un favore a Giuseppe Corte, di lasciare la stanza per una madre che sarebbe entrata con due bambini. Avevano la necessità di una camera vicina. Un trasloco che avrebbe comportato la discesa di un piano. Ma è una sistemazione assolutamente provvisoria. Giuseppe Corte non sembra contento della proposta nonostante venga fatta per questioni meramente gestionali e non mediche. Per carità non le venga neppure in mente che ci siano altre ragioni. Ai suoi nuovi compagni di piano Giuseppe preciserà, sin da subito, che lui è del piano superiore dove, al più presto tornerà. Non sarà così e per il protagonista inizierà una progressiva e fatale discesa verso il basso.
Buzzati scrive questo racconto nel periodo di sviluppo dei grandi ospedali categorizzanti, suddivisi per specialità, l’epoca dei sanatori e delle istituzioni totali. La discesa verso il basso, l’esclusione sociale di colui che ha una malattia inguaribile. In questo racconto, ci offre la possibilità di vedere da dentro, dagli occhi del protagonista come ci si sente: l’ottima impressione iniziale, enfatizzata delle parole di Buzzati “la gaia camera”, la descrizione degli spazi come fossero quelli di un albergo, di una struttura di vacanze “tutto era tranquillo, ospitale e rassicurante”. Un’impressione iniziale forse legata al bisogno di affidarsi per il timore e l’incertezza legata alla propria condizione.
E poi il disorientamento, il confronto con gli altri, con la morte che inizialmente viene percepita lontana. Come qualcosa che non lo riguarda. E qualcosa cambia: la malattia da cui non si guarisce nonostante le cure, la progressiva discesa ai piani inferiori senza che vi sia una comprensione della situazione. Traslochi ai piani inferiori richiesti con scuse, con inganni, per questioni logistiche e non cliniche. E insieme al protagonista anche noi che leggiamo, progressivamente, capiamo che qualcosa non va. Che forse quel miglioramento sperato non arriverà.
Il Corte così passò al sesto piano, e sebbene fosse convinto che questo trasloco non corrispondesse a un peggioramento del male, si sentiva a disagio al pensiero che tra lui e il mondo normale, della gente sana, già si frapponesse un netto ostacolo. Al settimo piano porto d’arrivo, si era in un certo modo ancora in contatto con il consorzio degli uomini; esso si poteva anzi considerare quasi un prolungamento del mondo abituale. Ma al sesto già si entrava nel corpo autentico dell’ospedale; già la mentalità dei medici, delle infermiere e degli stessi ammalati era leggermente diversa. Già si ammetteva che a quel piano venivano accolti dei veri e propri ammalati sia pure in forma non grave. Dai primi discorsi fatti con i vicini di stanza, con il personale e con i sanitari, Giuseppe Corte si accorse come in quel reparto il settimo piano venisse considerato come uno scherzo, riservato ad ammalti dilettanti, affetti più che altro da fisime; solo dal sesto, per così dire, si cominciava davvero.
Lo sguardo di Gabriele, in quel tribunale, mi ha fatto pensare al racconto di Buzzati: perché quella continua domanda, quando andrò a casa, come faccio ad andare a casa raccontava dell’impotenza, dell’assenza di comprensione e della difficoltà a credere nella risposta dell’altro. Alla sfiducia. Di chi pensa che tanto si andrà sempre giù e che non succederà quello che viene detto. Perché non ci si sente più soggetti del proprio destino. Giuseppe Corte grida quando si sente preso in giro, andò in furore gridò che lo stavano truffavano, che non voleva sentir parlare di altri traslochi in basso, che se ne sarebbe tornato a casa, che i diritti erano diritti. E dopo essere stato trasferito al quinto piano, con l’inganno, con la promessa del medico che l’errore di assegnazione del piano sarebbe stato presto risolto, smette di protestare, si sente venir meno le forze. È in preda alla febbre. Una febbre che torna in risposta ad una delusione, ad ogni spostamento di piano. Viene ingannato il Corte, lo si illude che in base ai suoi meriti egli potrà risalire di piano. Ma questo non avviene mai. Nonostante la percezione del suo impegno, nonostante ingannevolmente gli venga riconosciuto. Finchè, con un nuovo inganno, lo spostamento al primo piano, quello dei moribondi: la capacità di dominarsi gli era completamente sfuggita. Il terrore l’aveva sopraffatto come un bambino. I suoi singhiozzi risuonavano lenti e disperati per la stanza. La situazione era talmente grottesca che in certi istanti Giuseppe Corte sentiva questi la voglia di sghignazzare senza ritegno.
Gabriele dopo l’udienza in tribunale, nei giorni successivi, si è ritirato in camera. E progressivamente la febbre. Dopo diverse esperienze di Comunità educative, ricoveri in SPDC, comunità terapeutiche, udienze in Tribunale quale piano rappresentiamo per lui?
Credo che la progettualità di Gabriele dovrà partire proprio da questo punto: restituire responsabilità che la malattia non può e non deve togliere. Far succedere le cose che si dicono. E promuovere comprensione e condivisione. Non illusioni o inganni. Per promuovere e stabilire un clima di fiducia. Reciproco. L’unico all’interno del quale è possibile lavorare terapeuticamente.