Commento all’articolo di Danilo Di Diodoro. Apparso su Corriere Salute, il 23/10/21
L’articolo si fonda su interviste a due esperti: Paolo Migone e Bruno Bara. Tenta di esporre criteri di valutazione e risultati delle varie psicoterapie, con l’ormai classico raffronto fra quelle a indirizzo psicodinamico e quelle cognitivo – comportamentali. Articolo dichiaratamente divulgativo, ma a livello dignitoso pur se inevitabilmente semplificatorio. Infatti il problema è complicato e lontano dall’essere risolto.
Qui si parla, beninteso, di interventi rivolti a condizioni psicopatologiche minori, che possono basarsi su rapporti duali o tutt’al più su psicoterapie di gruppo. Diverso è il discorso per la condizioni psicotiche gravi, che comportano interventi articolati e complessi, anche a livello residenziale più o meno protratto: paradossalmente in questi casi la valutazione può fondarsi su criteri più solidi e in parte quantificabili, come la durata di un trattamento residenziale o i parametri indicanti il recupero di un inserimento psicosociale. Ma in queste situazioni la valutazione del collegamento fra intervento ed esito non può essere rivolta solo a eventuali rapporti psicoterapici individuali ma all’insieme di un intervento multifocale: e nel caso della residenzialità, alla terapeuticità globale di un ambiente caratterizzato il più possibile da interscambi con la realtà extraistituzionale.
Ma l’articolo non di questo tratta, ma di situazioni complessivamente meno impegnative. Qui emerge tutta la problematicità della valutazione. Non si può far riferimento alle classiche garanzie metodologiche: difficile identificare un placebo (una finta terapia?); e in ogni caso sarebbe eticamente e tecnicamente mal attuabile una assegnazione random dei casi al gruppo in terapia o a quello della “finta terapia”. Difficile anche definire incontestabili criteri di miglioramento: soggettivi? obbiettivi, magari con ricorso a rating scales? E quanto di un miglioramento è attribuibile al trattamento e quanto a una remissione spontanea? Questo vale soprattutto per terapie assai protratte come la psicanalisi classica. E nei calcoli statistici, indispensabili in ogni valutazione di efficacia, c’è il rischio di sommare mele e pere, metodologie di fatto non uguali a causa di personali caratteristiche tecnico-culturali e personali del singolo terapeuta: per ovviare a ciò si è fatto anche, discutibilmente, ricorso alla compilazione di manuali.
Naturalmente, sul terreno di una verifica mutuata dalle metodiche delle scienze naturali, gli interventi cognitivo – comportamentali si trovano più a loro agio; ben più complessa è la situazione per quelli a indirizzo psicodinamico.
II problema della verificabilità vengono solo in parte superati con la compilazione di metaanalisi; queste parrebbero indicare una certa efficacia delle varie psicoterapie, senza una superiorità di questa o quest’altra che sia chiaramente dimostrata. Si è in parte rinunciato a indiscutibili indicazioni preferenziali : forse si va affermando il verdetto di Dodo in Alice, “tutti hanno vinto, tutti hanno diritto al premio” .
Anche per questo si tende a spostare l’attenzione dagli esiti ai processi, alla verifica di quanto accade momento per momento. Ciò implicherebbe la rinuncia a quello che forse è un compito impossibile: la affidabile valutazione della superiorità o meno di una singola modalità di intervento. Forse conta di più quel fattore comune che è l’empatia, l’incontro personale, il sentirsi presi in carico. In ciò, quanta è ancora l’importanza della tecnica? E quella della personalità del terapeuta?
Tuttavia, c’è qualche indicazione parziale e provvisoria. Nella maggior parte delle metaanalisi la psicoterapia psicodinamica a lungo termine parrebbe più efficace delle terapie brevi, nei disturbi complessi e cronicizzati. Ma qui forse è in gioco il fattore, in sé aspecifico, della durata – solidità del rapporto. Inoltre, si tratta di un dato non adeguatamente verificato. Infatti i singoli studi presi in considerazione nelle metaanalisi soffrono di una comune difficoltà metodologica: un controllo sperimentale stretto, se aumenta la validità interna dello studio, rischia di produrre condizioni diverse da quelle delle realtà clinico-terapeutiche; le procedure necessarie per la manualizzazione e la standardizzazione dei parametri utili alla ricerca possono allontanare questi studi dalla pratica clinica. Del resto, alcuni psicanalisti tendono a negare del tutto la “misurabilità” dei cambiamenti strutturali che costituiscono la finalità stessa della psicanalisi. Proposte importanti come quella della mappa psicodinamica, o della diagnosi psicodinamica operazionalizzata, certo offrono un panorama dei vissuti e interazioni interpersonali, ma sensatamente prescindendo da numeri e da pretese di quantificazione; e in ogni caso paiono appartenere all’ambito delle verifiche di processo, non di esito, sempre ammesso che questa distinzione abbia davvero un senso, poiché le verifiche di processo scaglionate nel tempo indicano anche cambiamenti intervenuti.
Come in altri campi della nostra disciplina, si può cercare un terreno più solido nel collegamento con il dato biologico: pare che i cambiamenti indotti dalla psicoterapia siano sottesi da cambiamenti funzionali e strutturali del sistema nervoso centrale. Ma credo che questo sia un terreno ancora tutto da dissodare.

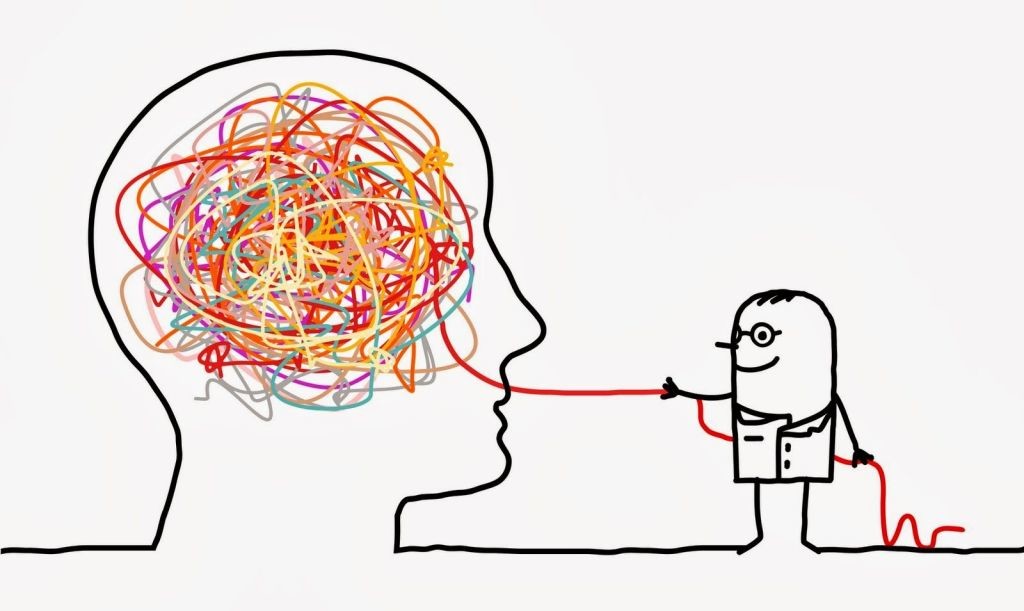















Il tema affrontato dal prof Pisseri apre un vero vaso di pandora. Tanto è potenzialmente vasto l’argomento e complesso. Allora, sarà più importante la tecnica o la relazione? E la personalità del terapeuta quanto influisce? Chi è il terapeuta che ha “personalità?” È più efficace un approccio psicodinamico (“l’universo psicodinamico”, si potrebbe dire vista le numerose scuole in cui si declina) o quello cognitivo-comportamentale che non è certamente meno ricco e frastagliato nelle sue proposte? È così vero che nel dubbio uno/a alla fine sceglie l’indirizzo terapeutico che più si attaglia alla propria personalità? E quali implicazioni può avere un simile atteggiamento sulla “cura”?
Secondo me sono tutte domande retoriche nel senso che non lo sapremo mai con certezza. Ma almeno certa retorica ha il vantaggio di sviluppare la curiosità e l’ingegno e stimola la ricerca. Dunque, qui si potrebbe allargare il discorso prendendola un po’ alla larga se vogliamo, trattando la questione sotto una diversa prospettiva. Per esempio, il dibattito tra approccio psicodinamico e cognitivo-comportamentale viene proposto mi sembra tendenzialmente in termini di opposizione, di antagonismo quasi. Cioè mi sembra che alla fine si finisca per riproporre la classica antinomia “Universale astratto/Universale concreto”. Dove più “astratto” sarebbe l’approccio psicodinamico e più “concreto” quello cognitivo-comportamentale. Messa in questo modo non resterebbe che proporre un momento simbolico di “sintesi degli opposti” in senso “hegeliano”. Quindi astrazione e concretezza tutt’e due danno la “salvezza” (scusate la rima). E quale potrebbe essere il piano d’incontro di questi due universi, dunque? Potremmo azzardare: la “Relazione”. Ok, d’accordo, ma che cos’è esattamente “Relazione?” (altro universo complicatissimo) Trovo molto interessante a questo proposito il concetto derivato dalle evidenze dell’infant research di “Conoscenza relazionale implicita” presente nei bambini già in tenerissima età e che rappresenterebbe una guida con cui il bambino, ma direi anche l’adulto, si servono quando sono in difficoltà e che li spinge ad interagire con il mondo (quando invece la “sofferenza” tende ad interrompere il rapporto col mondo) alla ricerca di un Altro/a che possa apportare il dovuto sostegno (quando da soli non riusciamo a venire a capo dei nostri guai). Allora, mi piace pensare che forse il rapporto terapeutico questo fa, cioè riattiva un tipo di conoscenza che per tanti motivi abbiamo smarrito nel corso del nostro percorso esistenziale. Voglio dire che anche quando ci “limitiamo” a proporre una tecnica di “desensibilizzazione” in realtà quello che stiamo facendo (al di là della tecnica in se stessa) non è semplicemente proporre uno strumento che è legato alla materialità, alla praticità di un’azione, ma, in un senso non privo di una sua idealità, stiamo provando a riabituare la persona ad interagire in modo più funzionale con il mondo esterno servendosi dei consigli di un esperto o della collaborazione di una persona familiare che ha dimostrato al paziente una maggiore sollecitudine nel portargli aiuto.
Per farla breve, i concetti di psicodinamico e cognitivo-comportamentale, di astratto e concreto non sono propriamente – una coppia di concetti opposti ed escludenti, ma una coppia di concetti “distinti” che non sono tra loro necessariamente escludenti, ma che convivono su diversi piani – o strati perché “multistratificato” è l’essere umano che si esprime simbolicamente lungo un continuum – Senso inconscio del Sé-Senso privato del Sé-Senso pubblico del Sé -, potremmo dire. Ovviamente, non sto proponendo di ridurre la discussione sull’efficacia della psicoterapia alla polemica filosofica che opponeva Croce a Hegel. E nemmeno sto suggerendo l’idea del “terapeuta universale” esperto di approcci multipli. L’approccio dovrebbe essere multiplo, semmai. Ma questa è un’altra storia (ideale).
Voglio dire soltanto che in un rapporto terapeutico efficace, forse, si confrontano due persone (o più) che accettano serenamente di poter essere in certi momenti della vita interiormente “astratti” e più “superficialmente” concreti allo stesso tempo. Il terapeuta “efficace” e il paziente “collaborante” sono quelli che tante volte e senza rendersene conto si rivelano – un’autocontraddizione vivente quanto mai però legittima e necessaria -. È qui forse che ha inizio la “relazione” (che ha ricadute terapeutiche) quando la consapevolezza delle proprie intime contraddizioni diventa il primo passo per diventare più indulgenti nei confronti di se stessi e degli Altri aprendoci così nuovamente a quella – conoscenza del mondo che si accompagna al sentimento della responsabilità (verso noi stessi e gli Altri) che credevamo persi per sempre.