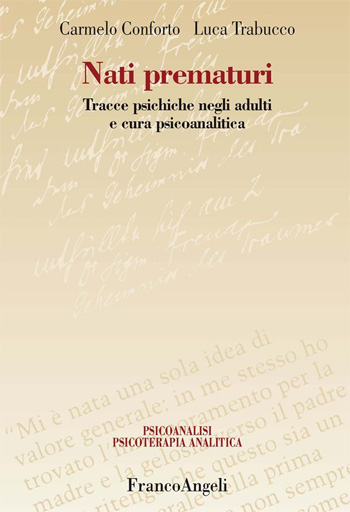Testo del commento al libro di Carmelo Conforto e Luca Trabucco: Nati Prematuri. Tracce psichiche negli adulti e cura psicoanalitica, Franco Angeli, Milano 2014, presentato il giorno 19 Novembre 2014 presso Sala Convegni della CTR La Tolda a Varazze, in via Piave n. 72.
Ciò che della vita intrauterina e del momento cruciale della nascita non sappiamo possiamo almeno rappresentarcelo per via di congettura, se non addirittura grazie a qualche residuo depositato in ciò che, con ancor grande approssimazione, chiamiamo la nostra “memoria implicita”.
Se partiamo dalla nostra capacità di adattamento alle situazioni improvvise o sconosciute, dobbiamo supporre che il passaggio dall’ambiente uterino all’esterno sia segnato dalla più profonda paura e angoscia.
Rispetto a tale transito, infatti, l’ambiente di provenienza è protettivo, buio, umido, morbido, caldo, e in esso i rumori filtrano in maniera ovattata; i suoi confini sono precocemente diventati oggetto di esperienza tattile per essere continuamente esplorati con la superficie cutanea, organo sensoriale in piena funzione, possiamo supporre, già molte settimane prima della nascita (e se un organo sensoriale funziona, una certa proto-rappresentazione di una differenziazione fra sé e non-sé potrà pure iniziare a stabilirsi). Il nuovo ambiente nel quale veniamo all’improvviso proiettati, sputati fuori, espulsi, ci è sconosciuto, privo di confini immediatamente apprezzabili, inaspettatamente illuminato, rumoroso, relativamente freddo, spigoloso, concitato, movimentato, confuso. A esso accediamo attraverso la terribile esperienza della prima apnea seguita dal sorprendente suono della nostra stessa voce che proviene da dentro. Ebbene sì: la cesura è davvero impressionante e angosciante. Ma allora perché mia figlia mi sorrise quando, pochi minuti dopo il parto, la presi in braccio, e le sussurrai una frase affettuosa? Davvero la preconcezione di un oggetto che accoglie è così forte, così viva e urgente da non lasciar spazio né tempo alla paura, alla disperazione?
Sembra che la natura, o l’evoluzione, dotando l’individuo di ciò che Bion chiama preconcezione, aspettativa del seno o dell’oggetto, gli abbia fornito un potente anello di congiunzione, nel passaggio pericoloso sopra l’intercapedine fra due mondi che, almeno in apparenza, non si conoscono: “nasce l’uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento”, ci ricorda il Poeta.
Ma poi, al di là delle combinazioni fortunate in cui il soggetto e l’oggetto si presentano puntuali all’appuntamento, una puntualità che è il vero prototipo di ogni modello di regolazione affettiva, esistono tutti gli altri casi in cui ciò non avviene, tutte le discrasie, disregolazioni, disarmonie, ritardi, interruzioni, cadute nel vuoto, porte chiuse, e ponti pericolanti, appigli che non reggono, deserti che si spalancano davanti con le loro angosciose distese di sabbia, come nel sogno di una mia paziente nel quale lei usciva da una casa assieme a tante persone che la lasciavano indietro, per non trovare più nessuno fuori della porta, finché non incontrò un giovane delinquente che prese a tormentarla con un coltello.
Perché la nascita necessita di una buona accoglienza: è Sándor Ferenczi (1929) a ricordarci che “il lattante è molto più vicino alla non esistenza individuale di quanto non lo sia l’adulto, che ne è separato dall’esperienza della vita. Scivolare all’indietro, verso l’inesistenza, potrebbe quindi essere, per i bambini [male accolti alla nascita], molto più facile” (Ferenczi 1929, pp. 47-48)1.
Nel loro libro, Conforto e Trabucco hanno puntato il loro riflettore su un’area dell’esperienza che ci segue, come individui e anche come studiosi, da tempo, anche se ha faticato a venire, si potrebbe dire per ragioni connaturate alla sua essenza, alla luce. Un’area che ha stentato a farsi riconoscere forse a causa di un pregiudizio narcisistico, che ci fa supporre a lungo, in maniera inconfessata, che il mondo sia nato e muoia con noi. Anzi: che la sua esistenza parta dal punto al quale la nostra memoria narrativa può risalire, in barba a ogni ritrascrizione della memoria, a ogni ricordo trasformato. Ma la storia del nostro “prima” la portiamo iscritta in noi, ed è straordinario quanto possiamo leggere, qui in questo libro, oggi, in termini di attitudine di uno strumento sociale, di una comunicazione condivisa e co-costruita quale è la relazione psicoanalitica, a recuperare ricordi dal pozzo dell’ “irraccontabile” memoria implicita.
Ho lavorato per molti anni nei Consultori del SSN come psichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza, provenendo da una formazione in Psichiatria generale fortemente influenzata dal pensiero psicoanalitico. Quando iniziai a lavorare con bambini piccoli, soprattutto se progettavo di intraprendere percorsi psicoterapeutici, dovetti sopportare numerose frustrazioni, perché, attraverso un lavoro sia pure attento, scrupoloso e puntualmente supervisionato, avevo sempre la sensazione di rimanere all’oscuro di tutto ciò che consideravo essenziale per potermi sentire a mio agio. Possiamo dire che avevo una soglia di tolleranza piuttosto bassa rispetto al rimanere in stati di impasse, di ascolto dell’ignoto, di non comprensione del materiale che scorre davanti agli occhi, una qualità che ho invece apprezzato molto in ciò che traspare dell’atteggiamento emotivo degli autori di questo libro. Decisi allora di bruciare le tappe, perché temevo che quello stato di inerzia non mi avrebbe portato a nulla di utile. Cominciai così a interrogare i genitori, e soprattutto le madri. Volevo sapere tutto di loro, della loro esperienza, e soprattutto dell’ambiente emotivo in cui quel bambino si era sviluppato.
Quando, fino a pochi anni prima, avevo frequentato i corsi “modello Tavistock” di osservazione psicoanalitica del neonato e del bambino prescolare, mi ero spesso scontrato con una mentalità che non riuscivo a farmi piacere. Ogni volta che durante la presentazione del mio materiale portavo qualche considerazione sugli stati mentali che trasparivano nella madre del bambino osservato, venivo redarguito: “adesso non stai osservando il bambino”, mi si diceva. Un anatema che per me, apprendista ostinato oltretutto proveniente dalla psichiatria dell’adulto, era piuttosto difficile da accettare.
Così, dicendomi che l’anamnesi era la cenerentola degli strumenti diagnostici e pertanto era da riscoprire, misi a punto un modello di indagine anamnestica, che non chiamo questionario perché le domande in esso contenute avevano l’intento di suscitare risposte molto libere di spaziare nel tempo e nella memoria, domande che riguardavano non solo la nascita e lo sviluppo del bambino, ma che procedevano dalla costituzione della coppia, dalla sua emancipazione rispetto alle famiglie di origine, allo spazio che in essa aveva avuto o aveva conquistato il desiderio di un bambino, alle ambivalenze e agli eventuali drammi del concepimento, al grado di consenso di entrambi i genitori rispetto ad esso, all’esperienza della gravidanza, del parto, del puerperio, dell’allattamento, dello svezzamento, eccetera. In questo modo, il bambino “nasceva” un po’ anche nella mia mente, acquisiva connotati più precisi, e in qualche non rarissimo caso, l’esperienza dell’anamnesi rappresentava per i genitori un’occasione di scoperta.
Oltretutto, obiettavo a chi mi ricordava la declinazione bioniana dell’ascolto psicoanalitico, fondata sull’assenza di memoria e desiderio, fare psicoterapia con bambini implicava il contatto con una parte intrattabile che rimaneva fuori della stanza: una parte che ha il potere di decidere della terapia, di farla proseguire o di interromperla, di accompagnare puntualmente il paziente alle sedute o di fargliele saltare, di ostacolare in maniera incontrollabile il trattamento o di lasciare che si sviluppi. Il rapporto stesso con le famiglie dei piccoli pazienti rendeva necessario un rapporto con terzi che, nell’analisi di un adulto sarebbe risultata improponibile. E tutti questi elementi esterni diventavano inevitabilmente memorie e desideri che, non potendo essere eliminati, dovevano essere almeno circoscritti.
Ascoltando i racconti delle madri, imparai così che a quell’iniziale disavventura costituita dal periglioso passaggio della nascita occorreva una sostituzione rapida di contenitori: da quello uterino a un altro fatto di calore del corpo, braccia, seno, capezzoli, occhi, voce, sguardo e soprattutto mente. Solo così, per dirla con Ferenczi, il bambino avrebbe potuto “perdonare i propri genitori per averlo messo al mondo”. Ma così, nel mio mondo professionale, non era.
L’esperienza di lavoro al Consultorio ci metteva a contatto con bambini che avevano incontrato fredda accoglienza (o anche molto peggio) da madri tossicodipendenti, o psicotiche, depresse, immature, a loro volta gravemente deprivate, e neppure troppo di rado, persino gravemente perverse. E da padri violenti, alcolisti, abbandonici, paranoici, delinquenti, pedofili.
Un capitolo particolare lo ebbero gli esiti delle depressioni puerperali e delle ospedalizzazioni prolungate che sottoponevano la diade a interruzioni, laddove avrebbe dovuto esserci un pronto ricongiungimento da far seguire alla cesura.
Dopo un po’ la preconcezione del seno sembra andare incontro a un processo di spegnimento, a un ripiegamento depressivo, a forme di rassegnazione, e i successivi ricongiungimenti si rivelavano spesso –quando era troppo tardi- dei “come se” costituiti da legami apparenti, fittizi, da relazioni di attaccamento prive di reale contatto, caotiche, destinate ad esplodere in gravi disturbi del comportamento quando fosse iniziata la crisi adolescenziale. Per non parlare di tutti quei bambini la cui esperienza di vita era stata interrotta da ulteriori e ancor più gravi cesure, dall’esperienza dell’abbandono, dell’istituto, e di adozioni-trapianto che spesso davano luogo a ingestibili reazioni di rigetto.
Quegli stessi bambini che impariamo a conoscere oggi, adolescenti disperati, in comunità terapeutiche come le Tughe.
Fu così che mi mossi, successivamente, in direzioni che facevano precedere la conoscenza della storia dell’individuo all’incontro diretto, il “da dove vieni?”, almeno idealmente prima ancora del “chi sei?”.
Ma non può esistere alcuna storia senza una protostoria e una preistoria.
Se la protostoria individuale del soggetto può essere fatta coincidere con una cesura tanto più arcaica quanto più precoce, qual è quella studiata da Conforto e Trabucco nei ricordi dei pazienti che furono bambini nati prematuri, anche la relativa preistoria può essere oggetto di ulteriori riflessioni.
Dico ciò perché ho in mente la vicenda di una bambina, che chiamerò Elisa, figlia di un mia paziente, che era stata concepita in vitro e in seguito sottoposta a crioconservazione dello zigote per un periodo abbastanza lungo, a causa di una serie di problemi familiari che avevano fatto scegliere ai genitori un consistente differimento dell’inizio della gravidanza.
A gravidanza iniziata, la madre si appassionò intensamente nella relazione con Elisa, al punto di parlarle ad alta voce quotidianamente per lunghe ore; ma, al quinto mese di gestazione, si rese necessario un parto prematuro. In quella circostanza, la madre si ritirò completamente dalla figlia, sostituita però dal padre che fu presente in maniera assidua accanto all’incubatrice, riuscendo a galvanizzare le energie dell’intero reparto perché costituisse un cordone di attenzione affettiva attorno alla figlia. Passarono diversi mesi, fintanto che il padre e il personale del reparto non riuscirono a convincere la madre, che versava in uno stato di prostrazione depressiva, a riavvicinarsi al capezzale della figlia facendole sentire di nuovo la propria voce. Il racconto fattomi dalla donna di quel primo contatto rese in maniera efficacissima la travolgente emozione provata da entrambe le parti, madre e figlia, sia per la reazione della bambina all’ascolto della voce materna, sia per l’intensa commozione della madre. Dopo di ciò la donna fu sempre accanto alla figlia, giorno e notte, per tutto il restante tempo di permanenza in incubatrice.
Entrata in casa, la bambina ebbe uno sviluppo psichico normale, a fronte di uno sviluppo somatico piuttosto deficitario, finché, giunta all’adolescenza, divenne anoressica.
Il seguito di questa storia passa attraverso una lunga psicoterapia condotta con successo da un nostro collega, e oggi Elisa è una professionista di successo.
Se penso a eventi remoti come la crioconservazione dello zigote, non posso pensare che a una preistoria evolutiva caratterizzata da catastrofi delle quali non sarei particolarmente stupito se persistessero delle tracce mnestiche.
Il lavoro di Conforto e Trabucco ci riporta questa riflessione di Bion:
“È possibile per noi psicoanalisti pensare che possano esserci ancora, nell’essere umano, tracce che suggeriscano la sopravvivenza nella mente, come nel corpo, di resti di quelle che furono cavità ottiche nel campo visivo, e nel campo auditivo di quelle che furono le cavità uditive? Questo potrebbe sembrare un problema accademico e privo d’importanza, a meno di pensare che possa esserci una qualche verità nell’affermazione … che vi sia una comunicazione tra pensieri ed emozioni post-natali e la vita prenatale. (Bion, 1977)2.
E allora mi chiedo: fino a quale limite è lecito spingersi? Forse che l’ancor più impressionante cesura costituita da una sospensione nel ghiaccio e da una lontananza senza tempo fra madre e embrione potrebbe costituire un antichissimo prototrauma?
Certo il ripetersi di tre eventi traumatici: l’idea di un impianto differito, di uno zigote immerso in una notte solitaria e glaciale senza tempo, è suggestiva di un trauma antichissimo; poi, a questo evento segue la precoce interruzione del soggiorno intrauterino, il ritorno dentro un mezzo alieno quale l’incubatrice, la nuova separazione dalla madre. E infine l’anoressia mentale, un ulteriore episodio di decostruzione del sé corporeo: c’è materia per ipotizzare una Nachträglikheit ripetuta, una riscrittura infinita del medesimo farsi e disfarsi della vita
Certo è difficile credere a un’ipotesi tanto fantascientifica. Perché, se memoria traumatica vi è stata, su quale supporto neurologico potrebbe essersi depositata e conservata? In quale memoria di massa? Si può supporre che nulla possa essere ritenuto dalla memoria prima che il Sistema Nervoso Centrale abbia raggiunto un certo livello di maturazione: ma è poi così necessario che ci sia un cervello perché possano essere presenti delle impressioni sensoriali o addirittura delle spinte motivazionali?
Non ne sembra convinto Sándor Ferenczi che, in una nota del 10 gennaio 1932, del Diario Clinico affronta il tema del “salto inesplicabile nel corporeo” che caratterizza l’isteria di conversione.
Partendo da un testo di Michael Balint3 , Ferenczi ipotizza la sopravvivenza, anche virtuale, di originarie attitudini della materia (organica e persino inorganica) ad essere mossa da motivazioni.
L’ipotesi è molto suggestiva: in tempi immemorabili, l’organismo sarebbe stato composto di materia “erotizzabile”, cioè soggetta a forze desideranti.
E’ una delle ipotesi scientifiche su cui si basa “Thalassa” (1924), poi sviluppata nel citato lavoro di Balint.
In “Thalassa” (1924)4, anche l’ontogenesi è descritta nella forma di una grande costruzione congetturale che ha per vettore l’ipotesi di un’originaria diffusione del carattere erotico-eccitabile della materia organica, progressivamente differenziatasi in funzioni utilitaristiche non più influenzabili per via psichica, ma soggette, almeno nel caso dell’isteria, a forme di regressione che renderebbero ragione del misterioso salto dal corpo all’”anima”. Quindi, per Ferenczi, la parola “isteria” diventa sinonimo di “pensare con il corpo”, il quale è formato di una materia biologica in grado di avere cognizioni, memorie, spinte motivazionali.
E, per concludere, aggiungo che anche in assenza di ipotesi così suggestive, si può riflettere sul fatto che la memoria individuale di un essere relazionale quale è l’uomo, non è la sola risorsa in grado di conservare contenuti mnestici. Ho scritto in un precedente lavoro5 che il soggetto ricorre frequentemente all’utilizzo di una “mente esterna”, tanto in periodi precedenti il raggiungimento dell’autonomia, quando alla mente materna sono delegate tutte le funzioni inerenti la sopravvivenza, sia come fonte di nutrimento che come strumento di protezione e “base sicura” (Bowlby, 1988)6 cui tornare a ogni segnale di pericolo, sia nei casi delle gravi esperienze dissociative di cui Ferenczi parla nel suo “Diario Clinico”7, quando le memorie traumatiche sono depositate in un “fuori” spesso sconosciuto al soggetto; un fuori che ha molto a che vedere con la sua preistoria.
NOTE
1. Ferenczi S. (1929), Il bambino male accolto e la sua pulsione di morte, in: Opere di S. F., Vol. IV, pp. 45-49, Milano: Raffaello Cortina, 2002.
2. Bion W. R. (1977), Caesura, in: Il Cambiamento Catastrofico, Torino: Loescher, 1981, p. 83.
3. Due note sulla componente erotica delle pulsioni dell’Io” (Balint 1933), pubblicato per la prima volta in Int. Z. F. Psa, 1933, 19, pp. 428-433. La traduzione italiana è presente nella raccolta: Balint M., L’amore primario. Gli inesplorati confini fra biologia e psicoanalisi. Edizione italiana a cura di Gino Zucchini. Milano: Raffaello Cortina, 1991.
4. Ferenczi S. (1924), Thalassa. Saggio sulla Teoria della Genitalità, in S. F. Opere, vol. III, pp. 303-336. Milano: Raffaello Cortina, 1992.
L’opera è stata pubblicata anche in volume indipendente presso vari editori, fra i quali Astrolabio (1965), e lo stesso Cortina (Collana “Minima”, 1993).
5. Guasto G., Orpha l’irriducibile vs. Thanatos l’irresistibile. Morte e sopravvivenza nel pensiero di Sándor Ferenczi (in corso di pubblicazione).
6. Bowlby J. (1988), Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento. Milano: Raffaello Cortina 1989.
7. Ferenczi S. (1932 1985), Suggestione, intimidazione, imposizione di una volontà estranea. Nota del 24 Gennaio 1932, in: Diario Clinico. Milano: Raffaello Cortina, 1988, p. 66.