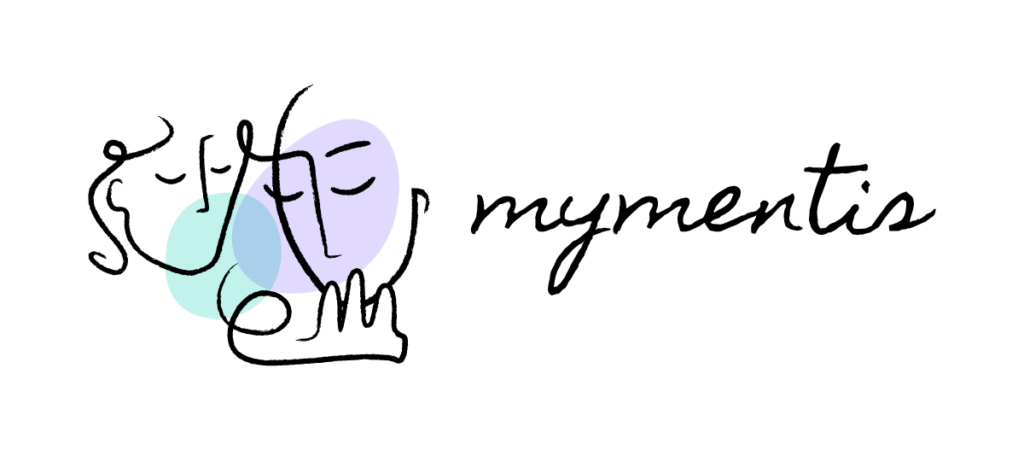Il vostro collega si vanta continuamente a lavoro? Potrebbe avere una sofferenza psichica senza saperlo, vediamo nel dettaglio.
L’effetto Dunning-Kruger è un fenomeno psicologico in cui le persone che hanno scarse competenze o conoscenze in un determinato campo tendono a sottovalutare le proprie lacune e a sovrastimare le proprie capacità in quel campo. Ciò può portare a comportamenti e decisioni irrazionali o pericolosi, poiché le persone credono di essere più competenti di quanto non lo siano realmente.
L’effetto Dunning-Kruger è stato scoperto da David Dunning e Justin Kruger, due psicologi dell’Università di Cornell, nel 1999. I loro studi hanno dimostrato che le persone che ottengono risultati peggiori in un compito tendono a sottovalutare le proprie prestazioni e a sovrastimare le proprie capacità. Al contrario, le persone che ottengono risultati migliori tendono a sottovalutare le proprie capacità e a sovrastimare le proprie prestazioni.
Ci sono diverse ragioni per cui le persone possono soffrire di effetto Dunning-Kruger. Una delle principali è l’ignoranza: le persone che hanno scarse conoscenze in un determinato campo possono non essere consapevoli delle loro lacune e quindi credere di essere più competenti di quanto non lo siano realmente.
Inoltre, l’effetto Dunning-Kruger può essere accentuato dall’ego e dalla mancanza di autocritica: le persone possono essere troppo sicure di sé e non essere disposte ad ammettere di avere bisogno di imparare o di migliorare le proprie competenze.
Il vantarsi delle proprie competenze o conoscenze può essere un segno di effetto Dunning-Kruger, ma non è sempre così. Alcune persone possono semplicemente essere naturalmente sicure di sé e non avere problemi ad ammettere le proprie lacune, e quindi non soffrono di questo effetto.
Tuttavia, è importante essere consapevoli delle proprie conoscenze e competenze reali e cercare di evitare di vantarsi di ciò che non si conosce o non si sa fare bene. Un modo per farlo è cercare sempre di imparare e di migliorare le proprie conoscenze in un determinato campo, e di essere aperti a ricevere feedback e a correggere eventuali errori.