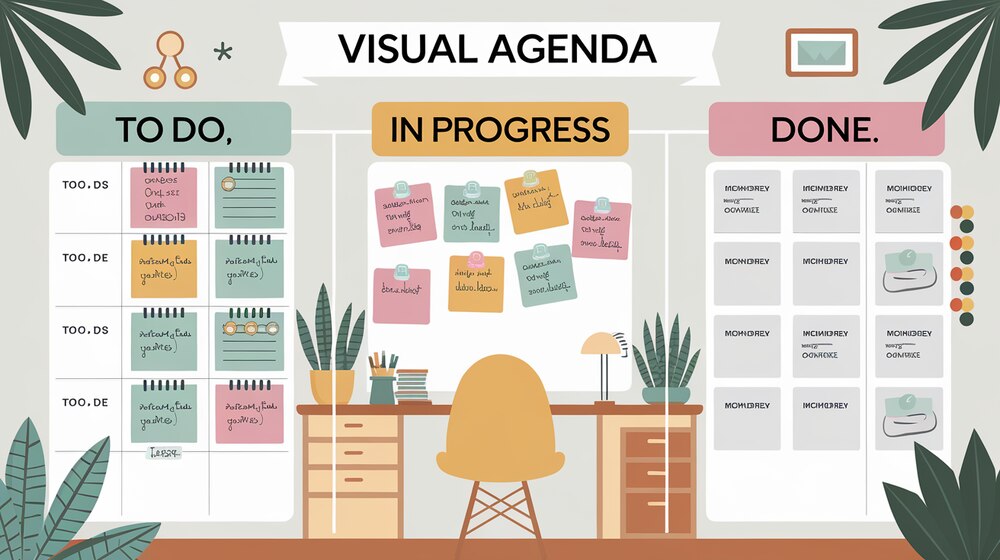Giro con la macchina in mezzo alla nebbia della pianura padana. Le distese pianeggianti, solcate dalle strade ad una corsia di marcia, squarciano piccoli paesi di provincia dove tutto mi sembra opaco. Mercoledì pomeriggio mi incontro con dei pazienti per una terapia di gruppo settimanale. Quanta sofferenza c’è in loro. E io cosa posso di fronte a tale dolore? Se non soffrire insieme a loro.
Il mondo al di fuori della stanza di terapia mi sembra così ipocrita ed irreale. Persone che con fatica erigono maschere, che tengono assiduamente, per allontanare la propria sofferenza. Maschere che da difesa diventano il principale persecutore. Fisse ed immutabili.
È giovedì mattina. Guardo gli alberi, che smossi dalla leggera brezza del vento, si muovono sinuosi nel torpore del mattino. Non si trova parcheggio nel centro. Sono in ritardo per vedere Asia. Mi racconta di sentirsi molto sola. È in ansia perché non sa cosa fare del suo futuro. Che lavoro fare? Che cosa fare della mia esistenza? Troverò mai qualcuno che mi ami? Cerco di starle accanto, vicino, ma non troppo da soffocarla. Le vorrei dire che in futuro andrà meglio, che non si sentirà più così sola. Lo spero dentro me stesso. Ma rimango in silenzio. In fine dei conti è possibile che lei possa avere una vita piena, ma chi sono io per poterlo garantire. Vorrei solo che uscisse un minimo sollevata dai nostri incontri. Penso internamente a quanta delicata sia. Si prende cura delle sorelle. È una ragazza che sa amare.
Cerco di prendermi cura di lei senza farle male. Lei viene in terapia per parlare e condividere il suo mondo e io ci entro volentieri. A volte quello che sembra poco è già sufficiente.
Mentre ritorno al mio studio privato. Ripenso ai miei anni in comunità psichiatrica. La legge Basaglia avrebbe dovuto trasformare i vecchi manicomi in comunità sul territorio più umane.
Ed in fondo c’è riuscita. Però a quale prezzo?
Mi ricordo di una paziente. Si era innamorata di me che facevo l’operatore. Lei era molto malata, di una grave schizofrenia. Soffriva molto. Veniva da una serie interminabile di ricoveri. È cresciuta in una situazione di totale abbandono, violenza e abuso. Situazioni indicibili.
All’inizio ho provato a prendermi cura di lei. Le volevo davvero molto bene. Vedevo tutta la sua fragilità e tristezza che risuonavano dentro di me in modo potente. Mi piacevano anche le sue lusinghe. Mi facevano sentire importante. Io la trattavo come una donna degna di rispetto e di valore.
Poi le cose sono incominciate a peggiorare. Voleva che io fossi un suo possesso. Voleva una simbiosi totale. Una sera scappò sotto la pioggia a piedi nudi in mezzo alla campagna. Ero preoccupato che si facesse male. La ritrovai piangente al buio. Mi disse che stava seguendo dei cavalli che aveva visto, dei cavalli liberi, dei cavalli selvaggi. Mi guardai intorno. La luna pallida illuminava debolmente il terreno. Non vidi niente tranne la pianta insanguinata dei suoi piedi.
La riportai in comunità. Si addormentò velocemente.
Tornando a casa mi sentii terribilmente in colpa. La stavo forse illudendo col mio amore. Le davo forse false speranze di qualcosa che in fin dei conti non posso darle. Lei vedeva in me un ideale. Io mi sentivo un uomo qualunque. Anche se con lei mascheravo. Con lei volevo essere quella figura maschile che non ha mai avuto. Un uomo che la riempisse di rispetto.
La situazione peggiorò ancora. Un giorno mi saltò addosso. Aveva il ciclo. Mi sporcò di sangue. Non sapevamo niente sul suo stato di salute perché rifiutava le analisi. La guardai in viso. Rideva. Mi aveva umiliato ed era divertita. Lì capii che mi stava facendo rivivere il suo vissuto. Umiliata, degradata, abusata. Mi sentivo sporco. Mi sentivo inutile. Io le davo amore e lei mi ripagava con il suo sadismo. Avrei potuto continuare in quella dinamica. Ma sarebbe stato sano? Per me? Per lei?
Decisi di fare l’unica cosa che potesse essere un ultimo segno di rispetto mio e suo. Le posi un limite. Il CSM non voleva prendersela in carico. Nessuno voleva averci a che fare. Veniva mandata di comunità in comunità. Era la follia in persona. Le istituzioni ci avevano abbandonato, i colleghi osservavano impotenti, io ero stritolato tra la mia volontà di cura e la sofferenza annessa. La denunciai. La denuncia decadde subito perché era interdetta. Però lei capì. Venne in questura e parlò con il carabiniere. Era ferita. Fuori di sé. Mi chiese di non denunciarla. Ma la situazione ormai era andata. Non tornò più in comunità. Mesi dopo venni a sapere che si prostituiva nella periferia della città. Era ritornata alla sua infanzia quando la madre la costringeva a farlo. Mi sentii uno schifo. Forse avrei potuto continuare.
L’arrestarono poco dopo per violazione del coprifuoco durante il lockdown. La mandarono in una comunità in veneto. Non seppi più niente di lei.
Al lunedì pomeriggio lavoro in ospedale. Anni prima ci avevo svolto il tirocinio. Mi rimarrà sempre in mente uno dei miei primi pazienti. Io seguivo la mia tutor che faceva dei colloqui al letto dei pazienti per i vari reparti. Incontrammo un uomo allettato. Sembrava molto più giovane della sua età. Era scappato dalla comunità. E si era steso con le braccia aperte sulle rotaie. Vennero tranciate di netto. In ospedale era completamente fasciato. Aveva lo sguardo più triste che avessi mai visto. Uno sguardo vuoto. Perso nel nulla. Ci aveva già provato in passato a morire. Si era conficcato un coltello di 14 cm in pancia. Mi chiedo quale forza di volontà servisse per fare una cosa del genere. Quanta disperazione. Lo guardavo. Avevo la nausea. I genitori erano morti da tempo. L’unico che veniva a trovarlo era un lontano cugino. Che stava pochissimo. Era completamente solo. Mi chiesi quale Dio potesse permettere un destino talmente crudele. Ma tanto dio non c’è. E la natura è indifferente alla condizione umana. Dopo un po’ lo dimisero. Non lo rividi più. Mi ricordo di aver pensato che l’avrebbe rifatto. Non era più tra noi da molto tempo. E forse era giusto così. La morte a volte è una salvezza. Il suicidio è un atto di libertà in quelle condizioni.
A psichiatria all’università mi rimase impresso un racconto. Un uomo cercava in tutti i modi di uccidersi. Lo rinchiusero per salvarlo in una stanza imbottita con niente dentro a parte un materasso. Lui saltò sul materasso per sbattere la testa contro il soffitto. È morto di emorragia cerebrale.
Non si può salvare chi non vuole essere salvato. E già nel primo caso salvare è terribilmente difficile. Sempre che salvare sia il termine adeguato. Forse è meglio dire lenire per quello che si può la sofferenza, che è intrinseca alla vita umana.
Mentre tornavo a casa ripensavo a questo scritto e alla psicoanalisi. Quanti libri scritti sulle dinamiche in analisi. Quanti ne ho letti per sapere cosa fare e dire in terapia. Ma alla fine è tutto un flusso. La tecnica conta poco. Quello che serve è essere lì con loro, soffrire con loro, amare. Vedo le colline in lontananza, rischiarate dal tramonto del sole e sono pieno di dubbi.
Forse la vita è già tutta lì davanti a noi. Già scritta.
Spesso sono in macchina. Giro per la pianura per recarmi nei diversi centri dove incontro delle persone che soffrono e vogliono stare un po’ meglio. Penso spesso a quanto la vita in fondo offra costantemente un’ingenua illusione di felicità. Eppure, anche se il mondo ti sbatte in faccia la dura verità, noi la ignoriamo. Perché non possiamo fare altro per sopravvivere. Eppure, quando guardo la sofferenza in faccia, la mia e degli altri capisco che in fin dei conti c’è qualcosa al di là, della semplice rappresentazione, che si cela nell’ombra. Lì, in quel luogo tetro e buio, l’abisso orrido, si vedono cose particolari, dove tutto sembra avere un senso. Una logica. Una spiegazione. Ma anche questa forse è una pia illusione.
Forse la trama del tempo e dello spazio è già li. Davanti a noi. Pronta per essere vissuta ma immodificabile. Forse la matrice della realtà fisica è solo una delle tante dimensioni e la malattia mentale è il luogo di accesso ad una realtà separata. O forse mi illudo, che anche queste sono mie fantasie. Il mondo è più crudele della mia ricerca di un appiglio eterno.
Mi piace pensare che l’oblio sia inevitabile. Perché l’alternativa mi sembra peggiore.