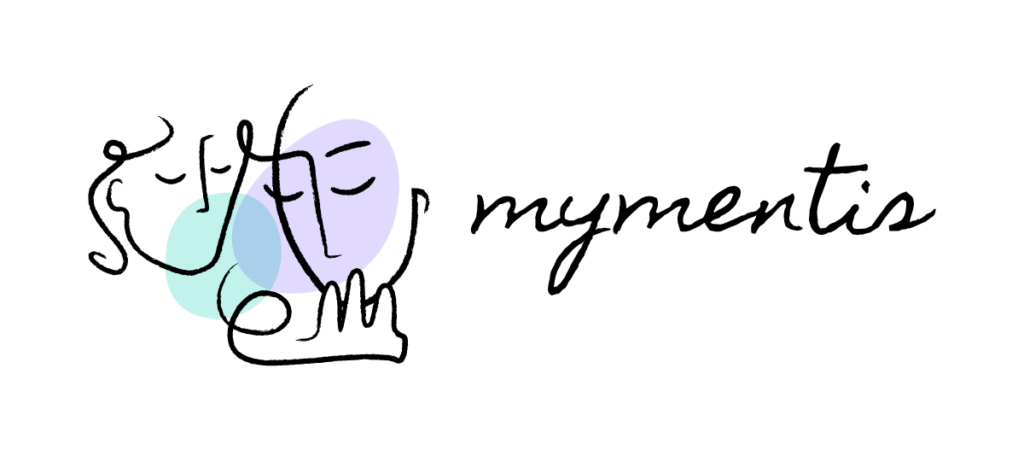Come abbiamo già visto in un altro articolo, oltre l’effetto placebo abbiamo anche il suo contraltare: l’effetto nocebo.
L’effetto nocebo è un fenomeno in cui una persona sperimenta una reazione negativa o un effetto collaterale dopo aver assunto un placebo, cioè una sostanza inerte che non ha alcun effetto terapeutico. Ciò può accadere se la persona crede che il placebo possa avere effetti negativi o se è stato detto loro che il placebo potrebbe causare effetti collaterali. L’effetto nocebo può essere influenzato dalla persuasione e dalla suggestionabilità della persona, nonché dalle aspettative e dalle credenze del medico o del fornitore di assistenza sanitaria. È importante che i medici e gli altri fornitori di assistenza sanitaria siano consapevoli dell’effetto nocebo e si assicurino di comunicare in modo trasparente e accurato con i loro pazienti per evitare di creare aspettative negative o di indurre l’effetto nocebo.
In psicologia, entrando nel dettaglio, l’effetto nocebo viene spesso studiato in relazione alla percezione del dolore e alle reazioni psicologiche alla terapia. Ad esempio, un recente studio ha mostrato che le persone che sono state informate che un farmaco avrebbe potuto causare effetti collaterali come nausea e vomito hanno riportato più frequentemente questi sintomi, anche se avevano preso solo un placebo. Altri studi hanno dimostrato che le aspettative negative possono influire sulla percezione del dolore e sulla risposta al trattamento del dolore, indipendentemente dal tipo di trattamento o farmaco che viene utilizzato. L’effetto nocebo può anche essere influenzato dallo stato emotivo e dalle credenze della persona. Ad esempio, le persone che sono ansiose o depresse potrebbero essere più suscettibili all’effetto nocebo, poiché potrebbero avere aspettative negative o credenze negative sulla loro capacità di gestire il dolore o di rispondere al trattamento. Inoltre, l’effetto nocebo può essere influenzato dal rapporto tra il paziente e il fornitore di assistenza sanitaria. Una relazione positiva e una comunicazione trasparente possono ridurre il rischio di effetto nocebo, mentre una relazione negativa o una comunicazione inadeguata possono aumentare il rischio, condizionando tutti gli aspetti della vita dell’individuo. Ecco perché le agenzie educative primarie (famiglia e scuola) hanno il compito e la responsabilità di conoscere e indagare gli le conseguenze dell’effetto nocebo, impostando il proprio dialogo su una base costruttiva, ricettiva ed empatica.