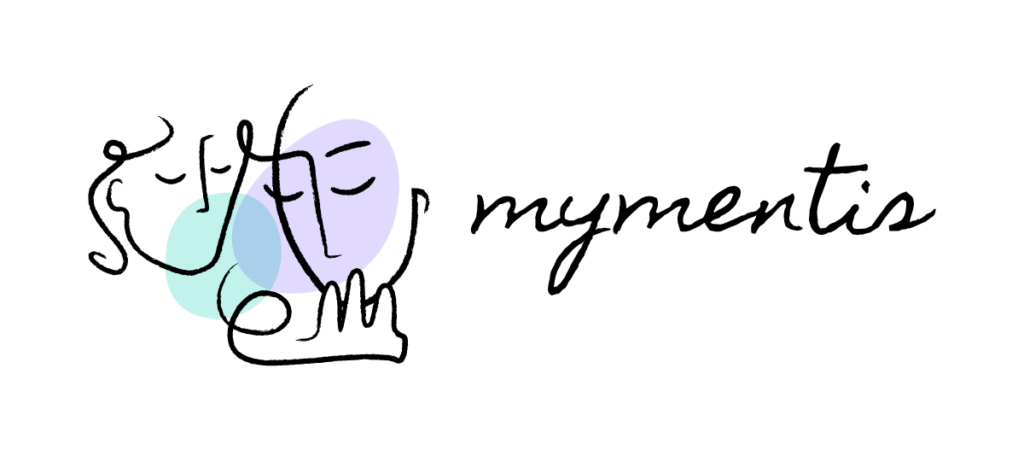Spara alle gambe di due superiori e poi si toglie la vita.
Così, tragicamente, ha deciso di porre fine alla sua esistenza un operatore ecologico, di quarantadue anni, arrivato armato a lavoro in Sardegna, ad Alghero.
Antonio Rosario Urgias, come ogni mattina, ormai da quattro anni, si è recato, prima dell’alba, sul posto di lavoro. Il giorno del misfatto, però, non si è andato a cambiare e tantomeno ha salutato i suoi colleghi come era solito fare. L’uomo doveva essere in malattia ma si è allontanato dalla sua abitazione, a dieci minuti dalla sede dell’azienda in cui lavorava, con un solo obiettivo: farla pagare a due dei suoi superiori.
Ha puntato una pistola alle gambe del suo capo area e, anche, a quelle del responsabile dello stabilimento che, nella città, gestisce la raccolta dei rifiuti comunali e ha prontamente sparato. Pochi e precisi colpi con una pistola semiautomatica a segno, prima di essere allontanato da altri colleghi, del tutto sotto shock. Nessuno però è riuscito davvero a fermarlo, inconsapevoli di quello che avrebbe fatto di lì a breve: Urgias si è abbandonato su una sedia e si è sparato.
Intorno a lui tutti stavano cercando di soccorrere i due feriti che sono stati immediatamente trasportati, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, al nosocomio della cittadina. Sono stati fatti rilievi da parte della scientifica e dei carabinieri, così come sono state avviate le indagini per capire la motivazione per cui l’uomo avesse con sé una pistola.
Il quarantaduenne era soprannominato con l’epiteto dialettale “patacò” che simbolicamente denotava la sua tendenza a intervenire, sin da ragazzino, in ogni discussione. Anche in maniera violenta. Padre di una ragazzina di sedici anni, aveva anche una compagna ma, da tempo, viveva da solo.
Secondo alcune indiscrezioni avrebbe avuto alcune discussioni, proprio con il capo area in merito ad un presunto ammanco nella busta paga di poco più di centocinquanta euro. Una cifra esigua ma per lui sufficiente a giustificare il suo gesto estremo che l’ha portato a gambizzare i due uomini e, poi, a farla finita.
Ennesimo gesto estremo che testimonia il disagio mentale di uomo che avrebbe dovuto avere un supporto psicologico. Ad avvallare la tesi è il ritrovamento di una lettera da lui stesso scritta e consegnata al suo legale, di oltre dieci pagine in cui spiega il movente del suo agire. Il testo è attualmente nelle mani di chi sta indagando sull’accaduto.