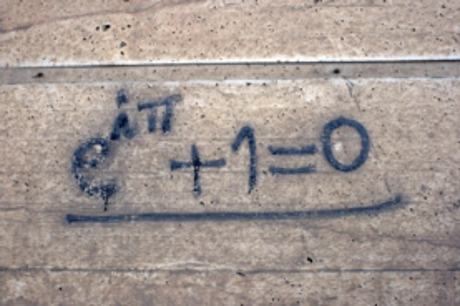Percezione di una forma del morire e dell’atteggiamento con cui la transizione è vissuta
Di chi è la vita? Mia? Della natura? Di Dio? Della società?
– La fierezza grave di chi compie un gesto “storico” di eversione?
O la quotidiana svagatezza di chi decide di prolungare la passeggiata?
Va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente -.
Comunque la pensiate!
Mi sono sempre chiesto quale atteggiamento può assumere l’individuo di fronte a questo “tipo di esperienza del morire”. Non riesco a chiamarle semplicemente “pratiche e problematiche concernenti la fine della vita” (stavo per dire – il “fine” della vita -) Espressioni “burocratiche” queste che tacciono fatalmente tutto il tormento, la lacerazione, immagino, che accompagnano le persone che si ritrovano a dover prendere delle decisioni così fondamentali e oltremodo “rigorose”, mi verrebbe da dire. O forse, più semplicemente, è vero che ci sono interrogativi che non ci poniamo nemmeno perché certe questioni non offrono punti di riferimento validi che possano confortarci in assoluto nelle decisioni che prendiamo e nei comportamenti che agiamo?
Quando si trattano argomenti così incerti e strazianti sono forse inevitabili le fluttuazioni per non dire i veri e propri tentennamenti del discorso e della volontà soprattutto. E anche certe deviazioni improvvise di questo pensiero a ruota libera e i – flussi e riflussi del rimuginare – fanno sì che questa riflessione si articoli in un groviglio tante volte inestricabile (apparentemente) dal quale spero almeno che tutti possano ricavare una propria teoria – il fascino della quale sta proprio nel fatto che ciascuno non potrà provarla -.
Avviso i naviganti che qui la “discussione” assumerà fatalmente la forma del “dibattito interiore”. Dico “fatalmente”, ma in realtà è proprio questa la struttura del discorso che ho ricercato (invano, forse) perché mi sembrava l’unico modo di evitare il rischio di – ergermi ad interprete di emozioni e pensieri altrui soprattutto di coloro che si ritrovano a “dover” fare certe “scelte” nel corso della loro vita -. Inoltre, non ritengo di dover fare della “morte assistita” un caso emblematico di “mala educazione” o di “mala sanità” men che meno, né di perversione sociale e culturale men che mai. Credo sia necessario come non mai fuggire l’effetto “pedagogico”, in questo caso.
Spero almeno che questa “ricerca di senso” non si risolva soltanto in un “riflesso menzognero”, ovvero – quella maniera un po’ affettata di deresponsabilizzarsi per non prendere una posizione -.
Non mi va di assumere qui il ruolo semplicemente del sofista, disposto a patrocinare la “dialettica” di qualsiasi tesi col rischio che l’anelito all’obiettività sfumi nel qualunquismo. Invece, condivido l’opinione che sia impossibile assumere un atteggiamento davvero imparziale, di fronte a discorsi che attengono ai sentimenti umani più profondi e intimi. Più che all’imparzialità mi rivolgerei alla meno pretenziosa “sospensione del giudizio”, eventualmente, che almeno ha il pregio, se non altro, di esprimere tutta la straordinaria complessità insita nel perorare una determinata ragione a sostegno di una propria scelta. È tutto molto complicato, di sicuro!
E come potrebbe essere possibile, poi, dimostrare razionalmente la liceità o illegittimità dell’eutanasia o del suicidio assistito? Mentre ci penso la mia “ragione” non può non entrare inevitabilmente in una serie di antinomie, cioè in contraddizioni con se stessa: scopro in realtà interpretazioni logicamente sensate sia ammettendo la loro possibilità che la loro impraticabilità (cioè, l’opposto). Così come sarebbe altrettanto problematico dichiarare con certezza se esista una libertà di scelta o valga soltanto il principio di causa-effetto.
Ci tengo a precisare che non mi rivolgo ad una categoria particolare o individui specifici vista anche l’eterogeneità delle opinioni in materia, presumo. Però altrettanto onestamente devo concedere che in qualche misura mi aspetto anche un minimo di “partecipazione” ai temi trattati qui. Certe argomentazioni non le presenterei di certo ad un convegno di “Comunione e Liberazione”, né ad un raduno dell’ennesimo “family day de noantri”, sebbene osi sperare di poter trovare anche lì qualcuno disposto ad ascoltare certe elucubrazioni.
*****
Dunque! – Morire di passato -. Si può? I ricordi possono davvero rovinarti addosso senza ritegno. I ricordi a volte possono essere come un peso apposto sopra una mannaia che ti pende perennemente sulla testa e ti ritrovi lì a sperare che la lama si abbatta su di te in caduta libera, finalmente.
“Esistere”: Congelamento di un’azione mai esaurita, decorso di un atto mai concluso. E procedo verso un tempo inesistente. Una temporalità multipla, caotica, interna senza una successione cronologica segna la fine della mia narrazione. R-esisto in questo “presente emozionale acronico” in un’ “ora” che non è adesso, ma neppure è coscienza di un “ora” passata; dove la storia si arresta sine die; dove tutto è reversibile, tutto è surrogabile, tutto è riparabile. Tutto succede “inutilmente”, finalizzato com’è all’inutile scopo del perseverare. Una fine sospesa. Che si rinnova ad ogni istante. E la vita si riduce ad un “protocollo di sopravvivenza”. Sono un’ “operazione tecnica”, seppure di una certa complessità, bontà vostra.
Continua il mio corpo ad essere utilizzato, pur nello stato cadente in cui si trova, per soddisfare i bisogni di immortalità di questo ambiente artificiale, fatto di uomini e apparecchiature e strumenti manipolati dall’uomo. Un corpo che non verrà distrutto, almeno fino a quando continuerà a soddisfare più e più volte il bisogno di proteggersi dal pensiero agghiacciante dell’inevitabilità della morte stessa. Più che un corpo umano un bene di consumo durevole cui è stata allungata surrettiziamente la data di scadenza.
Un corpo ridotto a semplice meccanismo che reagisce soltanto ad uno sguardo fisico-chimico. Il vostro sguardo “matematico” incontra un corpo “oggettivato”, un organismo chiuso in un isolamento irreale e fisicistico. Un corpo “feticcio”, mi verrebbe da dire: non un “essere” (umano) ma un “oggetto” di venerazione, il “manufatto antropomorfo di una società tribale. Cos’altro è questo accanimento se non “culto per il corpo”? Non mi sembra – rispetto per la vita -, ma venerazione di una “statua inanimata” di fatto. Non è forse una forma di feticismo quello di concentrare le proprie attenzioni semplicemente sul corpo e le sue parti organiche? In questo caso l’uomo è capace di autoconsolarsi adorando la classica “parte (il corpo) per il tutto (l’essere umano fatto di corpo e mente e psiche e relazioni e non necessariamente in quest’ordine)”. E non è questa la medesima attenzione che conferiamo agli idoli feticci? Davvero l’unico modo per essere “Dei” è quello di farsi intubare ad una macchina?
E mentre “muoio in eterno” in questa – condizione durevole di potenziale cadavere – mi scopro impossibilitato a capire se sia effettivamente io a guardare la tragedia che mi porto addosso o “siano gli occhi di un altro con le sue insaziabili aspettative di vita” a vedere al posto mio. È assurdo, ma mentre sto qui a raccontare del “mio falso incidente” non posso che sentirmi escluso dall’essere e dal non-essere incapace come sono di rivendicarne la benché minima responsabilità.
Non era esattamente questa la mia idea di “mondo comune” con i suoi molteplici punti di vista e possibilità. E io che credevo di essere presente sulla scena del mondo come persona unica e indivisibile. E invece mi trovo sprofondato in un abisso temporale tra un passato che non passa e un futuro che non c’è. È strano ma non ho paura, né speranza. Perché non mi aspetto nulla, e nulla attendo. E perché dovrei avere aspettative? Non ho benefici da perseguire, né situazioni pericolose da evitare. Persino l’attesa può essere una scelta, dal momento che si sceglie di aspettare qualcosa che si desidera. Sono un semplice organismo, anzi un organo senza volontà e senza tempo.
In questa totale atrofia dell’azione non mi resta che il maledetto pensiero totalmente avulso da tutte le altre attività così fondamentali nel cimento del vivere e nella prova ancora più grave del sopravvivere.
Pensare dovrebbe essere come distillare gocce di vita vera. Io invece mi limito a ricordare. I ricordi mi isolano nel pensiero e non so nemmeno dove sono in realtà e che ci faccio qui. In questo dialogo dell’Io rivolto a sé nel silenzio di una dimensione individuale, il pensiero diventa azione senza scopo, fine in sé. Ecco servita l’unica condizione in cui l’astrazione pura non ha alcuna ricaduta nella realtà fattuale. Bisogna trovarsi proprio in una terra di mezzo quella dove occorre essere davvero quasi-cadaveri per esperirla.
E mi consumo in questo confine tra i vivi e i morti, in questa sorta di “zona” anestetica dell’esistenza mentre spero di potermi assicurare ancora, paradossalmente, una“possibilità di azione”. Guardatemi mentre giaccio sdraiato su questo letto: non illudetevi sono già l’immagine stessa della morte, un essere “al limite” tra la simbolizzazione e il margine non simbolizzabile della vita. Sono nient’altro che l’ “istinto di morte”, lo “stigma del nulla distinto da ogni altro significato” dove l’unica legge che vige è quella categorica, assoluta, incondizionata della “coazione a ripetere”.
Il mio volto non avrà pure una bella cera, ma esso è la maschera dello sgomento di fronte al “nulla” che mi si prospetta ogni momento dinnanzi agli occhi. O se vi pare, l’espressione dell’incanto che precede l’istante prima del “deserto” quando l’Io cede il posto non al non-essere ma al “désêtre”, il “dis-essere”, forse. O meglio un essere di pura presenza e autoidentità, un mero ente che esclude l’alterità e ha l’unico carattere dell’utilizzabilità tipica degli oggetti. In questo stato di narcosi sperimento la mia più propria e più opprimente insussistenza. In questo luogo fuor di scena, in cui sono escluso da qualsiasi azione, degli arti artificiali, sorta di protesi corporea, realizzano una controfigura di me stesso e celebrano in sommo grado lo spettacolo della desolazione di una “presenza-assenza”. Ma in questo stesso luogo in cui si rappresenta questa recita dell’assurdo provo anche a rit-essere le trame della mia storia col desiderio ancora di ripensare l’idea di una libertà che non va mai data per scontata, ma che ha tutto il sapore del successo che bisogna guadagnarsi ogni giorno.
Qui i casi sono due: o sto facendo l’estrema esperienza dell’anima che mi porterà a salire fino al limite accecante del sacro oppure sto franando nel baratro turbinoso della dannazione eterna. Ma qui la faccenda rischia di diventare squisitamente religiosa, quindi metafisica, e vorrei invece fuggire questo estremo, al momento.
Non sono né vivo, né morto, dunque. “Coesistenza” o se vi pare “simultaneità” oppure “coappartenenza” di ciò che “è” e della sua negazione. Sono “insieme”, “tutti e due insieme”. Sono il “punto”, – un punto che si nega da se stesso rapportandosi a sé -. Sono la “virgola”, “due punti”, “punto e virgola”, “tutto in una volta”. Sono “l’intestazione autonoma…della lettera” di Totò, Peppino e la malafemmina. Sono tutti e tre “nello stesso tempo” (in questo territorio persino l’appartenenza di genere sfuma grandemente). Non c’è un principio di tempo, né di spazio, al massimo – uno spazio che non occupa spazio in questo luogo che non ha luogo -, in questo campo d’inesistenza dove faccio brutalmente esperienza di una non padronanza. Alla resa dei conti, sono – un’aporia esistente – insormontabile che diviene un’esperienza interminabile all’interno della quale sono costretto a persistere.
Amico mio, sei davvero un bel problema! Una vera rogna, ammettiamolo! Non direi nemmeno esattamente un “problema” perché messa in questi termini non c’è una soluzione a meno che – stazionare in uno stato perenne di morte latente – non sia esso stesso il rimedio. Semmai il problema sta nell’aver superato la linea che delimita la morte stessa. Insomma, qui morire, propriamente dicendo, è impossibile, è proibito finanche. E si riafferma la necessità decisa dalle più alte autorità di rimanere sempre all’interno di quest’aporia, condannati a fare esperienza della linea del confine quello in cui – il possibile e l’impossibile sono temporalmente congiunti -. Questi giudici e tutta l’eletta schiera di benpensanti al seguito indulgono secondo me un po’ troppo al pensiero astratto dimenticando che qui c’è una persona in carne e sangue precipitata nella trappola della mera imposizione di “principi generali” che sconfina però di fatto nell’abuso individuale; e oltremodo degenera nella “superstizione” popolare di un mondo descritto semplicemente dall’idea dell’esistenza di un’unica realtà. Non rendiamo un buon servigio a nessuno nel ridurre il soggettivo nell’oggettivo, il particolare nel generale.
Ma mi e vi chiedo: non sarebbe più etico, ma oserei dire semplicemente più umano, progettare il superamento definitivo del confine? Capite bene la perversione? L’ “aporia temporale della non-morte” diviene in realtà il luogo della tortura dell’impossibilità di ogni movimento. Essa evidenzia il non saper dovere andare, cosa dover fare, ma in tal modo «mi ritrovo nelle vesti di un oggetto esibito, ostentato, senza alcuna tutela, inerme, indifeso. Nemmeno uno straccio di cooperazione da parte di chicchessia. Sono solo nella mia insostituibile unicità, coadiuvato unicamente da protesi meccaniche e bio-mediche.
Uhm! Vediamo. Posso considerarmi un paziente “terminale”? Seppure non si capisce come possa essere considerato “terminale” uno che può essere tenuto “in vita” ad oltranza da una macchina. È proprio il concetto di “terminale” che viene ad essere messo in discussione dalle nuove tecnologie mediche che consentono l’ “esistenza” al di là di qualsiasi minima capacità di “autodeterminazione”.
Vorrei insistere sulla questione non marginale della mia temporalità. Qual è esattamente? Uno “scherzo” del tempo, forse, senza vivacità. E una vita è sfregiata per sempre; e vivo un paradosso se non proprio “volgare”, ma sicuramente piuttosto primitivo, oso chiamarlo, e alquanto indecifrabile in quanto la mia temporalità sfugge sì, ma soltanto nel passato. Un tempo così inteso non può essere definito esattamente “il presente”, l’ora. A meno che non vogliamo chiamarlo “volgarmente”: “presente che fugge nel passato”. Che mi appare immediatamente piuttosto banale come definizione. Ma allora che diamine sto realizzando? Forse sto vivendo ciò che chiamano la pura “essenza”? Il “Puro niente”, l’ “Assolutamente negativo”, il “Pienamente indeterminato” e via discorrendo. C…o! Siamo alla follia autoreferenziale e panlinguistica costretto come sono a chiudermi in me stesso. È proprio vero che quando ti ritrovi con le spalle al muro non ti resta che affidarti all’onnipotenza del delirio metafisico. Ma non fraintendete! È soltanto che ho la sensazione di qualcosa o qualcuno “bloccato” che “non diviene nel tempo”. È una sensazione dettata anche dall’immobilità propriamente motoria, da questa “impotenza motrice” cui sono obbligato?
Io volgo a voi il mio sguardo. E voi distogliete il vostro. Non siete granché come specchi, ammettiamolo. Anzi siete proprio uno “specchio” sfrangiato, “incrinato”, di fronte al quale il mio Io – si precipita in una forma primordiale -. In questa immagine che nasce nell’impedimento del movimento e del controllo dei miei gesti che mi sono negati, mi alieno totalmente. Altro che miraggio di completezza o illusione di unità. Qui si dà il caso che mi riconosco e mi identifico soltanto nell’immagine spezzata di un “corpo frammentato” che testimonia soltanto del fatto che sono in balia vostra e della mia “inibizione motoria”. Vogliamo discutere di questa vulnerabilità e di come tutelarla? Qualcuno vorrà interrompere questo “desertico” dialogo interiore?
Vorrà intervenire? Vorrà “parlare” finalmente? Sto precipitando di nuovo dentro gli argini “dell’essere dell’indistinto godimento”. Ma quale godimento? Le parole sono importanti! Bisogna usarle con parsimonia. E qui c’è veramente poco da divertirsi.
Mi piacerebbe credere che sto regredendo all’infanzia, in fin dei conti, proprio come il “curioso Benjamin Button” che corre l’esistenza in una prospettiva a ritroso. Ma sinceramente non riesco a farmi incantare tanto da un personaggio così vacuo e fatuo che – si lascia agire più che agire in prima persona -. Che è poi la mia storia! Ops! Mai amato quel film! L’ “involuzione” compassionevole e favolistica della – cenere che diventa legna -. Che follia. Proprio non mi si addice.
Notate l’ambiguità: la mia temporalità non coincide con la presenza piena dell’essere, cioè quella presenza che tende verso un atto, ma non coincide nemmeno col non-essere. Sono una presenza non completamente negata, ma che in compenso rivela tutti i limiti che la realizzano. In questo perenne rimando alla presenza e all’assenza e nel suo continuo slittare tra queste due alternative, faccio “prove di immortalità”. O dovrei chiamarli meglio “esperimenti di morte”? Sono una cavia addetta a testare la bontà di questi nuovi portentosi macchinari: una macchina per respirare, una per pisciare e via dicendo; una flebo per il dolore, una pillola per l’umore e altri mezzi chimici di ultima generazione per alleviare la fatica dell’ “esistenza”. Ma una macchina che pensi anche per te? Cui trasferire tutti i pensieri? Questi ultimi pesanti scampoli di una vita in graduale sparizione. No, quella proprio non l’hanno ancora inventata. Eppure sarebbe della più grande rilevanza per sopportare certo supplizio. Fare il mostro del dottor Frankenstein non era la mia massima aspirazione. Ben altri ruoli mi attendevo. E tuttavia, – Potrebbe esser peggio…Potrebbe piovere – dentro questa stanza. È proprio vero che – l’impossibilità di curare i malati sfocia nel tentativo molto “onnipotente” di “resuscitare i morti” -.
O forse parlare della morte è il nostro solo modo di prepararci ad essa? O di subirne tutta l’angoscia, forse, anche. Meglio allora smettere di parlarne? Meglio smettere di pensarla. Meglio smettere di nominarla. È il solo modo che abbiamo di dominarla, forse. E come posso smettere di pensare in questa situazione? E poi l’uomo pensa con le parole. I nostri pensieri sono costituiti da parole. Visualizzate un pensiero che esce dalla vostra testa e vedrete una sfilza di lettere e numeri che riempiono un condominio intero. Non si scappa. E poi non è che se smetto di nominarla il concetto di morte si estingue e scompare magicamente dal mio orizzonte o la morte verrà spazzata via nell’oblio e finanche svanirà dal mondo. Potrei allora esercitarmi a nominarla in diverse lingue anche se la mia conoscenza delle lingue straniere si riduce all’inglese molto scolastico come da curriculum. Così per gioco. Tanto ormai io e la morte siamo in confidenza siamo tutt’uno proprio strutturalmente fin dalla nascita, direi, e allora posso permettermi di canzonarla un po’. E poi non è forse la mia una condizione di immortalità in fondo? Potrei andare avanti così all’infinito. Da buon semidio posso tutto. – E allora… death, Tod, Mort, Frånfälle, Muerte, Dood, śmierć, Smrt, Tanatos, Maut…e bla bla bla -. Vi invito ad aggiungere altre traduzioni se credete. Effettivamente a forza di ripetere ossessivamente una parola e in lingue diverse pure, essa perde di significato, diventa straniante, inverosimile, assurda persino. Interessante la traduzione in lingua swahili di “morte” che fa “Kifo” che ricorda vagamente il suono della parola italiana “schifo” che la dice lunga probabilmente su ciò che molti africani pensano di questa eventualità estrema così poco metafisica e così tanto concreta da quelle parti e per ovvie ragioni. Ma questa è un’altra storia.
Sto divagando, lo ammetto, ma in qualche modo la leggerezza di certe espressioni mi serve per alleggerire la gravosità della situazione. Non crediate che una persona chiamata a sostenere certe scelte “al limite” sia sempre necessariamente crucciata. Più spesso, forse, sdegnata e indignata.
Dunque, dicevo. Posso ricordare il passato che in realtà non è mai trascorso come se fosse ancora presente, ma non posso anticipare il futuro e pensarlo o immaginarlo. È questo che mi rode di più. Non vedo l’avvenire, vedo soltanto il maledetto passato. Neanche avessi gli occhi dietro la schiena. Ma non potrei neanche chiamarli “ricordi” veri e propri i miei. Mi è rimasto forse il “ricordo” sì, ma quello nudo e crudo di un vissuto che tende a ripresentarsi per intero nella sua forma originale. Il ricordo di un passato percepito nel presente nello stesso identico modo in cui lo avevo vissuto. Una sorta di ricordo “essenziale”, primigenio, un vero e proprio vivido e brutale e crudele prolungamento della percezione presente con tutta la malvagia aggressività del fatto in sé percepito ancora e ancora sulla propria pelle; senza intercessione, né ricomposizione tipiche del tempo che scorre, senza quell’opera benemerita di ri-elaborazione propria della memoria.
La mera “esistenza” come una morte differita? Quale futuro può esserci in una condizione in cui è assente un qualunque atto della volontà personale? È l’atto di volontà che crea scopi, che determina l’idea di una possibilità, che innesca il futuro. E io qui vivo invece unicamente una condizione di straordinaria indeterminatezza, ma senza una prospettiva. In questa dimensione non percepisco il senso del fluire temporale, ma soltanto il suo arresto. Passato e futuro sono rimasti inchiodati in uno spazio non più umano privo di realtà spaziale e intangibile. E mi scopro sopra pensiero con lo sguardo fisso su un punto, ma non contemplo alcun oggetto. Tutti gli oggetti intorno a me hanno perso il loro valore di realtà. Rimane soltanto l’esistenza qui e ora del “come-se”.
In questo non-luogo molto intimo in cui il tempo sembra sospeso e il linguaggio è assente domina un silenzio foriero di vaghe intuizioni o meglio c’è una “voce” (un suono) ma non potrei dire che è la mia. È una voce intermittente, piena di lacune, va e viene. Forse suoni o soltanto le loro immagini che giungono stinti dal mondo?
Ci sarà pur un limite all’espressione dei pensieri? Proviamo a spiegarci! – L’atto valutativo di una coscienza – è assente, colgo soltanto agghiaccianti impressioni passive. La coscienza di un’impressione è una contraddizione in termini, forse. Quando – si è coscienti di qualcosa di cui non dovremmo aver coscienza di essere coscienti -. Insomma, è tutto sottosopra. È così che l’impressione finisce per risolversi nell’orribile – scheletro esadecimale di un atto di coscienza -. E allora succede che l’immagine si riduce a “semplici qualità cromatiche della cosa fisica”. Neanche la notte e il giorno esistono più, non ci sono che variazioni della luce.E allora anche le parole finiscono per apparirti soltanto come sfilze di orripilanti Hashtag: sequenze terrificanti di caratteri alfanumerici senza spazi, senza senso apparente si susseguono frenetici davanti ai miei occhi, dentro la mia testa, sorta di hiragana in corsivo; mere attualità di cui non hai propriamente coscienza, ma di cui sei solo passivamente consapevole; pura “passività in atto”, dunque. E nemmeno le libere associazioni di idee ti sono concesse, ma soltanto obbligati collegamenti ipertestuali mi scorrono nella mente, processi di modularizzazione delle idee schematizzate da grafi e nodi e domini. Un vissuto di disorientamento e sovraccarico mi opprime. Questo è il risultato dell’essermi consumato gli occhi e il cervello davanti al computer, verosimilmente. E non so più a che punto della vita mi trovo e come raggiungere un altro punto di essa. Il pensiero al tempo del World Wide Web. Oppure è soltanto che l’immagine disgregata del mio corpo mi impedisce di cogliere l’unità degli oggetti che percepisco?
In questo territorio paradossalmente fuori dal tempo e dallo spazio sembra non accadere nulla; eppure ho l’impressione che la vita abbia cominciato a girare su stessa come in uno smisurato putiferio. Forse è col mio “fantasma” che sto venendo a contatto? Gli altri hanno gli angeli custodi che li preservano dalla crudezza della vita io ci ho i “fantasmi” che mi marcano a vista. Intendiamoci, non che mi lamenti di ‘sto fantasma qua. Anzi! Che sia benedetto. Forse è l’unica cosa che mi procura ancora un po’ di piacere. Potrei viverci per sempre col mio fantasma anche se la prospettiva non mi alletta granché e mi vergogno persino un po’ di come sono adesso. Sono i sintomi che proprio non riesco a digerire. I sintomi sono meccanici, sono stupidi, senz’anima e tuttavia sono costretto a subirne tutto il tormento. Seppure nei sintomi si consuma anche tutto il conflitto interiore che vivo tra pulsioni e pensieri incongruenti. Ma questi sintomi come conseguenze dirette del vivere mi pongono già di per sé al di là della vita stessa e diventano unici testimoni di un’esistenza che semplicemente accade nel suo ripetersi ininterrotto e senza scopo.
Nel frattempo non mi rimane che perdermi nell’anestesia dell’astrazione ad oltranza”. Aiutato in questo anche dai vostri palliativi per la coscienza. Forse sto soltanto vivendo un’illusione creata dalla chimica. Forse pensavano con questi palliativi di ricompensarmi dandomi un accesso diretto ad un’altra vita-stupefacente. Una dimensione incantatoria dove il domani non avrà mai inizio e forse tutto resterà così com’è. Altro che morfina qui mi avranno somministrato qualche acido strano se sto qui a confrontarmi con i draghi del pensiero. Che geni! La vostra “cura” ad ampio spettro ha fatto di me un tossicodipendente. Meglio tossico che defunto, quindi.
Mettiti in ascolto del mondo, mi dicono e tutto ti sarà più chiaro. E qual è la melodia che mi giunge da questo mondo? Immaginate una “monodia” a nota unica. Anzi no! Meglio renderebbe l’idea la musica “acusmatica” composta da una sola nota granulosa, farraginosa, stridente; accordi stonati di saxofono fatiscente che suona un’unica nota strampalata, un unico ossessivo suono acuminato, straziante, ma con mille variazioni che viene trattenuto, ma non allo scopo di estendere in avanti la percezione musicale, ma solo per poter iniziare ogni volta da capo dallo stesso punto-suono dove tutto accade – nel presente di una sonorità cacofonica sempre attuale -. E il presente si allarga sì, ma perennemente all’indietro verso il “prima”; come avere il braccio di un vecchio grammofono impiantato nel cervello che graffia continuamente all’indietro con la sua punta di diamante sempre sullo stesso istante, sempre sullo stesso punto della corteccia fino a scavare un solco lancinante giù in profondità dove l’ippocampo è intento alacremente a risvegliare in un circolo senza fine il circuito hebbiano delle sinapsi addette all’immagazzinamento di quell’orribile esperienza e soltanto di quella. Insomma, una vera orripilante sensazione fisica, una sorta di “realtà aumentata” del dolore umano. Mi viene da pensare a quell’indemoniato di Coltrane. Ma che centra? Nemmeno lui con la sua mistica ispirazione ci potrebbe trarre granché da una nota così stonata. Non il brivido fortissimo e contagioso dell’assoluto “sheet of sound”, ma il circolo opprimente e scellerato della musica raffazzonata spacciata per jazz modale, eventualmente. Ma tu guarda se in una situazione del genere debbo mettermi a pensare a Coltrane in coppia con Thelonious Monk che suonano “Crepuscule with Nellie”. Forse gli ultimi scampoli di un Io in progressiva dissolvenza. Una – dissolvenza in chiusura – come in “Interiors” in cui lo stratagemma accresce la malinconia di un epilogo che comunque rimane aperto. O così mi piace credere. Il guaio è che sempre più spesso la dissolvenza che mi balena per la mente è quella più raccapricciante di certe sequenze mute di “Un chien andalou”. E non è surreale oggettivamente tutta questa faccenda? Forse non è così strano che proprio la “dissolvenza” dei film del cinema muto mi baleni, lì dove la vita sembra effettivamente scorrere “muta” in cui l’Altro non ha parola. Ecco la faccia triste di Buster Keaton mentre costruisce la sua “casa sbilenca in una settimana”, parodia antelitteram è un po’ nevrotica forse del fai da te di certi prodotti IKEA. O il volto più esuberante dello scavezzacollo Harold Lloyd “sospeso alla lancetta dell’orologio di un grattacielo”. Luoghi dove la logica è messa a dura prova dove non si pongono più questioni, né contrasti. E i capovolgimenti di senso si susseguono incessanti. E gli oggetti mutano di significato o non ne hanno uno proprio; e gli atti più elementari diventano macchinosi e contorti e le azioni più assurde diventano improvvisamente perfettamente plausibili e dove persino le sventure si annunciano come aiuti inattesi. E la morte stessa diventa insieme sventura e benedizione. In questo mondo oltremodo astratto, surreale, è difficile giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
Non potete pretendere di comprendere la mia azione perché essa semplicemente non si lascia afferrare. O forse più semplicemente non trovo metafore, né parole abbastanza efficaci da proporre per descrivere la condizione in cui mi trovo. Ed è per questo forse che gli altri fanno fatica a capire la mia volontà.
Ma forse in questo stato di isolamento in cui verso le parole non servono. La parola qui subisce davvero uno scacco inesorabile. Forse alle parole dovrei opporre non il silenzio, ma più semplicemente un grido. Non il grido energico dell’uomo rabbioso, ma quello più svigorito di un uomo adulto ormai stremato. Quando rimani escluso persino dalle parole il grido diventa il referente estremo del dolore irrinunciabile. Quando cioè nulla si può più scandire se non – quel nulla assordante, “doloroso”, dichiarato che annichilisce la parola stessa -.
Ma poi servirebbe a qualcosa mettersi ad urlare? Ammesso che uno abbia ancora fiato in gola. Non credo servirebbe a farmi ascoltare di più. Persino il grido, in questo luogo in cui finanche la parola “diserta”, diventa la frase di un signor nessuno. Il mesto richiamo dell’indifferenza fra l’istinto, la ragione e il sentimento.
Non vi servirebbe neanche sapere ciò che mi manca o mi è mancato o perché sia andata così. C’è sicuramente una trasformazione in atto, e i modi di cogliere e vivere i cambiamenti di ciascuna vita sono particolari e soggettivi. E io soltanto sono titolare della comprensione di me stesso e delle mie esperienze. Non è riservatezza la mia. È solo che la vita è – una messa in scena che deve svolgersi a sipario chiuso -. E nemmeno è tanto igienico sbirciare dietro le quinte del teatro. Finirebbe il divertimento una volta scoperto che dietro la sublime poesia si nascondono soltanto muri in cemento armato e altre “strutture di servizio”. Ancora più angosciante sarebbe scoprire che dietro le quinte del teatro non c’è nulla; più niente da vedere, più niente da sapere, più niente da desiderare. E nemmeno l’ombra di un scalcinato suggeritore che velatamente ti consiglia cosa fare, come pensare, come vestire, cosa dire, cosa comprare. Non dico che ho nostalgia dei “consigli per gli acquisti”, ma faceva parte del “vivere” e avevo comunque modo di fuggire certa insulsaggine. Il dolore assoluto, incondizionato, indicibile ha questo di brutto che disvela il vuoto di scena che dietro la vita si cela -. L’opera della vita sarebbe meglio non avesse spettatori. Meglio sarebbe che vi fossero soltanto – persone che si cimentano nel vivere -.
Allora io non vi chiedo di mettervi nei miei panni. Non vi chiedo di comprendere. L’atto del “comprendere” può essere vissuto effettivamente come una sorta di complicità con individui e azioni che non possiamo approvare fino in fondo. Questo lo capisco e lo rispetto. Allora l’unica cosa che posso domandarvi è di avere totale fiducia nella mia azione, fiducia in ciò che di più umano è rimasto in me. O se proprio non riuscite laicamente a fidarvi di me potete sempre provare a “perdonarmi” come estremo atto di riconciliazione. Pensateci bene! Io vi do l’opportunità di rimanere in pace con la vostra coscienza, non vi priverò della vostra purezza. Il perdono è un meccanismo unilaterale e si fonda su uno stato di disuguaglianza per cui c’è nella relazione un superiore e un inferiore che “necessita della vostra graziosa indulgenza”. Ciò vi consentirà di accettare formalmente la soluzione finale di colui che ha “scelto di smettere di esistere” e contemporaneamente di non condividere affatto la sua azione consentendovi di sentirvi se non propriamente “buoni”, almeno perbene. Come compromesso è accettabile?
Tuttavia, bando ad ogni sentimentalismo! Non è pietà, né carità che cerco, ma pretendo il vostro “riconoscimento”. Almeno questo rientra ancora nell’orizzonte possibile della mia volontà? Allora, sforzatevi di “parlarmi” ancora, provate a vedermi ancora come persona umana, cioè come potenza capace ancora di agire. Capisco che messa in questi termini la libertà di scelta può apparire una roba un po’ ingenua, una cosa da romanticoni sfegatati. Viene un momento in cui la libertà di scelta, lo ammetto, tende ad avere il sopravvento su chi la persegue al punto da farne l’unica ragione per vivere o per morire.
E tuttavia, in questa prospettiva, persino eutanasia e suicidio assistito si possono “comprendere” se guardiamo ad esse come “inizio”, come una nuova possibilità di agire. Ma non è paradossale e lo è di fatto trasformare – un atto finale nell’inizio di qualcosa che si rivelerà una fine? -. Ma l’alternativa quale sarebbe? Sperimentare in eterno quella specie di territorio narcotizzato in cui si manifesta il dolore irrinunciabile della coazione a ripetere? A questo deve ridursi la vita? Ad un rituale futile? Dove tutto è – determinato una volta per tutte – e non ci sono possibilità da sperimentare, né opportunità da cogliere, ma soltanto la speculazione sterile – quella peste del pensiero che imbriglia l’azione? –. E allora, vivo questo tempo, ben sapendo che non arriverà un tempo a venire, ma attendendo una continua ripetizione dello stesso. Proprio come in “Groundhog Day” in cui Phil Connors (Murray) si ritrova immerso in un loop temporale che gli fa rivivere all’infinito lo stesso giorno che si trasformerà presto in un inferno. E per uscirne il solo modo sarebbe quello di cambiare qualcosa nella catena di questi eventi sempre identici. E quali azioni mi sono date? Le azioni che posso compiere non avrebbero conseguenze alcuna. Domani mi risveglierò nello stesso posto, sullo stesso letto e senza dover rendere conto a nessuno, se non alla mia coscienza. Una vera pacchia! Dovrei trovare un modo per utilizzare al meglio tutto il tempo che ho a disposizione. E il tempo non mi manca, a quanto pare. Qual è il giusto criterio per valutare la qualità di una vita e il dovere che si ha verso di essa?
Come poter spiegare il concetto che persino la morte può trasformarsi in una “possibilità”? La possibilità che qualcosa possa ancora succedere? La morte stessa esprime persino l’idea della mia – capacità come possibilità decisionale -. Seppure l’unica decisione che mi competa sia unicamente quella di morire o semplicemente esistere.
Eppure mi dicono che si può anche non volere ciò che si vuole. Giustissimo! Ma potrei davvero poi dare un nome esatto a quello che voglio? E davvero non voglio quello che non voglio? E persino questo maledetto dubbio poi: È mio persino il dubbio o mi è stato inoculato da Altri-da-me? Il dubbio che dubita di se stesso. Ma in che razza di “zona” sono finito? Un territorio desolato, dove le normali leggi della natura del tempo e dello spazio non valgono più. E dove nemmeno i “desideri più intimi e segreti” si avverano. Se solo potessi ancora credere in qualcosa. Qualcosa per cui valesse ancora la pena di “vivere”. Davvero difficile in una situazione in cui l’unica azione che mi è concessa è quella di “viaggiarmela” nel subconscio.
Oppure, questa è una “fantasia di morte”, frutto della mia immaginazione malata, risultato del dolore in cui l’esperienza mi ha fatto precipitare o il tranello del demonio che vuole indurmi nel peccato? Raga, di questo passo non se ne esce. Credetemi! Allora, meglio appellarsi alla libertà che si qualifica come “ciò che imprime possibilità”. La libertà pone come proprio centro il potenziale della scelta e si manifesta come possibilità di agire scegliendo qualcosa che può anche non essere giudicato per tante ragioni oggetto di scelta. Come “scegliere di morire” ad esempio.
Secondo me si aborrisce proprio l’idea che si possa “procurare, in maniera intenzionale e nel suo interesse, la morte di un individuo anche e soprattutto, poi, quando la qualità della sua vita sia compromessa in modo permanente da una condizione o malessere di tipo psichico/psicologico”. E invece, secondo me, è un bene che si inizi a parlare non soltanto di condizioni mediche in cui il paziente soffre di una malattia (organica) o una menomazione “gravi” ed irreversibili. Certo è vero che a primo acchito in “una condizione o malessere di tipo esclusivamente psichico/psicologico”, la nozione di “scelta” individuale sembrerebbe ammettere una maggiore possibilità di azioni alternative; cioè nell’immaginario collettivo, quantomeno, sembra meno “obbligata” rispetto alla “scelta” operata in una situazione in cui è presente una malattia ad esempio degenerativa del sistema nervoso come la “SLA”. Si può persino dubitare legittimamente più in generale che l’azione di “darsi la morte” rientri nel campo della “scelta” individuale intenzionale, cioè programmata, e dunque razionale, presa ad esempio fra alcune alternative possibili. La “scelta” implica “l’essere liberi”: e dove sta la libertà se l’alternativa qui è tra morire o semplicemente “esistere”? “Azioni” queste ultime che sono o dovrebbero essere oltretutto di per sé incompatibili tra loro. In sostanza, qui si ammette che l’azione effettivamente eseguita di “procurarsi una dolce morte” sia in realtà determinata in base ad un principio diverso dalla “scelta”: ad esempio, in un modo dettato dall’impulsività o per imposizione della situazione in cui ci muoviamo. Dunque, qui si dubita che esista una reale “libertà di scelta” e si afferma sostanzialmente che vige solo un principio di causa-effetto. Tuttavia, in questa analisi della “scelta” di “darsi la morte” non dovrebbero essere tanto in gioco le condizioni “oggettive”, ma dovrebbero pesare soprattutto in questo contesto le condizioni psicologiche individuali e quelle sociali che definiscono l’azione dello “scegliere”.
Qui il punto non è la libertà in senso astratto, ideale, ma piuttosto stiamo discutendo della libertà, come attività, come qualcosa che si “sforza” di essere “atto”: la libertà come possibilità di dare corpo ad un nuovo Inizio. L’inizio – protende l’Io ad autoporsi come atto ulteriore e necessario – rispetto a quello più semplicemente e sterilmente riflessivo. Anche se questo atto mi dovesse sospingere verso qualcosa che “non sarà più”. Anche se questa scelta dovesse significare cessare di esistere. Anche se questo volesse dire alienarsi al prezzo del mio essere. E in questo rinnovato sforzo di esercitare un nuovo “inizio” trovo uno scopo. E finalmente mi riconosco di nuovo umano profondamente legato ad un destino comune e infine in pace con l’umanità intera. Insomma, preferisco affrontare l’ignoto del non-essere, piuttosto che rassegnarmi al martirio indeterminato dell’essere.
Ma l’esistenza di per sé è questione piuttosto banale. Tutto ciò fa parte forse della strategia di uno in preda ad un qualche delirio narcisistico di onnipotenza? Ciò sarebbe di per sé sufficiente a negare questa strabenedetta “autorizzazione a procedere per le morte” per fondato sospetto quantomeno della presenza di un vizio di mente seppure parziale. E tuttavia, questo volersi spogliare di ogni “più vile altra materia insieme a quella più nobile”, non è necessariamente l’espressione dell’insania tipica di colui che vuole porsi come un dio, ma più modestamente e meno patologicamente, forse, come l’aspirazione naturale degli esseri umani a trascendere i propri limiti. Ma se fosse la “vita” stessa a diventare un limite, poi? La vita è la constatazione di una magnifica ossessione e della sua irrealizzabilità: la ricerca della perfezione. E fin qui possiamo concordare tutti. Vi dirò anche, se può essere utile, che non ho mai avuto particolari pretese, né aspettative irrealistiche. Un umano piuttosto banale se volete o meglio un individuo piuttosto “pratico”. Ho invece maturato presto e sulla mia pelle la consapevolezza dell’irraggiungibilità di una fine compiuta. Diciamo che ero nel posto sbagliato nel momento più sbagliato ancora. Ma ho vissuto comunque. E non credo di poter far meglio a questo punto. Lo accetto se non proprio col sorriso, ma almeno senza frustrazioni particolari.
E nemmeno dovete fraintendere l’“inizio” che voglio praticare come un percorso a ritroso fino ad una sorta di “preistoria della coscienza”. Non si tratta di ritornare ad una mitica fase presimbolica. Vedo più prosaicamente la mia situazione come l’ennesimo ostacolo da superare. In questo senso la scelta di interrompere la mia esistenza assurge in qualche maniera ad atto profondamente morale persino in quanto mira a recuperare la pura attività originaria dell’ – Io finito – quello di una persona reale, necessariamente pratica che agisce in quanto tale nel mondo. Consideratelo una sorta di – dovere – che ho verso me stesso prima di tutto: Io – devo – farlo! Non so come dire. Sembra che debba rendere conto soltanto a me stesso. Ma è proprio così vero che una persona che si fa aiutare a morire sta semplicemente esercitando il diritto di “mettersi a repentaglio e di essere irresponsabile verso la propria vita? La decisione di porre fine ad una vita umana avviene in maniera asettica, dunque? O tutto ciò che vive, non vive solo per se stesso e la “scelta” di morire si ripercuote inevitabilmente sulle regole morali dell’umanità intera? La vita è sorretta da rapporti strutturali persino quando ha perso ogni altro significato e ogni altro scopo? E tuttavia, – quanta «umanità» sono in grado di concepire? Sinceramente, io sento di poter avere a che fare, tendenzialmente, con un essere umano alla volta. L’ “esser-ci” umano (il Dasein) si costituisce a partire da un lutto originario che accoglie l’altro da sé dentro di sé da sempre, è stato detto. La questione della morte, quindi, è limitata dalla questione dell’altro poiché la mia morte è la morte dell’altro? Ma non sia mai! Non voglio mica fare come Amleto emblema dell’aspirante suicida “irrazionale” con problemi esclusivamente psicologici/esistenziali e oltremodo solo di fronte alla morte. Con la trascurabile differenza però che per raggiungere lo scopo organizzò una carneficina. Come nuovo “inizio” è piuttosto discutibile. E tuttavia, l’uomo pur sottoposto alle relative limitazioni, è anche in grado di trascendere il mondo con un – atto di libertà -, facendone il progetto di atteggiamenti e azioni possibili.
Dubbi, contraddizioni, aporie. Tutto regolare alla fin fine. Forse che nella vita abbiamo delle certezze? Chi può affermare con sicurezza quando morirà? Quanto vivrà? Come sarà vissuto? In questo senso stai vivendo il risvolto più essenziale della vita stessa. Dunque, stai pur sempre vivendo e non semplicemente esistendo. E allo sfottò metafisico doveva condurci tutta questa splendida metariflessione, alla fine? L’Io che sfancula l’Io. La mente intenta a supercazzolare sé medesima. Parodia di me stesso. – Raccapriccio di pensieri inutili che pretendono di andare oltre i confini della mente – e che per questo finiscono per diventare inutilizzabili. Era inevitabile, forse, visto questo dialogo interiore forzoso tra me e me stesso.
È vero, la nascita è sacra, è una possibilità che ci è stata data. E non state qui a rinfacciarmelo continuamente, vi prego. L’inizio “incondizionato” della nascita non richiede alcuna volontà del soggetto coinvolto nell’atto del nascere. La morte invece si dà il caso che possa essere in qualche modo, in qualche circostanza pilotata dal soggetto che la può reclamare finanche per se stesso/a. È paradossale in apparenza, ma per desiderare di morire bisogna pur sempre aver vissuto prima. Ma questo cosa vorrebbe dire? Forse più semplicemente questo implica che una volta che un nuovo individuo ha la ventura di comparire su questa terra e accumula conoscenze e pensieri e intenzioni, e desideri e diritti e doveri, la sacralità di quella possibilità iniziale, originaria si trasforma in vita che appartiene interamente all’uomo ed è “azione”: cioè il nuovo venuto diventa regista del proprio vivere (e persino del proprio morire, dunque) attraverso la capacità di agire, di iniziare (cose, progetti). La nascita reca in sé il fondamento della “libertà del vivere” mentre vivi.E che dire allora quando la possibilità di incominciare qualcosa, possibilità di fare, – potenza di entrare nella spazialità mondana – sono venute a mancare?
La vita di un uomo è impegnativa ed esige molto, troppo perché ci si possa limitare a nutrire la sua carne con le flebo o a mitigare le infiammazioni delle sue ossa con gli antidolorifici non steroidei. L’esistenza pura e semplice, – una fossa per i vivi -. Anche morire è faccenda troppo importante per lasciarla alla mercé del caso. Ammetto di avere ancora dentro di me due parti che si stanno contendendo caparbiamente lo scettro del comando: non tutto è così chiaro, vi assicuro.
C’è ancora una tensione dentro di me! Ma che si prefigura come una marea impetuosa ricca di memoria ancora vivida, sconvolgente. I desideri sono ormai andati. Devo soltanto svuotare completamente questo organismo da ogni bisogno, da ogni tensione. Certo questo vuole dire morte reale, “tensione all’inanimato”. Poco male. In fondo, questa morte sarebbe solamente limitata all’organismo.
E a me piace credere di essere molto di più della somma dei miei organi. La vita eccede l’organismo.Allora, “Essere” semplicemente quello che sono, rassegnarmi alle ingiunzioni della famiglia, dei giudici, dei politici ben pensanti, soddisfacendo le loro ansie di vita, accettando il posto che mi compete al momento confinato su questo letto? Oppure scegliere di “non-essere”. Ma in fondo se l’essere è l’indistinto indeterminato dove tutto tace, non-luogo del godimento della coazione a ripetere, presenza originaria sottratta, allora il non-essere diventa paradossalmente luogo del senso e della parola dell’Altro, allora è vita, è l’esser-ci, in definitiva. Qui il problema non è nemmeno essere o non essere. Il dilemma è squisitamente retorico! Perché essere “è” non-essere proprio costitutivamente. Ancora vita e morte scivolano alternativamente l’una nell’altra e viceversa in un circolo senza fine. Suprema iattura o somma speranza. Ma che ne so! Forse non ci ho capito granché e lacaniani e strutturalisti assortiti stanno sobbalzando sulla sedia. Ma abbiamo detto che questo è il tempo e lo spazio dove l’inverosimile può diventare possibile e viceversa. Concedetemi almeno che quest’area sia una piccola oasi personale di impunità. In questo stato non posso dare niente a nessuno e a nessuno posso far male o bene. Di sicuro – la morte non sarà poi così terribile se l’alternativa di “vita” che ti si prospetta è più terribile ancora -.
È strano. Ma mi sembra davvero di intrattenere una relazione immaginaria con qualcuno che non è reale. Sinceramente vi dico che questo non è un bel modo di sentirsi vivi.E mi aggiro come un “fantasma” nei meandri di me stesso. Sono io il mio “fantasma”? Uno che “non significa” più nulla, che non rimanda a nessun altro significante. C…o sono proprio al capolinea.
È in questa operazione di “scarnificazione”, di sottrazione progressiva dell’Io e dall’Io fino ad implodere nel nulla che consiste la morte? O la “scrittura”? Quando l’Io, anzi la parola “io” non esiste più e l’io scolorisce fino ad estinguersi.
È questo il mitico “Essere” di cui si straparla tanto? Quello di un uomo che per morire finalmente deve prima consumare dentro di sé tutto ciò che appartiene alla creatura, cioè il suo “mitsein”, in definitiva: – i ricordi frivoli, le parole dei libri, le impressioni, l’esperienza, gli affetti, le gioie e i dolori, tutto! Bene, allora se è così vuol dire che sto già morendo, dunque. Manca soltanto il sugello finale. Tocca a voi adesso.Uhm! Non ce la fate, vero? Ok!
Ci hanno raccontato che l’uomo non è sotto alcun vincolo. Nessuna necessità esterna lo costringe a rispondere in un modo o nell’altro. È libero. Può operare una scelta. Può cioè scegliere chi o cosa desidera diventare. Dunque, la vita non è un’istanza morale (non impone nulla); la vita è un’opportunità-necessità etica, ti lascia la possibilità di scelta, fosse anche la scelta di porre fine ad essa, nel senso che ti rende responsabile dei pensieri e delle azioni che hai deciso di mettere al servizio di questa scelta.
Sostanzialmente, sussiste credo il timore che possiamo “abituarci alla morte” che “normalmente” concepiamo o meglio ci piace concepire come qualcosa che ci viene dall’esterno. Essa deve calare per caso o per volontà divina o per fine vita “naturale”, o per consunzione progressiva o istantanea dovuta a qualche guasto organico. “Non bisogna abituarsi a morire”, dunque; cioè – non bisogna considerare la morte “normale” – neanche fosse una cosa che possiamo darci liberamente e impunemente da soli.
In questo contesto vita e morte sono concetti che hanno carattere a priori cioè formale, non derivato dall’esperienza, qualcosa di “precostituito” ed accettato senza discussione, nell’illusione che vivere e morire siano per definizione, dei “dati”, cioè delle necessità che non esigono giustificazione, né spiegazione, né fondazione. Sono soltanto “condizioni formali di possibilità” e come tali sono il fondamento che di per sé conferisce loro significato e legittimità.
Dunque, si ammettono vita e morte come cose in sé indipendentemente dal soggetto che li esperisce come sorta quasi di noumeni kantiani, dei postulati che non è possibile spiegare solo con gli strumenti della pura ragione. Noumeni perché non li possiamo conoscere fino in fondo.
Allora, – Cos’è vita? Cosa non è vita. Cos’è morte? Cosa non è morte? Che vuol dire essere-morti? Che cos’è l’esperienza della morte? –. Vita e morte non sono “fatti” dall’uomo, ma sono “dati” all’uomo. Gli scopi di quello che l’uomo non ha creato da sé non può nemmeno mutarli. Si tratta di dati naturali che a causa della loro “naturalità” costituiscono un vincolo morale.
La vita non può essere semplicemente una proprietà posseduta dagli organismi in misura variabile e quantificabile, a seconda della maggiore o minore complessità dell’organizzazione corporea, come le piante di Lamarck. La vita non può consistere semplicemente nell’espletare certe funzioni più o meno complesse. Notate che queste ultime considerazioni potrebbero essere accolte indifferentemente e paradossalmente sia dai fautori della “dolce morte” che dai loro contrari.
Di cosa voglia dire essere vivi tutti abbiamo una vaga nozione. Ma la morte come si può spiegare al di là di ciò che appare ai nostri sensi? Si dice che ciò che accomuna vita e morte sia l’idea che non possiamo mai “apprenderle” completamente. Ci sono date e questo è quanto. E ciò implicherebbe la conseguenza abbastanza ovvia a ben vedere che non abbiamo alcun potere di (sulla) vita e nemmeno di (sulla) morte, dunque. Perché la vita e la morte non ci appartengono. Bisognerebbe spiegarlo ai fautori della pena capitale, eventualmente.
Insomma, vita e morte hanno carattere originario e inderivabile. Allora, morte e vita vengono assunti come concetti scontati, ovvi e da non indagare, da non nominare neanche. Cosa ne pensi della vita? E della morte, poi? Niente! Perché dovrei pensarne qualcosa? Oltretutto porta pure iella parlarne.
Ovviamente non sto perorando alcuna etica che possa giustificare il suicidio. Ma allora qual è la mia responsabilità, alla fine? Mantenermi “vivo”? Almeno questo bastasse ad assicurarmi l’elisir dell’eterna giovinezza. Il mancato sviluppo non può essere la soluzione, né il mio desiderio finale, spero.
Testo, contesto e controtesto. Al fine di un banale chiarimento.
Persino questo stesso contenuto, la sua scrittura, può essere letto come fosse composto da un “insieme di tracce” alla resa dei conti: – si può intravedere – il tentativo di tenere insieme concetti ed espressioni che sembrano completamente distorti, privi di collegamenti, apparentemente slegati tra loro. Le tracce sono come tante fotografie che si susseguono ordinatamente seppure senza un ordine strutturato. Ognuna delle quali rimanda ad un’altra e a nessuna in particolare. La traccia (linguistica) non vuole rappresentare qualcosa per qualcuno, non funge da avvertimento o da suggerimento, non “insigna”, cioè “non fa segno” a qualcuno. Essa è un inganno simbolico nel senso che le cose dette o scritte non stanno e non vogliono stare esattamente e necessariamente nel modo in cui sono state riportate.
Sembra a tratti che io stia discutendo del testo di un altro. Mi capita di parlare in terza persona, in modo impersonale. È l’Io che si disperde tra i segni grafici in lento e progressivo distacco dalla scrittura medesima o dal tema in questione. Ogni tanto l’Io sembra materializzarsi ancora, riprende corpo, si coagula di nuovo. Il ritorno di un guerriero fragile che non sa contro chi o cosa combattere. O forse è soltanto che in fondo le citazioni abbondano e parliamo pur sempre con le parole degli altri. Non nasciamo forse in un bagno di linguaggio? Sono sempre le parole degli altri che parlano per noi. Ma forse non sono tanto importanti le parole degli altri, ma più importante ancora è dove vuoi portarle, cosa vuoi farne.
Mi sono qui ritagliato il ruolo quasi di narratore omodiegetico, adottando un punto di vista interno sebbene non dica molto di me (anche se a volte parlo in prima persona e parto da alcuni presupposti ed esprimo opinioni personali) e per l’ovvia ragione che non mi trovo al momento nella condizione di dover stabilire se ricorrere o no ad una “morte assistita”. E nemmeno posso conoscere a fondo la psicologia delle persone coinvolte realmente nella necessità di dover prendere delle decisioni così capitali per se stessi e per le loro famiglie. Ed è per questo forse che mi metto sovente a dialogare in-direttamente con il lettore trascinandolo a volte ironicamente in questo universo terribile e caotico e vagamente alienante. Tentando (o almeno questa era l’intenzione) nello stesso tempo di coinvolgerlo nello stesso processo di “formulazione di ipotesi” di una storia “significante” (o in-significante, dipende dai punti di vista) ma di sicuro “mancante” di un vero senso definito e inequivocabile.
Dunque, me ne starò qui ad “attendere” che qualcuno si metta a raccontare la sua storia o – a raccontarmi la mia -. Almeno questo mi distrarrà dai pensieri astrusi. Ma a ripensarci, non è tanto importante cosa l’altro vorrà raccontare, mi interessa di più ascoltare il suono di una voce che non “graffia”, una voce che racconta, sì, ma che non sta qui a “raccontarmela”.
O così è se vi pare! Salutandovi indistintamente e senza nulla a pretendere
– Ed è in nome della devozione che nutriva per la musica e della venerazione che sentiva per il suo strumento che smise di suonarlo. Tanto male vibrava tra le sue mani? –
Suggestioni bibliografiche
• Arendt H. La vita della mente. Il Mulino, 2009
• Arendt H. Vita Activa, Bombiani, 2012
• Barsanti G. La mappa della vita. Guida Editori. 1983
• Chiodi G. M. La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica. Franco Angeli, 2011
• Colombo A. (a cura di), I pro e i contro. Teoria e didattica dei testi argomentativi, La Nuova Italia, Firenze,1992• Derrida J. Aporie. Morire – attendersi ai ‘limiti della verità’, Milano, Bompiani, 2004
• Derrida J. Della grammatologia. Jaca Book. 1998
• Derrida J. Ousia e grammè, in Margini della filosofia, Torino, Einaudi, 1997
• Gentile A., Ai confini della ragione. La nozione di «limite» nella filosofia trascendentale di Kant, Edizioni Studium, Roma, 2003
• Habermas J. Teoria dell’agire comunicativo. Razionalità nell’azione e razionalizzazione sociale, Bologna, il Mulino, 1997
• Habermas J. Il discorso filosofico della modernità. Laterza. 1987
• Heath S. L’analisi sregolata: lettura di Roland Barthes. Dedalo. 1977
• Heidegger M., Essere e tempo, Mondadori, 2006
• Husserl E., Fantasia E Immagine, Rubbettino, 2017
• Husserl E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, 2015
• Jonas H. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. Einaudi. 2009
• Jonas H. Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità. Einaudi. 1997
• Kant I. Critica della ragion pura, Laterza, 2000.
• Lacan J. Altri scritti. Einaudi. 2013
• Perelman C. & Olbrechts-Tyteca L., Trattato dell’argomentazione – La nuova retorica, Piccola Biblioteca Einaudi, 2001
• Perissinotto L. Wittgenstein. Una guida. Feltrinelli. 2008
• Pinkard T. Hegel. Il filosofo della ragione dialettica e della storia. Hoepli. 2018
• Rhonheimer M. Legge naturale e ragione pratica: una visione tomista dell’autonomia morale. Armando Editore. 2001
• Severino E. Volontà, destino, linguaggio. Rosenberg & Sellier. 2010
• Sgalambro M., Variazioni e capricci morali, Bompiani, Milano, 2013
• Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916. Einaudi, Torino, 1979